Capitolo primo
1.1 L'insicurezza collettiva e il diritto penale del rischio. Introduzione e premessa metodologica
Dov'è finita la dolcezza? È in nome di questo principio che avviene il più epocale dei cambiamenti della storia del sistema sanzionatorio: il tramonto dei supplizi è sentito come esigenza sociale improcrastinabile a partire dalla seconda metà del XVIII secolo nella Francia rivoluzionaria, quando si palesa la necessità di punire diversamente, abolendo lo «scontro fisico del sovrano con il condannato, sciogliendo il corpo a corpo che si svolge tra la vendetta del principe e la collera contenuta nel popolo con intermediari il boia e il suppliziato» (1).
Lo scardinamento improvviso di quel connubio atroce e sanguinario, fino ad allora indissolubile, tra la violenza tirannica del re e il piacere nel veder soffrire del popolo (2), avviene paradossalmente attraverso il più mite dei sentimenti: la dolcezza. Che è poi, nella lucida ricostruzione storica foucaultiana, la naturale «necessità di un castigo senza supplizio formulata dapprincipio come un grido del cuore o della natura indignata, poiché anche nel peggiore degli assassini, una cosa almeno deve essere rispettata quando si punisce: la sua umanità» (3).
È l'uomo insomma, scevro del suo aspetto criminale, ad essere eretto a misura contro il dispotismo del patibolo, simbolizzazione materiale del Potere.
Oggi, uomini e giuristi del XXI secolo, sono chiamati a interrogarsi sul collocamento della società su tale parabola dell'umanità. Occorre constatare un arretramento (4), con conseguente ritorno al supplizio, o un avanzamento nel segno dell'umanità ?
Per tentare di dare risposta a tale quesito occorre analizzare la problematica sotto due differenti aspetti: il sociale (o comunitario) (5) e l'individuale, concentrandosi in particolare, ai fini di tale ricerca, sulle azioni criminali commesse da soggetti psicotici, fenomeno forse numericamente marginale (6) rispetto alla totalità del crimine, ma certamente più problematico e complesso da una prospettiva tanto giuridica quanto sociologica.
Non vi è l'intenzione di aggirare il quesito, anzi è impellente la volontà di darne una risposta quanto più esaustiva e sostenibile.
Esploreremo dunque i meandri reconditi di uno spazio, tanto ideale quanto materiale, che il sociologo del diritto Pierre Bourdieu definisce «campo giuridico» (7), nella sua particolare accezione di «campo giuridico del penitenziario» (8), inteso come quel «cosmo sociale costituito dall'insieme di microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica e una necessità specifiche, non riconducibili a quelle che regolano altri campi» (9).
Non uno spazio qualunque abitato solo da un sistema di regole codificate, che il giurista moderno suole definire diritto positivo, ma anche da figure professionali che rappresentano, nel linguaggio di Bourdieu, gli agenti specializzati di produzione di enunciati linguistici seri.
Ma l'oggetto della ricerca è ancora più peculiare, si intende infatti ricostruire il sotto-campo giuridico dei folli-rei, particolarmente interessante poiché caratterizzato da un livello di sovraffollamento di agenti specializzati, che non ha pari in altri settori di campi simili e che è causa, come verrà dimostrato, di ambiguità, disfunzioni, “schizofrenie”.
Alle figure professionali più strettamente giuridiche (per formazione e funzioni): i magistrati di cognizione e di sorveglianza, gli avvocati, i direttori penitenziari, si affiancano infatti figure para-giuridiche, come gli agenti di Polizia penitenziaria e figure extra-giuridiche, con ruoli riconducibili alle esigenze di cura degli internati, come gli psichiatri (tanto lo psichiatrica territoriale del Dipartimento di Salute Mentale, quanto quello di istituto), gli psicologi, gli educatori, gli operatori di comunità.
Le interazioni tra tali soggetti sono riconducibili al modello sociologico della cooperazione conflittuale (10), concetto proprio della sociologia dell'organizzazione, che intende definire l'azione sociale instaurata da soggetti portatori di obbiettivi differenti e con ineguale potere decisionale, tenuti ad adottare delle forme di negoziazione al fine del raggiungimento dei propri obiettivi individuali.
È chimerico pensare al raggiungimento di un'armonia di azioni e una unitarietà di intenti che possa risolvere il dannoso conflitto tra agenti specializzati? L'oltre etico e giuridico evocato dal sottotitolo di questa ricerca è sterile esercizio teorico o è futuro prossimo?
Per tentare di dare una risposta a questi difficili quesiti si è scelto di adottare un metodo di ricerca ingiustamente marginalizzato dall'apprendista giurista contemporaneo, abituato alla comodità delle torri d'avorio della manualistica e del troppo spesso sterile dibattito dottrinale, che rimane smarrito e sorpreso nello scoprire un mondo, come quello carcerario e quello degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (11) in cui vige una «perenne contraddizione tra le finalità dichiarate (di emenda, di recupero sociale, di rieducazione dei condannati) e quelle attuate di fatto mediante consolidate e apparentemente immutabili prassi carcerarie» (12).
Il metodo scelto è la riaffermazione del primato dell'esistenza sul teorico concettualizzato e praticato, in tutt'altro contesto, dal sociologo torinese Mauro Rostagno (13). In queste pagine tale primato si concretizza in una ricerca esplorativa sul campo delle strutture di esecuzione penale dedicate ai folli-rei.
Non solo gli O.P.G. e le Case di Cura e Custodia, previste dai nostri codici, ma considerati luoghi destinati, presto o tardi, ad essere superati e sostituiti da istituzioni-altre come le comunità terapeutiche specializzate nel ricovero di folli-rei, i reparti di osservazioni psichiatrica delle carceri e i servizi di psichiatria territoriale.
Il primo capitolo è sostanzialmente suddivise in due parti, nella prima si delinea il contesto sociale all'interno del quale il folle-reo si colloca e lo stigma con cui viene marchiata la sua doppia devianza (la commissione del reato e la malattia mentale) dalla moderna società dell'insicurezza, ciò aiuterà a capire i principali istituiti giuridici che riguardano i folli-rei, concentrandosi, in particolare, anche se non esaustivamente, sui concetti di imputabilità e di pericolosità sociale e sulla loro evoluzione in dottrina e in giurisprudenza, nel solco di quella precipua tradizione italiana che è il c.d. sistema del doppio binario.
Nella seconda parte del primo capitolo si adotta invece la prospettiva dello storico del diritto, ripercorrendo, anno dopo anno, dal 1876 al 2011, le tappe fondamentali riguardanti il controverso binomio cura e sicurezza e descrivendo quell'intricato intreccio di corsi e ricorsi storici, fatto di assordanti silenzi, precipitose riforme, gattopardeschi affanni. Tale ricostruzione è fondamentale, oltre che a introdurre alcuni concetti sociologici salienti ai fini della trattazione, quali quello dell'imprenditore morale, a far da preambolo alla seconda parte della tesi.
Nel secondo capitolo infatti, rivendicando l'impellente necessità di un'analisi comparatistica del problema, si inquadrerà il fenomeno dei mentally ill offenders (i folli-rei) e degli high security hospitals, gli O.P.G. d'Oltremanica, nella tradizione di common law e, in particolare, nel contesto statunitense e anglosassone, scelta non casuale, ma dettata dalla possibilità data all'Autore di svolgere un semestre di ricerca sul campo al Center for Transnational Legal Studies di Londra.
Il terzo capitolo è certamente quello in cui il primato dell'esistenza si afferma con maggior determinazione, accogliendo scientemente il rischio, di compiere un'analisi e un'attività poco ortodossa per una tesi di giurisprudenza. In questa sezione infatti non si illustrano soltanto le principali proposte di riforma del sistema sanzionatorio delle misure di sicurezza, distinguendo tra posizioni abolizioniste e revisioniste, facendo largo uso degli strumenti statistici, ma ci si affretta a riaffermare la prevalenza dell'Uomo sul Numero, dando conto delle visite svolte dall'Autore all'interno delle comunità terapeutiche protette, specializzate nell'ospitare pazienti psichiatrici autori di reato.
Si è ritenuto infatti che l'unica modalità con cui: apprezzare gli effetti concreti della decisioni della giurisprudenza (soprattutto quella costituzionale) e dei più recenti interventi legislativi in tema di folli-rei e sanità penitenziaria, sondare la fattibilità delle proposte di riforma e valutare la sostenibilità della alternative agli attuali O.P.G., sia quella di visitare tali strutture, interloquire con ospiti e operatori, comparare le metodologie e le prassi di intervento, per poi proporre una analisi sociologica e giuridica delle osservazione sul campo.
Solo così si può cogliere, nella relazione tra legislazione (riferimento a normativa in tema di salute e riabilitazione), definizioni dei servizi (carte dei servizi), discorsi e pratiche di operatori e utenti della comunità, la complessità di una realtà che si genera nella confluenza di aspetti giuridici, sociologici, antropologici, psicologici e psichiatrici.
Parte essenziale di tale ricerca sono stati gli incontri e le interviste con diverse figure professionali, alcuni riportati integralmente nelle pagine seguenti, altri parzialmente, altri semplicemente citati o utilizzati per creare un sostrato di conoscenze e opinioni necessario ad orientare le varie fasi della ricerca.
La scelta dei soggetti da intervistare è il risultato del tentativo di dar conto della complessità del problema e del sovraffollamento del campo giuridico dei folli-rei, evitando così di affrontare la questione dal punto di vista di una sola categoria professionale, ma allargando il più possibile lo spettro di opinioni, competenze, professionalità e obiettivi.
Le interviste sono state raccolte, nei contesti più vari, nell'arco temporale tra il settembre 2010 e il settembre 2011 e hanno seguito uno schema libero, per evitare di imbalsamare le idee in un rigido questionario, con il rischio di non cogliere le differenze di approccio alla problematica. Ecco l'elenco degli intervistati in ordine alfabetico:
- Andrew Bridges, direttore del Probation System del Ministero della Giustizia del Regno Unito,
- Andrew Coyle, già direttore penitenziario, presidente dell'International Center for Prison Studies, Essex University,
- Angelo Fioritti, psichiatra, direttore D.S.M. Bologna e coordinatore progetto di ricerca Mo.di.O.P.G.,
- Anna Greco, coordinatrice educatori casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, responsabile Forum Giustizia e Salute del Piemonte,
- Anna Maria Frammartino, psicologa a contratto, reparto di Osservazione Psichiatrica “Sestante”, casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino,
- Antonino Calogero, Direttore sanitario O.P.G. Castiglione delle Stiviere,
- Caterina Corbascio, psichiatra, direttrice D.S.M. Asti e referente piemontese del progetto di ricerca Mo.di.O.P.G.,
- Dario Stefano dell'Aquila, referente Antigone Campania, autore del libro inchiesta sugli O.P.G. “Se non ti importa il colore degli occhi”,
- Franco Scarpa, Direttore Sanitario O.P.G., Montelupo Fiorentino,
- Giovanni Gardelli, psicologo, responsabile comunità Casa Zacchera di Sadurano (Forlì),
- Ignazio Marino, Senatore della Repubblica, presidente della Commissione per l'efficienza del Servizio Sanitario nazionale,
- Luigi Missiroli, psichiatra, ex direttore D.S.M. Forlì,
- Nunziante Rosania, Direttore Sanitario O.P.G., Barcellona Pozzo di Gotto,
- Peter Tague, professore di procedura penale e deontologia forense, Georgetown University di Washington,
- Santi Consolo, Vice capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,
- Silvia Morrone, psicoterapeuta, direttrice clinica comunità Il Montello di Serravalle Scrivia (Alessandria),
- Ugo Zamburru, psichiatra, direttore D.S.M. Asl 4 Torino, scrittore e animatore del Caffè Basaglia di Torino.
A questi si aggiungono i veri protagonisti di questa ricerca esplorativa, i pazzi criminali, con cui ho parlato, mangiato, guardato l'orizzonte, giocato a carte. Soggetti sospesi, loro malgrado, tra mondi incomunicabili, tra le ragioni (e i torti) del diritto e quelli della psichiatria, tra esigenze di cura e di sicurezza. Uomini e donne senza vie di mezzo, o compatiti o puniti.
Il lettore, nelle pagine che seguono, non troverà né facile pietismo, né livorosa intransigenza nei confronti delle loro azioni e delle loro esistenze.
Si cercherà piuttosto di dare loro, quello che chiedono e quello che meritano, la dolcezza.
1.2 La società e il folle reo. Il tempo degli stigma
Posto che si accettino come presupposto ideologico i due fondamentali assiomi della criminologia correzionale (14) e considerando quindi (a) l'azione sociale come intersoggettivamente significativa e (b) il “crimine” come costruzione sociale e non esistente per se, il più convincente tra i tre maggiori approcci sociologici (15), per spiegare come l'odierna società dell'insicurezza si relaziona con i folli-rei, è probabilmente l'interazionismo simbolico.
Le “pietre angolari” del pensiero interazionista, secondo uno dei suoi principali teorizzatori, Herbert Blumer (16), sono:
- Gli esseri umani agiscono nei confronti delle cose sulla base dei significati che queste hanno per loro;
- Il significato di tali cose è derivato dall'interazione sociale che ciascuno ha con i propri simili;
- Questi significati vengono negoziati e modificati attraverso un processo interpretativo messo in atto dalla persona nel relazionarsi con le cose che ha di fronte.
Tutto gravita intorno alla definizione sociale del crimine data dalla collettività in un preciso contesto spazio-temporale. Quindi, se è vero che da un lato, «l'interpretazione di un atto dipende da come la situazione o l'ambiente interazionale viene definito dai partecipanti» (17) e, dall'altro, occorre superare una visione puramente positivistica, evitando di appiattire il fenomeno criminale su una misurazione statisticoquantitativa (18), con il rischio di dimenticarne l'aspetto qualitativo, cioè perché e come nasce e si sviluppa il crimine, occorre constatare che i comportamenti umani vengono continuamente valutati ed etichettati (19).
Etichettati sia dal soggetto che li pone in essere - il self - sia dagli altri consociati - la community - (è la c.d. Labelling Theory o Teoria dell'Etichettamento).
Le azioni, tutte le azioni umane, vengono categorizzate, o meglio etichettate, e definite conseguentemente conformi o difformi (20). Molto dipende dai soggetti che effettuano il processo di interpretazione del crimine (21): possono essere soggetti “istituzionali”, come i magistrati o le forze di polizia (22), chiamati a loro volta a dar seguito a processi di definizione del crimine compiuti dalla legislazione penale, oppure soggetti “non istituzionali”, le cui interpretazioni non vanno tuttavia sottovalutate in termini di grado di severità della reazione sociale (23), poiché possono concretamente avere conseguenze ben peggiori per i soggetti etichettati come devianti o criminali.
Sulla base del pensiero interazionista occorre dunque capire i contorni della fase storica-culturale odierna, per indagare come il soggetto psicotico autore di reato (il folle-reo) viene etichettato.
Grave errore sarebbe pensare che tale analisi dell'interpretazione sia vuoto esercizio accademico senza apprezzabili conseguenze nella realtà, basti pensare, a titolo di esempio, come la categoria della pericolosità sociale (che coinvolge direttamente i folli-rei) influenzi il dibattito del mondo del diritto, modificando, come vedremo, le strategie di controllo penale rispetto agli autori di reato “pericolosi”.
Secondo l'analisi di UIlrich Beck (24) siamo passati dalla Società classista alla Società del rischio, cioè da una società costruita sul concetto di «produzione e distribuzione della ricchezza» ad una realtà in cui ci si preoccupa della «distribuzione dei rischi». Nello specifico per rischio si intende l'aleatoria conseguenza di decenni di sviluppo scientifico e tecnologico senza pari nella Storia dell'Uomo, che hanno ampliato il grado di incertezza nel futuro e la consapevolezza (o la percezione) di Istituzioni incapaci di arginare la violenza e dare sicurezza al cittadino.
Il legame tra sviluppo tecnologico beckeriano e folli-rei può, prima facie, apparire totalmente inesistente, ma non lo è affatto, se si pensa che il senso di insicurezza nasce come paura di uno sviluppo tecnologico incontrollato e investe direttamente, in seconda battuta, le relazioni tra consociati. «Nella società postindustriale, migrazioni, disoccupazioni, conflitti culturali, problemi di articolazione interna determinano una situazione di coesistenza che genera conflitti interindividuali con episodi più o meno espliciti di violenza, in questo contesto, il primo fattore di rischio percepito è costituito dall'Altro» (25).
Ma l'Altro non è più un singolo individuo, ma è «il gruppo, la moltitudine, la società nel suo insieme» (26): sono infatti intere città ad essere considerate “insicure”, non i singoli cittadini che abitano in quel contesto.
Così ragionando, la posizione del folle-reo, già storicamente considerato un “diverso” con il quale ridurre al minimo le relazioni umane, si aggrava, andandosi a sommare a quel senso di insicurezza collettiva (e quindi di diffidenza) che investe tutte le classi sociali, nessuno escluso (27). Se già essi partivano quindi da una posizione di svantaggio, le loro condizioni si sono ulteriormente aggravate nella Società del rischio.
Urge ora, prima di proseguire nella descrizione dell'aspetto individuale, cioè del crimine visto dal punto di vista del suo autore (nel nostro caso lo psicotico), compiere un ulteriore passo nell'esplorazione della Società del Rischio, senza il quale la nostra analisi risulterebbe monca e fallace.
È necessario infatti indagare lo scollamento tra criminalità effettiva e criminalità percepita: spesso a condizionare le relazioni umane è una sensazione di insicurezza, più che una insicurezza oggettiva (28). Ritornano le riflessioni di Hagan (29) sulla percezione del danno sociale come elemento costitutivo della criminalità: «Alcuni comportamenti come il gioco d'azzardo, la prostituzione o l'utilizzo di droghe vengono considerati relativamente poco dannosi, tant'è vero che sono chiamati reati senza vittime, anche se talvolta producono danni significativi sia a chi li pratica che alla rete sociale in cui queste persone sono inserite. Vi sono invece atti criminali che hanno un forte impatto sociale, basti pensare al terrorismo, alla violenza della criminalità organizzata, ai crimini predatori o d'impresa, alle violenze sessuali. (...) Vi sono crimini, insomma che, pur producendo danni seri, possono essere considerati, nella percezione pubblica, relativamente poco dannosi» (30).
Cosa produca e chi sia il responsabile di tale paradosso è analisi complessa, da rimandarsi ad altra e specifica ricerca; merita comunque in questa sede compiere una riflessione sul ruolo primario svolto dai mass media (31) e della rappresentazione mediatica della criminalità. Quest'ultima mira, in primo luogo, all'identificazione del fruitore (telespettatore o lettore) con la vittima (32) e, in secondo luogo, alla demonizzazione dell'autore di reato, in una sorta di linciaggio mediatico, considerando «ogni attenzione ai diritti dell'autore una mancanza di rispetto per le vittime» (33).
L'Osservatorio di Pavia-Media research (34) trasforma annualmente in dati statistici la correlazione tra “percezione dell'insicurezza” e “media”.
Come si evince dalla Tabella 1.1, se si confrontano tre parametri statistici (il numero di reati conosciuti dall''Autorità giudiziaria (35) sulla base dei dati ufficiali raccolti dal Ministero dell'Interno, il numero di notizie (36) riguardanti episodi di criminalità (37) e la “percezione di insicurezza” (38)), si nota che a fronte del numero di reati che resta sostanzialmente stabile, con una lieve decrescita a partire dal secondo semestre del 2009, il numero di notizie ha un andamento variabile, ma quantitativamente di gran lunga sempre maggiore rispetto al numero di reati, con “picchi” in corrispondenza dei c.d. Casi criminali (39).
Il dato della “percezione dell'insicurezza” invece di seguire la “criminalità effettiva”, è molto influenzato dalla mediatizzazione della criminalità, producendo così quello scollamento tra “criminalità percepita” e “criminalità effettiva”.
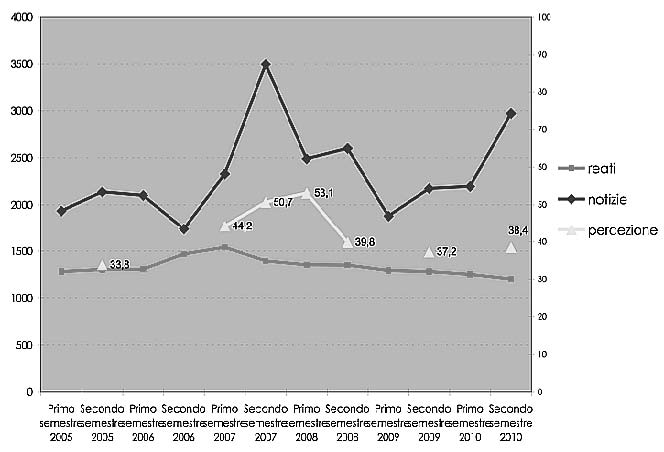
Occorre domandarsi se la «bolla dell'insicurezza mediatica» sia questione tutta italiana o riguardi più in generale un trend mondiale o, per lo meno, europeo.
Occorre quindi confrontare le agende dei principali telegiornali europei, scoprendo così come «le notizie relative a fatti criminali rappresentano un tratto strutturale e costante della pagina dell'informazione pubblica e privata italiana, posizionandosi al terzo posto nell'agenda con una percentuale pari all'11,9%, doppia rispetto alla media europea del 5,9% e addirittura 11 volte superiore alla Germania, ferma all'1,5%» (Tab. 1.2) (40).
Emerge insomma una tipicità tutta italiana di attenzione alle soft news e alla cronaca nera, che si combinano con le notizie politiche, economiche e sociali.
Il confronto con la narrazione dei fatti criminali negli altri paesi europei si svolge su due piani: uno quantitativo, il numero di notizie riguardanti fatti criminali, e uno qualitativo, relativo alle modalità di narrazione. Dal primo emerge la distanza numerica tra il telegiornale pubblico italiano e quelli degli altri paesi (41).
Rispetto alle modalità di narrazione della criminalità, da un lato si conferma l'attenzione che tutti i telegiornali europei dedicano ai c.d. “casi criminali”, ovvero quei crimini che in ragione della loro efferatezza ed eccezionalità ricevono un'ampia copertura mediatica, dall'altro si evidenzia la pervasività delle notizie criminali nel telegiornale italiano rispetto a quelli europei.
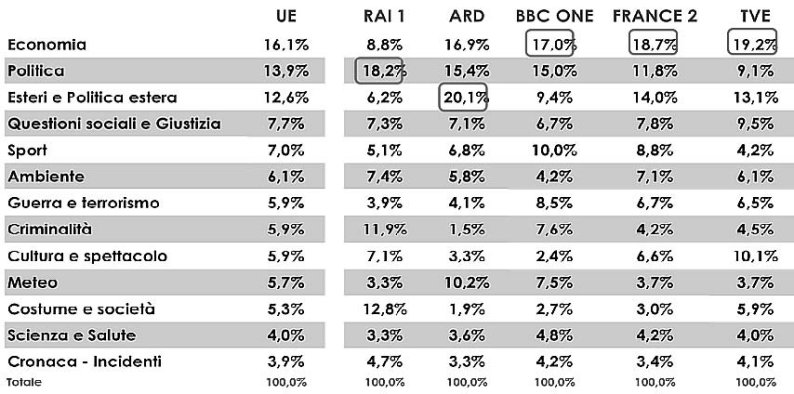
È lapalissiano il primato dei temi economici nell'agenda dei telegiornali delle reti pubbliche europee, con l'unica eccezione dell'Italia dove l'economia si ferma all'8,8% (rispetto a una media europea del 16,1%) e dell'Ard tedesco, dove le questioni di Politica Estera (20,1%) superano di qualche punto percentuale le notizie economiche (16,1%).
Il dato italiano acquista maggior rilevanza se si addizionano la percentuale di servizi dedicati al Costume e Società (le c.d. Soft news) alla cronaca nera, arrivando al 24,7%, cioè un quarto dell'intero telegiornale.
In sintesi si può notare che «in Europa il primato delle notizie ansiogene corrisponde alla crisi economica e all'impatto sulla vita dei cittadini (generico peggioramento delle condizioni di vita, disoccupazione, riduzione del potere di acquisto per le famiglie), in Italia il primato dell'insicurezza spetta alla criminalità» (42).
La situazione non cambia in termini di numeri assoluti con l'aggiunta delle emittenti private, se si confronta in una settimana tipo (nella Tab. 1.3, la prima settimana di settembre 2009), il numero unitario di servizi dedicati alla criminalità, sempre nella fascia serale prime time, si nota come solo le reti private spagnole superano il dato italiano (con la cifra record di 36 servizi), che, tuttavia, aggregando reti pubbliche e reti private, l'Italia arriva a 50 servizi settimanali (circa 7 al giorno). Una vera e propria “bulimia criminale”.
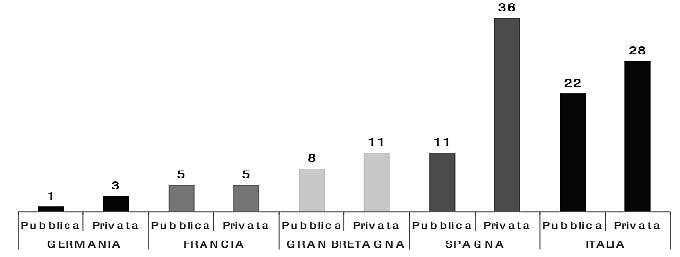
Se si tratti solamente di semplici scelte editoriali o di una pianificata strategia di politica criminale non si riesce ad evincere dai numeri; sicuramente spostare ogni responsibilità sui mass media significherebbe banalizzare il problema, compiendo un'analisi parziale.
Ma anche se permangono dubbi sul mezzo, quel che appare innegabile è il risultato: il diritto penale diventa mezzo di comunicazione politica e difficilmente sa resistere a pressioni populiste frutto di una politicizzazione della questione criminale senza precedenti storici (43). Il rischio è tradurre, in modo del tutto semplificatorio, le legittime richieste di maggiore sicurezza in un impulso abnorme verso una maggiore penalità o verso forme di privatizzazione dei mezzi di difesa, da cui può conseguire una pericolosa contrazione di un compito che dovrebbe rimanere allo Stato (44), quale monopolista della forza.
Per i folli-rei le conseguenze possono essere devastanti, in quanto essi sono legati a doppio mandato al giudizio di pericolosità sociale, che essendo giudizio di valore è «fortemente influenzato dal grado di colpevolezza morale e di allarme sociale che, nei vari momenti storici, viene attribuito a determinate categorie di delitti» (45).
La paura dei consociati da una parte, e l'ansia del legislatore di trovare soluzioni tanto più rapide quanto più repressive per dare risposta ad un popolo che «percepisce di essere insicuro» dall'altra, portano alla schizofrenia penale descritta da David Garland e dalla Scuola criminologica di Chicago (46). Si configurano così le caratteristiche salienti della sociologia postmoderna, destinata a plasmare il sostrato culturale e teorico di questo inizio secolo.
Garland parte infatti dall'osservazione di due dati di realtà, riferiti all'area delle sue ricerche (gli Stati Uniti), ma estendibili anche alla società europea, come vedremo:
- Il primo è la rilevazione statistica che un afroamericano su tre di età compresa tra i 20 e i 35 anni, negli Stati Uniti, è sottoposto a “controllo penale” in strutture carcerarie. Tali strutture sono prepotentemente tornate ad utilizzare strumenti di “caratterizzazione visiva” del carcerato, come ad esempio l'uso di manette e catene, anche all'interno dell'istituto penitenziario, e l'obbligo di vestire uniformi a strisce bianche e nere, che esplicitamente ricordano quelle dei galeotti a cavallo tra XIX e XX secolo. Ciò avviene soprattutto nell'area meridionale degli U.S.A., storicamente più conservatrice.
- Il secondo dato è la crescita smodata, soprattutto nelle aree metropolitane, di sistemi di sorveglianza affidati a telecamere a circuito chiuso o a agenzie di sicurezza private (47).
Secondo il sociologo americano questi due elementi sono contraddittori, poiché «nel primo caso il criminale è un individuo radicalmente diverso, un vero e proprio monstrum incorreggibile i cui istinti atavici minacciano la società, e perciò deve essere neutralizzato fisicamente e socialmente ad ogni costo (compreso il ricorso al forte simbolismo visivo che evocano catene, manette, uniformi N.d.A). Nel secondo, il criminale è al contrario un individuo perfettamente normale, razionale e opportunista come ogni attore economico, che probabilmente sarà dissuaso dal delinquere dalla presenza di una telecamera discreta o di una pattuglia di vigilanza privata. Nel primo scenario le prerogative penali dello Stato sovrano si mostrano in modo spettacolare sul palcoscenico di un teatro punitivo in cui il deviante è stigmatizzato e degradato. Nel secondo, lo stesso Stato sovrano sembra rinunciare al proprio monopolio su legge e ordine, lasciando che il controllo della criminalità si insinui silenziosamente fra le pieghe del mercato e della privatizzazione» (48).
Ecco spiegata la schizofrenia: la società moderna (o meglio, postmoderna) alterna risposte adattive e risposte non adattive, differenziando conseguentemente tra Criminologia della vita quotidiana (o Criminologia del sé) e Criminologia dell'Altro.
Le risposte adattive sono tipiche della Criminologia della vita quotidiana: il reato è considerato niente di più che un semplice fattore economico, «un rischio attuale da calcolare o un evento accidentale da evitare, non più un'aberrazione morale che necessita di una spiegazione specifica» (49); oppure «la manifestazione di una patologia, di una personalità disturbata o, in generale, di fattori sociali di emarginazione» (50).
Il fatto che un consociato possa essere vittima o autore di un atto criminale rientrerebbe insomma nella quotidianità, in quella alea di rischio che caratterizza ogni relazione umana. Ecco allora che si ricorre sempre più frequentemente a risposte adattive, meno visibili dal punto di vista del consenso dell'opinione pubblica (51), ma considerate dal singolo più rassicuranti ed efficaci. Gli stessi cittadini, consci del fatto che l'Istituzione pubblica non riesce a garantire la sicurezza, ricorrono a tecniche di prevenzione situazionale, derivanti dalla stesse rete delle interazioni della vita quotidiana.
In concreto, seguendo i dogmi di una persuasiva retorica neoliberista (52), essi scelgono di affidarsi a soggetti altri, che non siano le agenzie statali centrali: si “comprano” guardie private, si “comprano” complessi sistemi di antifurto, si “compra”, in definitiva, la propria sicurezza.
Sulla Criminologia della vita quotidiana è difficile, ma auspicabile, dare un giudizio globale valido per ogni tipo di sistema giuridico nazionale, poiché le c.d. tecniche adattive di prevenzione presentano gradi diversi di efficacia e problemi di compatibilità differenti con il monopolio statale dell'ordine pubblico (53), a seconda del quadro giuridico istituzionale in cui operano.
Se è vero che Garland affronta la tematica da un punto di vista marcatamente statunitense, dove il fenomeno della privatizzazione della sicurezza ha radici più profonde storicamente e più salde ideologicamente rispetto all'Europa continentale, è pur vero che le sue teorie si adattano bene alla situazione italiana, se si accetta di far ricorso a piccoli accorgimenti.
Sostituiamo, ad esempio, ad una nozione restrittiva di «soggetti privati» (54) una definizione maggiormente estensiva, che possa includere tutte le Agenzie amministrative territoriali (i c.d. Enti locali), dando così accoglienza a quell'idea di autorità pubblica “policentrica” prevista dal nostro ordinamento costituzionale (55). Così ragionando si includerebbero tra i mezzi di prevenzione situazionale anche le ordinanze amministrative come forma di controllo del territorio, poste in essere dalle Amministrazioni comunali e provinciali.
In Italia è innegabile il ruolo svolto dagli enti pubblici territoriali, non statali, a tutela della sicurezza urbana e per soddisfare la nascente funzione preventiva della criminalità (56).
L'apice di tale tendenza è stato tradotto in legge dal legislatore nazionale con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92 (il c.d. Decreto Sicurezza), convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il cui art. 6 dispone «(...) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza» (57).
Ampliando il potere dei Sindaci in materia di ordine pubblico, attraverso lo strumento dell'ordinanza, oltre a sancire legislativamente la «supplenza delle funzione repressive dall'autorità locale, in sostituzione di quella statale» (58), non si fa altro che dare italica accoglienza ai principi teorici della Criminologia della vita quotidiana garlandiana.
1.3 Il folle reo e la società. Il tempo della (in)differenza
Fino ad ora si è rimasti su un piano di analisi comunitario-sociale, delineando, dal punto di vista della Sociologia del diritto, qual'è il palcoscenico (le condizioni ambientali, culturali e politiche) in cui si muove l'attore al centro della ricerca: il folle reo.
Ora occorre compiere un passo fondamentale, andando a indagare chi è stato, chi è tutt'oggi e chi sarà nel futuro prossimo il folle reo e se e come la società/comunità si relaziona con la sua doppia devianza.
Anzitutto è necessario completare il pensiero di Garland, affrontando la seconda tipologia di criminologia secondo la Scuola di Chicago, vale a dire la Criminologia dell'Altro, che si concretizza in risposte non adattive. Risposte, cioè, basate sul «recupero morale della responsabilizzazione individuale, che rifiuta di giustificare o attenuare la responsabilità [del singolo per il reato commesso] in nome dei condizionamenti sociali o psicologici (59) che contrassegnano il vissuto del reo» (60).
La conseguenza di tale teorizzazione è il riconoscimento di una piena responsabilità per il fatto commesso, che merita solamente la più severa delle pene possibili.
È la ri-nascita di un neoretribuzionismo, che vorrebbe cancellare, o per lo meno attenuare fortemente, l'idea rieducativa della pena.
C'è un chiaro passaggio dalla comprensione per l'autore alla sua responsabilizzazione (61), pienamente recepito dal legislatore con le tanto discusse politiche di “tolleranza zero” e di “legge e ordine”. D'altronde, nel pensiero del legislatore moderno, c'è la volontà di evitare che «ad una finestra rotta, per un processo degenerativo di imitazione, segua un'altra finestra rotta e poi un'altra e un'altra ancora» (62); è la già descritta società dell'insicurezza a chiedere di «non ridurre la pena ad una sorta di grida secentesca di manzoniana memoria» (63).
Se la Criminologia della vita quotidiana intende la criminalità come un fatto “quotidiano” e quindi normale e abituale in ogni comunità/società, il concetto chiave della Criminologia dell'Altro (64) è la differenza: il soggetto deviante non è un “consociato perbene” uguale agli altri, ma è antisociale, perché presenta profili “negativi” che lo rendono diverso dalla massa e quindi dalle sue potenziali vittime.
In sintesi, «più si è diversi, più si è pericolosi» (65). È come se, consciamente o più probabilmente inconsciamente, si crei una diversità costituzionale (quasi ontologica), frutto di quell'«allarme per l'alterità, che porta ad identificare tutto ciò che è estraneo da me come minaccioso e pericoloso» (66).
Non è questa certamente una novità caratterizzante dell'età postmoderna in cui viviamo; tuttavia la differenza rispetto ad altre epoche storiche è la provenienza dell'altro: egli può venire “dall'esterno” o “dall'interno” della comunità in cui vive.
In questo senso, Antonio Scurati (67) descrive sapientemente la differenza tra paura esternalizzante e paura internalizzante. La prima segue il paradigma proiezione escluisione (se tutto il “male” viene da fuori, allora “nessuno deve venire da fuori”), la seconda si basa invece su introiezione-eliminazione (“il male” proviene dall'interno della società, ma è una realtà talmente inconfessabile che viene occultata) (68).
Da qui all'insegnamento della Scuola del positivismo criminologico italiano (69) di lombrosiana memoria il passo è davvero breve; l'unica differenza è che, mentre i criminologi positivisti ipotizzavano che la “delinquenza” di un soggetto nascesse da differenze biologiche (o comunque nosograficamente rilevanti), la Scuola di Chicago sottolinea il profilo sociale del soggetto e la sua appartenenza a determinate categorie sociali (il “matto”, l'“immigrato clandestino”, il “mafioso”, il “drogato”).
Ed ecco avvenire il passaggio saliente: la società necessita di un pena che sappia neutralizzare (più che rieducare, reinserire o risocializzare) il reo, allontanandolo dalla società per mezzo della segregazione fisica. Ma la neutralizzazione non è esattamente l'originaria e principale funzione delle misure di sicurezza, applicate ai folli-rei in quanto non imputabili? L'equazione, almeno da un punto di vista teorico, è alquanto sorprendente. Le misure di sicurezza, tra le quali l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, nate da presupposti antitetici rispetto alle pene, si adattano alla crisi del sistema penale e si ritrovano paradossalmente a svolgere le stesse funzioni e ad ottenere il medesimo risultato (70): neutralizzare il deviante.
Occorre ora domandarsi quali siano gli strumenti giuridici attraverso i quali si concretizza tale neutralizzazione.
È proprio questa la questione che occuperà il prossimo paragrafo: prima di scoprire l'istituzione O.P.G. e le sue possibili alternative, è necessario studiare il percorso del folle-reo. Le coordinate geografiche (o meglio giuridiche) da seguire hanno nomi che evocano nel giurista (e nel sociologo) anni di decisioni giurisprudenziali, svolte legislative, accesi dibattiti in dottrina: la pericolosità sociale e l'imputabilità.
1.4 La pericolosità sociale: dalla presunzione all'accertamento in concreto
Gli estensori del Codice Rocco hanno dovuto lavorare di fino per arrivare a definire la pericolosità sociale, presupposto necessario per l'applicazione delle misure di sicurezza, andando così a delineare il caratteristico sistema del doppio binario.
Correvano gli anni Venti, il regime chiedeva “ordine e disciplina”: non potendo accettare l'idea che “i pericolosi” potessero recar danno alle persone “perbene”, occorreva essere più autoritari, a cominciare dai nuovi codici. Infatti, dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, la politica criminale non solo italiana, ma europea, fu chiamata a dare risposte nuove ed efficaci a «impennate delle forme più gravi di criminalità» (71).
Il modello monista basato solo sulla pena era strumento inadeguato di contrasto dei plurirecidivi, evidentemente non persuasi al delinquere. Lo stesso «cavallo di razza» (72) Alfredo Rocco, Guardasigilli del Regno all'epoca dell'emanazione del codice penale, nel 1929 commentava così la stesura definitiva del testo: «La necessità di predisporre nuovi, e in ogni caso più adeguati, mezzi di lotta contro le aggressioni all'ordine giuridico, da adoperarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo, è ormai universalmente riconosciuta» (73).
Da un lato insomma c'erano le ragioni della politica, che esortava i tecnici del diritto a «svincolarsi dai limiti garantistici della pena» (74), dall'altro vi era sotteso un duro scontro in dottrina tra la Scuola classica e la Scuola positiva (o moderna) (75). Entrambe proponevano un sistema monistico, basato però su presupposti contrapposti: i “classici” erano sostenitori di pene con funzioni principalmente retributive e soprattutto proporzionate alla gravità del reato commesso, i “positivi” immaginavano pene con funzioni preventive, che, basandosi su una valutazione soggettiva dell'autore del reato, evitassero, con la loro durata indeterminata, la commissioni di nuovi reati.
La soluzione cerchiobottista trovò la sua sintesi nel sistema del doppio binario, cioè l'affiancare alla pena, fondata sulla colpevolezza, la responsabilità e l'imputabilità dell'individuo, un'ulteriore “sanzione”, chiamata misura di sicurezza. Per essere applicata, quest'ultima ha bisogno sostanzialmente di due presupposti, enumerati all'art. 202 c.p.: «Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato».
È pertanto necessario che il soggetto abbia compiuto un reato (o un quasi reato) (76) e soprattutto, più interessante ai fini di questa ricerca, che sia socialmente pericoloso, caratteristica in prima battuta solo enunciata, ma non riempita di significato, fornito dall'art. 203 c.p.: «Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p.».
Il legislatore, in definitiva, chiede al giudice di stabilire quanto sia probabile che il soggetto compia nuovi reati in futuro, oppure, nell'ipotesi di quasi-reato, quanto sia probabile che il soggetto compia reati. Il termine “reato” va inteso nel significato più ampio possibile, come qualsiasi fatto previsto dalla legge come tale e non soltanto quelli della stessa indole del reato già commesso. Il concetto di probabilità di commettere nuovi reati, non è poi così distante da quello di temibilità, introdotto nel dibattito dottrinale italiano dal giurista napoletano Roberto Garofalo già nel 1878, che pretendeva di misurare la «capacità criminale del delinquente, cioè la sua perversità e la quantità di male che si può attendere da lui» (77).
Termini come prevedibilità, probabilità o temibilità non hanno nessun significato da un punto di vista psicopatologico e, probabilmente, proprio per questa mancanza di scientificità sono stati scelti dal legislatore del codice e “sostenuti” da larga parte della dottrina, che sentiva la necessità di «far recuperare al mondo del diritto ciò che aveva concesso alla psichiatria, definendo la pericolosità mediante parametri non tanto psichiatrici, quanto giuridici». (78)
Ma la svolta sociologicamente più significativa riguarda l'art. 204, rimasto in vigore fino al 1986 (79) e poi abrogato dalla c.d. Legge Gozzini (l.663/1986) (80). Il passaggio è epocale, poiché si sancisce la necessità di eliminare ogni forma di pericolosità presunta imposta dalla legge, lasciando spazio solo ad un accertamento in concreto da parte del giudice (81).
Ecco affermarsi prepotentemente quel «clima di fiducia nel potere regolativo dell'autorità giudiziaria, alla quale si rimettono le sorti dell'intero apparato delle misure di sicurezza, il cui ruolo di difesa sociale e prevenzione speciale è stato mediato dalle scelte dell'autorità giudiziaria nel far ricorso a sanzioni, il cui presupposto soggettivo è quanto mai vago» (82).
Ricapitolando, l'art. 204 così statuiva: «Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa [c.p. 203].
Nei casi espressamente determinati [c.p. 109, 210, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 240, 312, 417, 538], la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno anche in tali casi l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:
- dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;
- dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso».
Se alla creazione di presunzioni di pericolosità, che, come si evince dalla lettera della norma, erano un numero piuttosto significativo, si aggiunge l'aggravamento portato dalla non previsione di termini minimi di durata delle misure di sicurezza, si profila un quadro vessatorio insostenibile nei confronti dell'internato (così è definito il soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale detentiva).
Si concretizza insomma quella truffa delle etichette, che porta, sul piano concreto applicativo, a svuotare di significato l'intero costrutto teorico del doppio binario, poiché si trasformano le misure di sicurezza in una «ulteriore pena a tempo indeterminato» (83), facendo venire meno quell'auspicabile diversità di contenuti tra misure di sicurezza e pena, senza la quale lo stesso doppio binario diverrebbe costituzionalmente incompatibile.
Massimo Niro (84) nota polemicamente: «Se l'O.P.G. [ed estensivamente qualsiasi misura di sicurezza personale, N.d.A.] fosse pienamente assimilabile al carcere, non avrebbe senso esonerare dalla pena l'infermo di mente pericoloso autore di reato e la distinzione pena-misura di sicurezza si ridurrebbe ad un artificio giuridico, ma così non può essere e dunque occorre conferire caratteri e requisiti ulteriori che lo differenzino da un normale istituto di pena. Tale quid pluris, che ne giustifichi l'esistenza sta' appunto nella funzione di cura dell'infermo di mente e nella su intrinseca, quanto necessaria funzione terapeutica».
“Presumere la pericolosità” significava invece accettare, e anzi imporre legislativamente, quell'insostenibile equazione malato di mente = pericoloso (85).
A questo punto si staglia come fortezza (apparentemente) inespugnabile il cuore del problema della pericolosità sociale. E cioè: chi la accerta e, soprattutto, in base a quali parametri?
È la prima, ma non certamente ultima volta, che si propone il problema del coordinamento e della convivenza tra poteri, da una parte le ragioni del diritto, dall'altra quelle della scienze psichiatrica; da una parte il giudice e il giurista, dall'altra lo psichiatra perito.
La legge impone il superamento delle presunzioni, ma non si sobbarca il peso di stabilire chi debba effettuare questo accertamento.
In linea teorica il giudice dovrebbe valutare autonomamente, poiché il legislatore ha ritenuto non opportuno inserire nel rinnovato codice di procedura penale la c.d. perizia criminologia (86), nonostante fosse prevista dalla legge delega votata dal Parlamento nel 1974. In pratica, però, il giudice aggira il problema chiedendo al perito già in sede di perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell'imputato (dalla quale deriva l'imputabilità), di pronunciarsi anche sulla pericolosità sociale, badando bene a non valicare i limiti imposti dall'art. 220 c.p.p. (87). Con tale stratagemma si “anticipa” la questione, rischiando di confondere due valutazioni diversissime tra loro, nella perizia sull'imputabilità il giudice chiede infatti al perito di «operare una diagnosi e, dunque, di valutare i complessi patologici del soggetto» (88), nella perizia sulla pericolosità al perito viene chiesta una prognosi, per la quale, paradossalmente, il legislatore non rinvia a scienze sociali e psichiatriche, bensì a criteri in tutto e per tutto giuridici, più precisamente, come previsto ex art. 203.2 c.p. ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e quindi: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:
- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».
Provocatoriamente si potrebbe affermare che la legge chiede al perito di sostituirsi al giudice, per di più usando gli stessi suoi parametri.
Il rischio è che il concetto di pericolosità sociale perda totalmente ogni scientificità non potendo trovare metodi di accertamento predittivi e falsificabili (89), acquisendo «lo stesso grado di certezza del lancio di una moneta o di un tiro a dadi» (90).
Ad oggi i tre metodi conosciuti e utilizzati per stabilire il grado di pericolosità di un soggetto sono l'intuitivo, il clinico e lo statistico (91).
Il metodo intuitivo è, tra i tre, quello che presenta un grado di scientificità più basso, poiché valuta fattori culturali e sociali (l'esperienza di vita del soggetto, l'ambiente dove vive ed è cresciuto, la rete di relazioni) che poco si addicono ad una perizia. Il rischio più grosso è che nel giudizio si soggettivizzi la personalità dello psichiatra perito piuttosto che quella del soggetto.
Il metodo clinico ricorre all'osservazione ed alla analisi psichiatrica della personalità. In pratica, seguendo questo metodo, le distanze tra perizia psichiatrica e perizia criminologica si accorciano notevolmente e, in determinati casi, si annullano del tutto, è come se il giudizio di pericolosità non fosse altro che un'appendiceconseguenza della valutazione psichiatrica.
Il metodo statistico prende in considerazione i fattori causali su scala generale e cerca di oggettivizzare la prognosi, attribuendo determinati punteggi ai fattori negativi e positivi di predittività. Il limite è che non si deduce soggettivamente qual'è il rischio di recidivanza del soggetto esaminato, ma soltanto quello del suo gruppo sociale di appartenenza, trasformandosi spesso in una sterile generalizzazione.
Occorre quindi una riflessione seria e a-ideologica (o meglio, post-ideologica) sul ruolo delle misure di sicurezza e quindi dello stesso sistema del doppio binario nel nostro ordinamento; liberarsi da pericolose spinte neo-positiviste potrebbe essere un primo importante passo affinché concetti astratti e difficilmente definibili, come quello di pericolosità sociale, vengano plasmati a immagine e somiglianza di un contesto sociale dominato dall'insicurezza.
1.5 Imputabilità, quando teorizzare il problema significa nasconderlo
Quello dell'imputabilità è, a dir poco, il core del diritto penale, poiché rientra nell'ancor più complesso tema della colpevolezza e quindi dell'elemento soggettivo del reato (92). Parafrasando la morale kantiana si può affermare che «l'imputabilità costituisce l'anello di congiunzione tra l'essere della realtà fenomenica e il dover essere del diritto (penale)» (93). È, in definitiva, il recepimento formale dell'idea di persona moralmente cosciente e responsabile di un fatto, dell'uomo cartesiano identificato nella ragione e nella volontà delle proprie azioni.
Il dibattito della dottrina, non solo giuridica e sociologica, ma anche medica, filosofica e politica intorno all'imputabilità, ha dimensioni pari alla sconfinata estensione territoriale dei grandi imperi dell'Antichità, pertanto questa ricerca non ha alcuna pretesa di spingersi alla scoperta degli angoli più reconditi dell'“impero imputabilità”, né di darne una descrizione onnicomprensiva.
Non è questo l'obiettivo, anzi, si intende contestare l'eccessiva attenzione data all'argomento, che più in generale, è sintomatica della tendenza del giurista a concentrasi sui processi e le teorizzazioni della c.d. fase di cognizione, relegando in secondo piano la c.d. fase esecutiva, quasi a voler negare l'evidenza di come le sfide di un sistema penale giuridicamente e eticamente sostenibile passino oggi, anzitutto, dall'applicazione e dalla concreta esecuzione di pene e misure di sicurezza, più che dalla loro concettualizzazione teorica.
Tuttavia, riconoscendo la centralità della problematica dell'imputabilità, si cercherà di fornire un sintetico quadro generale, capace di descrivere le recenti linee di sviluppo in dottrina e giurisprudenza, che potrebbero addirittura portare, in un futuro prossimo, al superamento totale dell'imputabilità, così come descritta dal codice Rocco (94).
Solo uno “shock riformista”, infatti, potrebbe portare a una rivalutazione del comprendere (95) a discapito del classificare: «Cogliere l'essenza della persona umana implica un percorso che non persegua l'obiettivo di mettere ordine e semplificare, che non privilegi criteri classificatori, bensì richiede una sospensione del giudizio. Il modello delle scienze umane esige la posposizione di ogni teoria precostituita per avvicinare la persona nella sua unitarietà ed irrepetibilità fondamentali, per come si presenta l'Altro e per come si declina nel mondo. C'è bisogno quindi di un “modo altro” di porsi di fronte alla sofferenza umana, agita o subita» (96).
Partendo dai fondamentali, occorre anzitutto badare alla lettera della norma, vale a dire all'art. 85 c.p., che statuisce: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere».
È questo il principio generale che lega la possibilità di punire il soggetto alla sua capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti (capacità d'intendere) e all'autodeterminarsi liberamente (capacità di volere).
Il ragionamento è apparentemente semplice: se il soggetto possiede tali capacità, allora egli può legittimamente essere indotto dalla minaccia della pena ad astenersi da questo o quel comportamento; può dunque essere rimproverato per aver scelto di tenere il comportamento criminale, vietato dalla legge penale (97).
Al principio generale, il codice fa seguire le applicazioni concrete, vale a dire i casi in cui la capacità di intendere e volere si intende assente.
Così, come in tema di pericolosità sociale, esistono casi in cui l'incapacità d'intendere e volere è presunta e altri in cui deve effettuarsi un accertamento in concreto, tramite perizia.
Nella prima categoria (c.d. Presunzioni di non imputabilità) rientrano casi legati all'età del reo: ex art. 97 c.p. (98) non è mai imputabile il minore di anni quattordici, mentre, ex art. 98, se il reo è di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, si esige un accertamento in concreto dell'imputabilità.
Nella seconda categoria invece rientrano i casi di (99): vizio totale o parziale di mente (art. 88 e 89), assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti (con la tanto puntigliosa quanto contorta e anacronistica differenziazione tra intossicazione derivata da caso fortuito o forza maggiore ex art. 91 c.p., quella volontaria o colposa ovvero preordinata ex art. 92 c.p., quella abituale ex art. 94 e infine la cronica ex art. 95) e il sordomutismo (art. 96).
Ed ecco, se si cerca di andare sociologicamente oltre la mera statuizione normativa, stagliarsi nuovamente il problema della scientificità. Su quali basi scientifiche si fondano i casi di non imputabilità previsti dal codice?
La risposta più intellettualmente onesta, ma anche più provocatoria, è «nessuna». Il codice, infatti, non fa altro che riflettere ancora una volta precise scelte di politica criminale, creando delle c.d. fictiones giuridiche (100), in alcuni casi apertamente smentite dalla scienza psichiatrica.
Basti pensare, ad esempio, a due casi paradigmatici: il minore di quattordici anni non è in nessun caso imputabile, quando invece è lapalissiano che un adolescente, anche se infra quattordicenne, possa possedere coscienza e volontà tali da scegliere se porre in essere o meno azioni criminali. Tanto è vero che, in altri sistemi giuridici, il limite d'età per l'imputabilità è più basso o del tutto assente: nel Regno Unito è, ad esempio, dieci anni (con l'eccezione della Scozia dove scende addirittura a otto anni). Non vi sono ragioni oggettive per considerare l'adolescente inglese diverso e “più responsabile” del pari età italiano.
In negativo, il codice ex art. 92 considera imputabili coloro che abusano di alcool o assumono sostanze stupefacenti volontariamente o colpevolmente, mentre sono non imputabili ex art. 95 coloro che presentano una intossicazione cronica da alcool o stupefacenti. In concreto, da un punto di vista scientifico, le due situazioni non presentano differenze rilevanti, a cambiare è la valutazione etica e politica.
Ancora una volta occorre constatare che ci troviamo di fronte «non ad un mero concetto giuridico, ma ad un principio intriso di fattori morali e sociali espressione di una concezione filosofica che riconosce nelle azioni umane il requisito fondamentale della libera autodeterminazione della volontà» (101).
Dietro ad un'espressione così apparentemente immediata come quella di capacità di intendere e volere, si cela infatti lo scontro tra due visioni: da una parte la c.d. Teoria del libero arbitrio (o dell'indeterminismo), che sostiene la libertà di scelta e la capacità di autodeterminazione della persona, dall'altra la c.d. Teoria determinista che, invece, sostiene la determinazione aprioristica di ogni azione umana, necessitata e prodotta da cause incontrollabili dall'uomo (motivazioni inconsce, cause biologiche, ingiustizie sociali).
Alla questione fa diretto riferimento il legislatore durante i lavori preparatori del codice penale (102), riguardo allo sfuggente concetto di infermità psichica, causa di esclusione dell'imputabilità: «Basta che colui che ha posto in essere l'azione abbia attitudine psicologica di volere, perché vi sia imputabilità. Si nega dunque il determinismo? Sì e no.
Sì, se per determinismo dell'azione umana si intende quello fisico, meccanico e fisiologico, giacché la volontà umana non si trova di fronte alla casualità, come il grave di fronte alla legge di gravità.
No, se per determinismo si intende il determinismo psicologico. Non si può concepire una volontà senza causa, una volontà senza motivi, una volontà come un fiat che nasca dal nulla, come arbitrium indifferentiae. Di fronte a questi motivi la volontà umana non soggiace in modo fatale, perché l'uomo ha la facoltà di discernere e di selezionare, ed, in definitiva, la volontà non è puramente ricettizia e passiva di fronte ai motivi, ma ha la possibilità di contrapporre un motivo ad un altro» (103).
Persino l'insigne giurista Francesco Antolisei non va oltre la definizione di imputabile come «persona normale, con normale capacità di autodeterninarsi, cioè colui che reagisce normalmente ai motivi ed è persona sana e matura» (104).
Il concetto di normalità è quindi palesemente evanescente e aleatorio. In definitiva si è di fronte ad una scelta: o continuare ad avvilupparsi intorno ad un dibattito infinito sul libero arbitrio, proseguendo lo scontro secolare tra deterministi e indeterministi, oppure andare oltre e riconoscere alla libertà di intendere e volere il valore di postulato della ragion pratica e, pertanto, considerare l'imputabilità parametro di convivenza tra le persone a cui è attribuita pari dignità di soggetti. L'imputabilità si trasformerebbe in mera convenzione sociale, importante, da una parte, per la società, perché agevola e favorisce la convivenza pacifica, dall'altra, per l'individuo, che sa se e quando è “assoggettabile” ad una pena.
Ma è importante sopratutto per il diritto, poiché, finché non verrà legislativamente sancito il suo superamento, continuerà ad avere la fondamentale triplice funzione, sottolineata dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9163/05:
- di principio costituzionale, ex art. 27, in cui si stabilisce la personalità della responsabilità penale, intendendo, secondo l'interpretazione della Corte, sia la non responsabilità per fatto altrui, sia che il fatto personale è quello ascrivibile al soggetto sotto il profilo della sua coscienza e volontà (la c.d. suitas della condotta).
- di categoria dogmatica del reato.
- di presupposto e criterio guida della sanzione penale.
Una volta accennato alle problematiche definitorie dell'imputabilità, occorre ora soffermarsi sull'accertamento. Anzitutto va rilevato che esistono tre modelli possibili per addivenire ad un giudizio sulla capacità di intendere e volere (105):
- Il modello psicopatologico puro (o biologico puro). La non imputabilità deriva dall'essere affetto da quelle date gravi malattie, specificamente indicate dal codice, senza avere riguardo all'incidenza della malattia stessa sulla capacità di intendere e volere. La critica rivolta a tale metodo si concentra sulla automatica assimilazione tra malattia mentale ed incapacità di intendere volere.
- Il modello normativo puro (o psicologico puro). È un modello scarsamente diffuso, poiché slega del tutto l'infermità psicofisica dall'imputabilità, prescindendo da qualsiasi dato empirico e scientifico, con il rischio di costruire un accertamento metafisico e aprioristico.
- Il modello psicopatologico-normativo (o misto). È il modello più diffuso, adottato dalla maggior parte dei Paesi europei (Italia compresa). Prevede una sorta di “doppio accertamento”, il primo è di carattere clinico, vine svolto dal perito a cui viene chiesto di accertare l'esistenza e l'entità di una psicopatologia, il secondo, che prende le mosse dalla perizia, ma non si conclude in essa (106), tendente ad accertare il grado di incidenza che il disturbo mentale ha avuto, al momento della commissione del fatto, sulla capacità di intendere e volere del reo. In pratica, tale modello vuole tracciare dei confini precisi: alla scienza psichiatrica il compito di individuare i requisiti biopsicologici in presenza dei quali il soggetto può dirsi capace; alla scienza giuridica spetta la fissazione della rilevanza dei dati clinici, valutando gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legge.
Occorre ora soffermarsi più approfonditamente sui concetti di vizio di mente e vizio parziale di mente, poiché sono i casi che afferiscono maggiormente alla problematica dell'istituzione totale O.P.G.
Pensare che i già citati art. 88 e 89 c.p. non creino problemi interpretativi e applicativi è una mera illusione, soprattutto alla luce della sentenza n. 9163/05 Sezioni Unite, a suo modo rivoluzionaria.
Ma procediamo con ordine e sottolineiamo anzitutto, a partire dalla lettera della norma i punti di maggior criticità. L'art. 88, rubricato vizio totale di mente statuisce: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere».
L'art. 89 riguarda la controversa figura del vizio parziale di mente e statuisce: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».
I due articoli hanno un termine in comune: infermità. E proprio da qui si dipanano le ambiguità.
Il legislatore, scegliendo quel termine, ha optato per una precisa tecnica legislativa, quella della c.d. clausola generale, creando una norma “aperta” capace di adattarsi nel tempo alle varie interpretazioni psichiatriche, sociologiche e giuridiche.
Ma l'estrema duttilità, oltre all'indubbio pregio, di creare una norma, per usare un linguaggio esemplificativo, ma poco tecnico, ever green, capace di recepire le nuove acquisizioni scientifiche e culturali, ha più di un difetto: l'impossibilità di generare un concetto unitario e generalmente valido della nozione, ma soprattutto il rischio concreto della presenza di un elemento extragiuridico, che necessita di parametri valutativi di matrice psichiatrica, che, al pari del diritto, è scienza tutt'altro che univoca e coesa.
Spesso nelle aule di giustizia si realizza quella previsione negativa di autorevole dottrina psicopatologica forense: «Massima discrezionalità significa assenza di paradigmi e parametri di valutazione. Ogni asserzione può quindi trovare credito, non esiste più alcuna certezza, tutto è possibile. È questo il momento in cui compaiono le più disturbanti ingiustizie» (107).
È proprio come tentativo di porre fine a tante ingiustizie e ambiguità che si può leggere la già citata “rivoluzionaria” sentenza n. 9163/ 2005 Sezioni Unite.
Fino ad allora la dottrina si presentava divisa tra una maggioranza, che considerava infermità le sole malattie mentali in senso stretto e cioè quelle clinicamente accertabili, e una minoranza, che invece faceva rientrare tra le infermità anche i gravi disturbi della personalità, nevrosi e psicopatie (108), purché si manifestassero con un elevato grado di intensità, tanto da incidere sulla sfera volitiva del soggetto, sottraendoli così alla categoria degli “stati emotivi e passionale” che per espressa previsione legislativa (art. 90 c.p.) non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
La prima corrente di pensiero favorevole ad un allargamento del concetto di infermità era la c.d. Antipsichiatria, che in Italia, come vedremo, avrà in Franco Basaglia e i suoi allievi e colleghi della Scuola di Trieste, i più autorevoli esponenti. Negli anni Settanta conducono una vera e propria battaglia culturale (ed anche linguistica) contro il concetto di malattia mentale, che non sarebbe altro che una malattia sociale, causata dal disagio e dall'esclusione sociale e non da un elemento organico o psicopatologico.
Le Sezioni Unite, in definitiva, sciolgono gli attriti e accolgono, con quasi trent'anni di ritardo, l'orientamento storicamente minoritario. L'infermità diventa concetto più allargato, che al suo interno non comprende soltanto le malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, purché il giudice svolga un accertamento in concreto, per capire se essi hanno effettivamente escluso e scemato grandemente la capacità di intendere e volere.
Ma ad una “apertura” segue, paradossalmente, una “chiusura”: imponendo l'accertamento in concreto, il giudice di legittimità ribadisce la necessità di un nesso eziologico tra infermità e il fatto di reato. È proprio in questo fondamentale passaggio che si consuma la rivincita del diritto sulla psichiatria, poiché il giudice, e solo il giudice, ha gli strumenti per valutare se sussista il richiesto nesso eziologico. In definitiva o l'azione criminosa è direttamente causata dall'infermità mentale o il soggetto è imputabile.
Dopo quasi trent'anni, la sentenza n. 9163/05 Sezioni Unite non fa altro che dare accoglienza giuridica ad uno dei principi ispiratori della grande riforma psichiatrica basagliana (l. 180/1978, su cui avremo modo di ritornare più diffusamente nel prossimo capitolo), quello delle c.d. quote di responsabilità: solo responsabilizzando l'infermo di mente si può davvero ambire ad una sua risocializzazione (109).
Stiamo forse procedendo lenti ma inesorabili, almeno per quanto riguarda la fase di cognizione e di accertamento dell'illecito penale, verso lo scardinamento definitivo di quell'inossidabile e deleterio automatismo del soggetto infermo di mente, quindi non imputabile, quindi pericoloso? Così pare. Ma gli sforzi sono ancora molti, perché la vera sfida è concretizzare tale scardinamento, trasponendolo nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza. In caso contrario rimarrà sterile intellettualismo e rivoluzione in potenza. Ma Diritto e Etica pretendo, con urgenza, un passaggio all'atto.
1.6 Prima escono i cavalli, poi gli uomini (110). Breve storia di un'istituzione totale
Sarebbe peccato originale approcciare la problematica dell'O.P.G e del suo superamento senza conoscere la storia e l'evoluzione delle istituzioni totali.
Ineludibile è quindi il richiamo teorico ad un grande maestro della sociologia moderna, Erving Goffman e in particolare alla sua opera più popolare ma anche più controversa: Asylums, le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza (111), «uno di quei testi che trascendono il proprio ambito disciplinare e segnano una tendenza, se non un'epoca, della cultura» (112).
Vista la mole di scritti, studi e ricerche ispirati da quest'opera, è impresa ardua evitare la banalità; tuttavia resta imprescindibile la base metodologica data dal sociologo canadese e quella ossessiva consapevolezza di compiere, analizzando le istituzioni totali, un esercizio morale, più che una vuota esercitazione empirica: rovesciare cioè la pretesa che le istituzioni dettino la loro logica alle scienze sociali, ma piuttosto “far parlare”, attraverso la rievocazione sociologica di semplici gesti, la dimensione tipicamente umana della resistenza all'oppressione, anche quando questa, come nel caso degli O.P.G., si manifesta nelle forme più neutrali, organizzate e sadicamente scientifiche.
Insomma, parlare di O.P.G. come istituzione da un lato e come “contenitore di umanità” dall'altro, partendo dal sostrato teorico di Goffman, non è solo una scelta metodologica, ma un atto di resistenza o, per lo meno, una presa di coscienza e soprattutto una necessità del giurista contemporaneo. Non possiamo arrenderci infatti all'idea che cotanti insegnamenti, così valorizzati nel passato recente (113), siano ora sopiti sotto una coltre postmoderna e a-ideologica.
Abbiamo oggi una possibilità unica: riscoprire (o meglio risvegliare) gli insegnamenti della sociologia anti-istituzionale con più libertà, scevri da quelle gabbie di pensiero e di preconcetti che hanno caratterizzato le interpretazioni del Sessantotto europeo, avendo l'onestà intellettuale di ammettere dove si è esagerato, dove il passo è stato troppo lungo o troppo corto. I capitoli che seguono saranno un piccolo contributo di onestà, consapevoli dell'«urgenza dell'adesso» (114) imposta dall'insostenibile condizioni in cui versa il sistema sanzionatorio dei folli-rei.
Urge quindi tracciare ora le caratteristiche dell'istituzione totale goffmaniana, per costruire così le basi teoriche necessarie a descrivere la storia dell'O.P.G in Italia, a partire dal 1876 (anno di apertura del primo “Reparto per maniaci” nell'ex convento di San Francesco di Aversa) ad oggi.
Irving Goffman parte dal dato di realtà che la vita dell'uomo si svolge in gran parte all'intero di istituzioni (o organizzazioni sociali), «ognuna delle quali si impadronisce di parte del tempo e degli interessi che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo e tendendo quindi a circuire i suoi componenti, in una sorta di azione inglobante» (115).
La pervasività di un'istituzione si misura appunto nell'intensità di tale azione inglobante. La massima intensità viene raggiunta, in quelle che Gofmann definisce istituzioni totali, poiché in questi luoghi vengono quasi totalmente, anche fisicamente, impediti gli scambi sociali con l'esterno.
Ne esistono di cinque tipologie (116):
- A tutela di incapaci non pericolosi (gli orfanotrofi, le case di riposo per anziani o diversamente abili)
- Per incapaci, che, anche se non intenzionalmente, rappresentato un pericolo per la comunità (i lebbrosari, gli ospedali psichiatrici)
- Per coloro che sono intenzionalmente pericolosi per la società (il benessere delle persone segregate non è l'immediata e preminente finalità dell'istituzione stessa, vi rientrano campi di concentramento, carceri, campi per prigionieri di guerra).
- Istituzioni create al solo scopo di svolgervi una certa attività (la loro giustificazione è di tipo strumentale, vi rientrano le navi, i collegi, le piantagioni coloniali)
- Le istituzioni staccate dal mondo (vi rientrano tutti i luoghi di raccoglimento spirituale e preghiera, come monasteri, conventi, eremi)
Al di là della completezza o meno della categorizzazione, che, a detta dello stesso Gofmann, non è nulla di più di una rappresentazione empirica, quel che conta è il fatto che le istituzioni totali tendono a rompere le tre classiche «sfere di vita»: frequentare luoghi diversi, persone diverse e, in ultimo, essere sottoposti a diverse autorità, senza alcun schema razionale di carattere globale.
Nell'istituzione totale avviene l'esatto opposto: si stà sempre nello stesso luogo, in compagnia sempre delle stesse persone e eterodiretti da schedature orarie rigide e ripetitive, tendenti a «manipolare molti bisogni umani per mezzo dell'organizzazione burocratica».
L'invasività dell'istituzione sulla vita dell'internato è talmente elevata, da poter, per gli internamenti più lunghi, trasformarsi in una vera e proprio disculturazione (117), cioè l'incapacità di affrontare le normali situazioni della vita quotidiana “esterna”.
In realtà quello di “disculturizzare” (ma potremmo dire “disadattare”) l'internato non è un obiettivo esplicito dell'istituzione, sarebbe eccessivamente sadico, anzi spesso esse si pongono, almeno sulla carta, l'obiettivo opposto, cioè quello di risocializzare o rieducare. «Esse si limitano a creare e sostenere un tipo particolare di tensione fra il mondo famigliare e esterno e quello istituzionale e interno, che usano come leva strategica nella manipolazione degli uomini».
L'umiliare, il degradare, il punire, il profanare, l'abbruttire sarebbero tutte azioni che mirano a modificare profondamente il sé dell'internato, andando a creare un taglio netto tra ciò che il soggetto era “prima” e ciò che è “dopo” l'entrata nell'istituzione.
La mortificazione dell'internato è infatti la caratteristica della prima fase della permanenza nell'istituzione: più è dura ed evidente, più il distacco tra il sé dell'internato e il mondo esterno sarà traumatico. Vale la pena capire in che modo, su un piano sociologico, si svolge tale mortificazione, potremo così, in seguito, fare un confronto con ciò che avviene nelle istituzioni totali al centro di questa ricerca (l'O.P.G., le comunità terapeutiche e i reparti di osservazione psichiatrica all'interno delle carceri) (118).
Goffman suddivide la problematica della mortificazione, in tre passaggi consequenziali:
- «Le istituzioni totali spezzano o violentano proprio quei fatti che, nella società civile, hanno il compito di testimoniare a colui che agisce e a coloro di fronte ai quali si svolge l'azione, che egli ha un potere sul suo mondo, che egli è sostanzialmente persona che gode di autodeterminazione, autonomia e libertà di azione “adulte”» (119). Nella vita fuori dall'istituzione, in linea di massima, l'individuo sceglie se amare, odiare, essere indifferente, sceglie autonomamente quando svegliarsi, lavarsi, andare a dormire, parlare o stare in silenzio. Tutto questo è, banalmente, l'autodeterminazione e tutto questo, nell'istituzione, non è scelto, ma subito e imposto.
- L'internato a forza di non essere considerato “adulto” e in grado di autodeterminarsi, è pervaso da un senso di impotenza, che, paradossalmente, lo porta ad affidarsi totalmente all'istituzione, anche se i suoi desideri non coincidono affatto con le finalità dell'istituzione stessa. Si verifica insomma una graduale perdita di autonomia, che, a lungo andare, porta al terzo e ultimo passaggio della mortificazione.
- La continua e reiterata aggressione del sé provoca «un acuto senso di tensione», o, per usare un termine mutuato dal linguaggio scientifico, lo stress, poiché si realizza che il proprio sé viene minacciato e si ha paura di non riuscire a sopportare l'istituzione totale stessa. Tale condizioni di stress può portare a due reazioni opposte, da una parte, l'autolesionismo (o, nei casi più gravi, il suicidio), perché il livello d'ansia e di frustrazione è divenuto insopportabile, dall'altro, potrebbe scattare la c.d. vendetta dell'internato, «dopo essere stato soggetto ad un'ingiustizia, ad una punizione eccessiva o comunque ad un trattamento giudicato troppo severo o umiliante, l'internato stesso inizia ad avere un irrefrenabile desiderio di vendetta, che, consciamente o inconsciamente, considera il “giusto prezzo” della vessazione subita. È con questa decisione di vendicarsi che egli diventa un criminale» (120).
C'è una terza reazione possibile, l'adattamento, che a sua volta assume diverse forme: la regressione, cioè una sorta di apatia e accettazione in cui «l'internato ritira apparentemente l'attenzione da tutto, riducendola ai soli eventi relativi al proprio corpo» (121), la linea intransigente, cioè il rifiuto dell'istituzione e quindi di ogni tentativo di cooperazione con il personale e con gli altri internati, la colonizzazione, cercare, per spirito di sopravvivenza, di costruirsi un'esistenza sostenibile e quanto più possibile felice all'interno dell'istituzione, la conversione, quando l'internato decide di vestire la maschera del “perfetto internato”, sforzandosi di mostrare al personale il suo “entusiasmo istituzionale”. Ovviamente tali forme di adattamento raramente si presentano come pure, più realisticamente si contaminano e vengono usate dai singoli internati con tempi, modalità e intensità differenti.
Nello specifico degli ospedali psichiatrici (e quindi, nel caso di specie, dell'O.P.G.) c'è da aggiungere la problematica legata alla malattia che, oltre ad essere un dato medico reale, viene trasformata in un fatto sociale, dato ciò che ne è stato fatto, il significato che le è stato dato, l'etichetta che le è stata apposta: i malati di mente diventano così «il terzo mondo all'interno del mondo occidentale» (122).
I folli si trasformano, incolpevolmente, «nelll'oggetto di una violenza originaria, familiare, sociale e istituzionale, essi vengano travolti dal vortice degli inganni» (123); un vortice aggravato, o meglio giustificato, dalla scienza che li etichetta come malati. Ma Franco Basaglia sa essere ancora più tranchant: «Che il negro sia negro è indiscutibile, così come è indiscutibile che esistano le malattie mentali, anche se gli psichiatri non conoscono nulla della loro natura. Ma ciò che ha fatto il negro, quello è stato finora, ha poca relazione con il suo essere nero, così come ciò che ha dato al malato la faccia che tuttora ha, ha poco a che fare con la malattia.
L'esclusione -come fatto sociale -di cui il negro è oggetto in una società razzista, che ha bisogno di sfruttarlo per sopravvivere, è ciò che determina il negro come inferiore e selvaggio, esattamente come l'esclusione di cui il malato di mente è oggetto nella nostra società è ciò che lo determina come inferiore e pericoloso» (124).
Sono passati più di tre decenni da quando queste parole durissime venivano scritte e il lavoro di Gofmann pubblicato: cosa è cambiato?
Ora che abbiamo conosciuto l'istituzione totale da un punto di vista teorico-concettuale, occorre scoprirla sul piano storico e giuridico. Anno dopo anno, si stanno per ricostruire le complesse vicissitudini di un luogo come l'O.P.G. (125), dove per chi vi è ristretto «la vera punizione non è la perdita della libertà, ma il passare del tempo. E non perché scorra lento, ma perché il tempo scorre tutto uguale e i giorni ti si appiccicano addosso uno dopo l'altro, come una zavorra sempre più pesante» (126).
1.6.1 1876: I maniaci di Aversa
Nasce ad Aversa la prima “Sezione per maniaci”, all'interno della locale casa penale per invalidi. Poteva ospitare diciannove persone nell'ex convento del Cinquecento di San Francesco da Paola. L'evento, raccontano le cronache dell'epoca (127), sorprese parecchi addetti ai lavori, sia per le modalità (fu istituito con un semplice atto amministrativo autonomo della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, all'epoca coordinata da Beltrani Scalia, senza darne avviso alla neonata amministrazione statale centrale), sia perché fu considerata una fuga in avanti rispetto al florido dibattito in dottrina, dominato dalla Scuola positiva lombrosiana.
Filippo Saporito, psichiatra, considerato il vero e proprio “padre” del manicomio giudiziario di Aversa che diresse dal 1907 (128), succeduto a Gaspare Virgilio, giustificava così la scelta (129): «Accadeva, infatti, che ogni qualvolta l'Amministrazione della giustizia e quella delle carceri si facevano a bussare alle porte di un manicomio comune, per chiedere ospitalità pei delinquenti impazziti, non ne ottenevano che rifiuti. Quei speciali inquilini, nei manicomi comuni, andavano a rappresentare scene di terrore, che vi portavano lo scompiglio».
Ma il tema dei folli-rei (e soprattutto quello dei rei-folli, cioè coloro che davano segni di squilibrio da reclusi nelle “carceri ordinarie”) non era affatto dimenticato, lo stesso Lombroso ipotizzò la nascita di almeno un manicomio giudiziario con una capienza minima di trecento internati. Correva l'anno 1872 e per la prima volta il termine manicomio giudiziario entrò prepotentemente nel dibattito politico, medico e giuridico italiano. Il presupposto teorico dello studioso torinese era dato dalla constatazione che «tra i delinquenti ve n'è tanti per cui la prigione è un'ingiustizia, la libertà un pericolo, a cui mal si provvide da noi (in Italia, N.d.A.) con mezze misure che violano ad un tempo la morale e la sicurezza».
È in nuce, la prima fase di un percorso che porterà al già visto (130) sistema del doppio binario, in cui la pena si possa trasformare da vendetta-punizione a difesa sociale. Era questo il “nocciolo duro” del pensiero lombrosiano: una pena che tenesse conto da una parte della tipologia dell'autore, dall'altra della sua funzione generalpreventiva (131).
Ma Lombroso andava oltre al semplice teorizzare e declinava concretamente la proposta di un futuribile manicomio giudiziario, anzitutto elencando il profilo giuridico e psicopatologico degli internati e quindi accennando all'organizzazione: «Vi dovrebbero essere internati: tutti i servi di pena impazziti, e con tendenze pericolose incendiarie, omicide od oscene, dopo trascorso lo stadio acuto del male. Tutti gli alienati che, per tendenze omicide, incendiarie, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione.
Tutti quelli imputati di crimini strani, atroci, senza un movente chiaro, o con un movente sproporzionato al delitto. Quelli che furono spinti al delitto da un abituale, evidente infermità, come: pellagra, alcoolismo, epilessia; massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici, e presentino una mala costruzione del cranio (132). Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una parte della loro esistenza nei vizi, nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti. Gli altri alienati non saranno riuniti che in piccoli gruppi, a seconda dei ceti e delle abitudini; dormiranno ciascuno in una cella; la disciplina dovrà essere severa, la vigilanza maggiore che nei manicomi comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato alle forze, all'aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti...
La direzione dovrebbe essere medica, il personale carcerario. Gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi, e già sottoposti a vari processi, non potranno essere dimessi mai; gli alienati a follia istantanea, od intermittente, che offrano segni di perfetta guarigione, saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti, dopo la loro uscita, a visite mediche mensili per molti anni di seguito» (133).
Interessante notare come alcuni problemi affrontati da Lombroso (le categorie di internati da destinare ai manicomi giudiziari, la composizione del personale, medica o giudiziaria, la durata dell'internamento, la direzione, la natura stessa della struttura, ospedale o istituto di pena), non sono altro che le stesse questioni che ancora oggi, ad oltre un secolo di distanza, arrovellano il legislatore e gli operatori del settore, ma su questo vi sarà modo di tornare.
Tuttavia va sottolineato come la sezione per maniaci di Aversa era all'interno di un istituto di pena e non di un manicomio civile e quindi rimaneva lontana dall'idea lombrosiana di “manicomio giudiziario”, poiché destinata ad accogliere i soli rei-folli, già condannati e riconosciuti delinquenti dall'autorità giudiziaria. La struttura di Aversa, per le sue caratteristiche, si avvicina maggiormente a quelli che Lombroso chiamava comparti per condannati impazziti (134) da istituirsi all'interno delle carceri.
1.6.2 1890: Il codice Zanardelli e il vizio di mente
Il 1º gennaio entra in vigore il primo codice penale dell'Italia unita, meglio noto come codice Zanardelli (135). Nel nuovo testo non si parla mai dei manicomi giudiziari, ma si introduce la novità importante della non imputabilità per vizio di mente, che avrebbe avuto effetti diretti sul trattamento dei folli-rei. L'art. 46 sancisce infatti: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge».
La strategia del legislatore sembra chiarissima: far uscire il folle-reo dal “circuito penale”, visto che, in nome di una concezione monistica-retributiva della pena, non si poteva occupare, di chi, come il folle, era privo di libero arbitrio a causa della malattia mentale.
Non è dato sapersi se tale soluzione extrapenale fu dettata da motivazioni etiche (v'era forse una sorta di “comprensione” per il malato psichiatrico, per cui sembrava ingiusto punirlo come gli altri?), politiche o, più biecamente ma realisticamente, opportunistiche. «L'istanza giudiziaria demanda all'operatore e alle istituzioni della psichiatria una quota di controllo disciplinare» (136): si realizza così quel passaggio di competenze (e conseguentemente, di responsabilità), dal soggetto penale a quello extrapenale, che si era «piazzato come sentinella di un ordine che è quello della società nel suo insieme» (137).
In concreto, seguendo le disposizioni attuative del codice penale contenute nel Regio Decreto 6509 del 1º dicembre 1889, si prevede che la Corte d'Assise provveda con ordinanza motivata a consegnare il prosciolto all'autorità di Pubblica Sicurezza, che ordina il ricovero in un manicomio civile in stato di osservazione, sino a quando il Presidente del Tribunale civile, su istanza del Pubblico Ministero, ed assunto le opportune informazioni, non disponga o il ricovero definitivo in manicomio o la liberazione del prosciolto per infermità mentale.
In realtà il decreto si spinge oltre e prevede, ex art. 14, che l'ordine di ricovero definitivo possa essere revocato anche dalla stessa autorità che lo ha posto in essere, qualora si sia verificato un mutamento delle circostanza; si prevede anche che il prosciolto folle, invece di essere internato in manicomio, possa essere affidato ad una persona con sufficienti garanzie, disposta ad assumerne la cura e la custodia (138).
Per quanto riguarda l'internamento del prosciolto folle, ex art. 46, la legge penitenziaria (Legge n.6165 del 14 luglio 1889) prevede che sia internato in apposite sezioni dei manicomi civili e che il direttore del manicomio invii rapporti trimestrali sul comportamento del soggetto e sul decorso dell'internamento al Presidente del Tribunale civile, che ha ordinato l'internamento stesso, per indagare se vi siano gli estremi per una revoca dell'ordine.
Nel silenzio della legge penale, e in attesa di un codice sostanziale che disciplini i nascenti manicomi giudiziari, la legislazione e gli attori del mondo del diritto extrapenale portano quindi avanti le loro proposte, noncuranti dei tentativi (falliti) di riportare nell'alveo esclusivo del diritto penale la tematica dei folli-rei.
Il tentativo principale porta la firma dello stesso ministro Zanardelli, che tenta invano di convincere i colleghi deputati ad aggiungere un secondo comma all'art. 46, in cui si sarebbe stabilita la competenza esclusiva del giudice penale ad ordinare il ricovero del prosciolto. «Da troppo tempo e da troppe parti si chiede, a ragione, che gli autori di fatti criminosi, ove siano dichiarati non punibili per infermità mentale, non vengano rimessi in libertà ed abbandonati a loro stessi, con grave rischio della insicurezza sociale. Occorre porre tali sventurati nella impossibilità di nuocere, ed in pari tempo assicurare loro quella assistenza e quella cura che l'umanità impone. L'iniziativa di tale provvedimento uscirebbe veramente dalla competenza tecnica del giudice penale, ma ragioni di economia amministrativa e di opportunità politica, mi hanno indotto ad attribuire allo stesso magistrato, che conosce il fatto e la persona, la facoltà che questa sia ricoverata in casa di salute, nel momento stesso in cui la dichiara prosciolta da ogni imputazione penale» (139).
1.6.3 1891: «Signor Ministro, abbiamo un problema!»
Il Ministro dell'Interno promuove un'ispezione nei 61 manicomi del Regno (140), che contenevano 24.118 persone registrate ma, verosimilmente, superavano le 25.000, visto l'alto numero di soggetti “sconosciuti” alle statistiche ufficiali e l'arretratezza degli strumenti di calcolo. Solo due erano i “manicomi criminali”: Montelupo Fiorentino e Aversa. A coordinare i lavori erano stati chiamati tre personaggi di primissimo piano: Cesare Lombroso, Pietro Tamburini e Filippo Ascenzi. Nella relazione finale essi denunciarono, però, gravi problemi di gestione di tali strutture e individuarono sei problemi salienti:
- l'affollamento degli istituti manicomiali (o, per usare l'espressione originale, «l'accumulo grande»);
- dalla mancanza di una legislazione unitaria, valida e omogenea per tutte le regioni italiane;
- «la nessuna cura e tutela per gli averi degli alienati, una volta reclusi nei manicomi»;
- «la nessuna efficace sorveglianza sui manicomi tanto pubblici, quanto privati», il riferimento è all'assenza di organi indipendenti che potessero dare continuità alla cura, una volta che l'internato veniva dimesso e relazionassero su eventuali (ma frequentissimi) abusi e malfunzionamenti, la proposta della commissione era quella di copiare il modello inglese, dove già allora esisteva una sorta di magistrato di sorveglianza, incaricato di seguire il percorso penitenziario (in questo caso, manicomiale) del soggetto;
- dalle grandi disparità di trattamento ed organizzative tra i diversi manicomi nonché dall'inadeguatezza della direzione dei manicomi criminali esistenti.
- Il sesto rilievo riguarda specificamente i due manicomi giudiziari: a differenza di quanto si possa pensare, vista l'entrata in vigore dell'art. 46 del nuovo codice penale, «solo uno o due imputati prosciolti vi sono stati reclusi», un numero irrisorio rispetto alla totalità degli internati. Questo significa, non solo che l'art. 46 non ha prodotto alcun risultato concreto, ma che l'istituzione stessa del manicomio giudiziario, com'è era stata proposta da Lombroso stenta a prendere forma (141). Insomma a Montelupo e ad Aversa continuavano ad essere internati solo i rei-folli («i condannati impazziti e i giudicabili») e non i folli-rei.
Urge, dunque, una legislazione specifica e stringente. Ufficialmente è il Regio Decreto del 1 febbraio 1891, contenente il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, a utilizzare per la prima volta il termine manicomio giudiziario e a stabilire quali sono le cinque tipologie di persone che dovono esservi internate:
- ex art. 469: per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomi giudiziari, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura.
- ex art. 470: I condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinari, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocumento alla disciplina interna. Nel qual caso si procederà al loro immediato trasferimento nei manicomi giudiziari.
- ex art. 471: gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l'art. 14 del r.d. 1 dicembre 1889, n. 6509 sono trasferiti, con decreto del ministro dell'Interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un Manicomio giudiziario, ma in sezioni separate.
- ex art. 472: Nelle sezioni indicate nell'art. precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del ministro dell'Interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell'art. 13 r.d. 1 dicembre 1889, n. 6509, debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in istato di osservazione.
- ex art. 473: Sopra apposita domanda dell'autorità giudiziaria, possono essere ricoverati in una sezione speciale dei manicomi giudiziari, anche gli inquisiti in istato di osservazione. L'assegnazione è fatta per decreto del ministro dell'Interno.
Indipendentemente dal dibattito politico e culturale, i manicomi criminali non sono strutture concretamente sanitarie: sebbene destinati ad un uso profilattico rispetto al crimine, vengono usati come luoghi per la gestione punitiva della follia criminale. Sono gestiti da un Direttore amministrativo come tutti gli stabilimenti di pena ordinari (e non da un Direttore Sanitario, che era previsto, ma doveva occuparsi solo dell'ambito terapeutico, non avendo, almeno formalmente, nessuna parola in capitolo rispetto all'organizzazione generale dell'istituto) e mediante un Regolamento che non differisce in alcun punto da quello carcerario.
Non viene realizzata insomma la non afflittività del manicomio criminale, unica vera differenza, in teoria, fra segregazione carceraria e manicomiale.
Interessante a tale proposito una relazione fatta dal Direttore Sanitario di Aversa, pubblicata nel 1900 (142):
Quivi il trattamento alimentare è uguale a quello delle carceri, i giacigli sono gli stessi che si accordano ai detenuti, la disciplina, se non è più rigorosa, non è certo informata e subordinata alle speciali condizioni dei reclusi, e quel che è peggio, vi fanno assoluto difetto i mezzi igienico-terapeutici, che sono indispensabili al trattamento degli psicopatici; difetto che, peraltro non reca altrimenti meraviglia, quando si sappia che la direzione di questi particolari istituti è disimpegnata ad un profano di psichiatria, e che il servizio sanitario è ristretto alla ben limitata orbita di azione in cui possono spaziare i medici addetti ai comuni penitenziari.
Filippo Saporito, anch'egli psichiatra ad Aversa, è ancora più duro nel suo giudizio: «I manicomi criminali non erano che pessime carceri [...] Erano luoghi in cui, quasi meccanicamente, dalle case di pena veniva ad affluire tutto ciò che esse contenevano di più torbido, le personalità che riuscivano più inadattabili al comune regime, superando, con la loro condotta, la mal concepita efficacia dei mezzi disciplinari: una specie di casa di rigore elevata alla massima potenza, di cui lo istrumento principale era il così detto guardamatto: un criminale in veste di infermiere» (143).
Il manicomio criminale è insomma qualcosa di molto diverso da ciò per il quale venne ideato; ma occorre aspettare pochi anni perché la malattia mentale venga presa in considerazione dal legislatore con una disciplina organica e compiuta.
1.6.4 1904: La prima legge sui manicomi
L'ansia riformatrice prodotta da una parte dal custodialismo terapeutico della psichiatria e dall'altro, dal custodialismo difensivo della giustizia penale, sono il contesto culturale in cui si approva la legge n. 36 del 14 febbraio 1904, che arriva con settant'anni di ritardo rispetto alla Francia (primo Paese europeo ad approvare una norma specifica sugli alienati, il 30 giugno 1838), venticinque anni dopo un dibattito infuocato e sei disegni di legge bocciati. Fortemente voluta dall'allora Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, viene stroncata dall'illustre dottrina psichiatrica forense (144): «I primi progetti erano tutti migliori di quello poi approvato», che sarebbe una edizione peggiorativa di un motuproprio granducale, vigente ancora per tradizione in Toscana dal 1838. In effetti la Legge 14 febbraio 1904, n. 36, intitolata «Disposizioni sui manicomi e sugli alienati», è composta di soli undici articoli nei quali ci si limita ad indicare sommariamente le norme di ammissione e di dimissione dal manicomio, a determinare i compiti del direttore, a ripartire le spese e a prevedere un meccanismo di controllo, lasciando al regolamento, successivamente emanato, di regolare nella sostanza la materia. Si rimane, per convenienza politica, su un piano squisitamente organizzativo, evitando di affrontare le vere questioni salienti della problematica manicomiale.
L'art. 1 dispone: «Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé e agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano o non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi».
Fondamentale è il secondo comma: «Sono compresi sotto questa denominazione [di manicomio, N.d.A], agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere».
Sorprende la forte omogeneità con cui si affrontano le discipline dei malati di mente autori di reato e di quelli non autori di reato, le uniche differenza erano la denominazione degli istituti (manicomi giudiziari per i primi, manicomi comuni o civili per i secondi), e la previsione per gli internati in manicomio giudiziario dei, già previsti, rapporti trimestrali all'autorità giudiziaria sulle condizioni sanitarie dei ricoverati.
Differenze poco sostanziali, che sanciscono la vittoria della sicurezza sulla cura: la psichiatria, complice l'ossequiosa omertà del diritto, impone l'istituzionalizzazione della malattia mentale considerata anzitutto come fattore di pericolosità da contenere, più che da curare, poiché la segregazione stessa diventa modalità di cura (145).
L'obbligo giuridico di custodire il malato di mente insorge solo dopo che questi abbia dato prova della propria pericolosità, o abbia turbato l'ambiente sociale dando pubblico scandalo. Nota saggiamente Rebagliatti (146) che tali disposizioni, «se, nel tempo in cui furono promulgate, costituirono un sistema organico e progredito di organizzazione assistenziale, tuttavia furono dominate da preoccupazioni di difesa della società» nei confronti di soggetti diversi e pericolosi, cosicché l'internamento «veniva ad atteggiarsi come una vera e propria misura di prevenzione» (147) molto vicina alle misure di sicurezza che saranno previste, di qui a pochi anni, dal codice Rocco. Di conseguenza, per tutti i malati di mente che non manifestino la loro malattia in modo tale da far temere per l'ordine pubblico, è del tutto escluso il ricovero in manicomio, visto che la legge si interessa alla salute del singolo solo in quanto dannoso per la salute collettiva.
Ecco da dove nasce l'uso distorto del manicomio, talvolta incoraggiato anche dalla giurisprudenza (148), che porta ad internare anche soggetti sani di mente ma di pubblico scandalo, come prostitute che esercitano troppo sfacciatamente la propria attività, o persone che si mostrano abitualmente in pubblico in abbigliamento succinto.
Per quanto riguarda le modalità di ammissione degli internati, ai sensi dell'art. 2 viene chiesta dai «parenti nell'ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ovvero dai tutori, procuratori, o curatori, e da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società». Di norma l'ammissione in manicomio può essere provvisoria o definitiva. L'ammissione provvisoria, in casi d'urgenza, viene ordinata dall'autorità di pubblica sicurezza dietro la presentazione di un certificato medico attestante le condizioni mentali del soggetto. Nelle situazioni normali, è il pretore che può autorizzare il ricovero dopo aver ricevuto una domanda correlata dal certificato medico o anche da un atto notorio in cui quattro testimoni, non parenti, ma che comunque conoscano il soggetto, ne descrivano lo stato mentale.
Il Tribunale può invece autorizzare il ricovero definitivo con rito camerale o su istanza del Pubblico ministero, in base alla relazione del direttore del manicomio, e dopo un periodo di osservazione, che non può eccedere in complesso un mese.
L'unica forma di contestazione e opposizione a tale provvedimento può essere un reclamo da parte del malato o da parte del Pubblico Ministero alla Corte d'Appello. A quest'ultimo però è consentito solo il reclamo contro i provvedimenti di diniego del ricovero, a dimostrazione che anche qui l'interesse pubblico era quello all'isolamento del malato di mente, e non quello alla corretta applicazione della legge (149). Tutti i provvedimenti di ricovero vengono inoltre trascritti nel casellario giudiziario, e vi rimangono per sempre cosicché il malato deve tornare ad affrontare il mondo con un marchio “infamante”, altamente ostativo al suo percorso di reinserimento sociale, che spesso si traduce in ritorno al manicomio.
Ma, visto che il principale scopo del legislatore è la custodia dell'internato, termini come reinserimento e risocializzazione servono soltanto a far discutere la manualistica.
Il licenziamento (cioè la dimissione) dei ricoverati può avvenire per sole due ragioni: la guarigione e il miglioramento tale da consentire di proseguire le cure nel domicilio del malato; il provvedimento definitivo di dimissione, in entrambi i casi, è autorizzato con decreto del Presidente del tribunale.
Il 1904, vero e proprio anno saliente per la malattia mentale e la storia del manicomio giudiziario, si chiude con un'importante modifica all'assetto gestionale dei manicomi giudiziari: il direttore generale delle carceri Alessandro Doria (con R.d. 5 settembre 1904) affida la direzione autonoma dei manicomi giudiziari soltanto ai medici alienisti, sottraendola alla subordinazione ai direttori amministrativi. Inizia così un processo di differenziazione che, a detta del Saporito (150), «ingloba tutta una tecnica speciale, la quale impronta i suoi principii alla tecnica carceraria ed alla tecnica ospitaliera, in relazione al duplice fine della sicurezza e della cura».
Era il 1904. Più di un secolo dopo, la diatriba su a chi spetti la direzione dell'O.P.G. è ancora aperta (151).
1.6.5 1923-1925: I manicomi criminali crescono
Come auspicato da Lombroso, l'istituzione di nuovi manicomi giudiziari, nel giro di pochi anni, subisce un'impennata. Viene individuata la sede del quarto manicomio giudiziario: dopo Anversa, Montelupo Fiorentino e Reggio Emilia viene scelto un antico convento, situato nel pieno centro di Napoli, nel popolare quartiere Avvocata. Con decreto ministeriale del 1º luglio 1923, sorge così il manicomio giudiziario di Sant'Eframo. Di lì a breve lo stesso accade a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina (il manicomio era stato istituito con legge del 13 marzo 1907, ma, per l'appunto, viene aperto solo il 6 maggio 1925).
1.6.6 1930: Il codice Rocco e il sistema del doppio binario
Entra in vigore il codice Rocco, che, come abbiamo visto (152), dà cittadinanza legislativa al c.d. sistema del doppio binario nell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia qui interessa la vera novità saliente del codice che riguarda il manicomio giudiziario in quanto istituzione totale.
Per opera del legislatore avviene infatti una sorta di rivoluzione copernicana, poiché «l'apparato delle misure di sicurezza va a rompere nella sostanza quella omogeneità di trattamento tra infermi autori di reato e non autori di reato, che aveva improntato la legislazione su cui andava ad innestarsi» (153).
Vanno rilevati tre fondamentali elementi di novità:
- La misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario viene direttamente disciplinata dal codice penale: l'ordine di ricovero del folle-reo diventa di esclusiva competenza del giudice penale. Sparisce così l'istituto della c.d. consegna del prosciolto folle all'autorità competente, e ciò che fino ad allora era stato di competenza del presidente del Tribunale civile passa al giudice penale, che è lo stesso chiamato a pronunciarsi nel merito sul reato o sui reati contestati. Parte della dottrina ha sottolineato l'importanza di questo passaggio di competenze, leggendolo come l'instillarsi nella cultura giuridica di una sorta di «diffidenza nei confronti della psichiatria» (154), come se i giuristi volessero riprendersi un primato. Resta comunque sintomatico il fatto che l'internamento in manicomio giudiziario sia inserito nel Titolo VII rubricato “Misure amministrative di sicurezza”. Sul peso da dare all'aggettivo “amministrativo” molto si è discusso, per poi concordare sul fatto che «non avesse alcun valore autonomo vincolante» (155), ma fosse, probabilmente, niente più che un richiamo linguistico all'aureo retribuzionismo della pena, che mal sopportava l'inserimento delle misure di sicurezza come sanzioni penali.
- L'entrata della follia all'interno del sistema penale avviene attraverso il fumoso concetto di “pericolosità sociale”, che, in molti casi, viene addirittura presunta e apriorisaticamente dichiarata dal codice.
- L'art. 222 fissa dei termini minimi di durata della permanenza in manicomio giudiziario e statuisce pertanto: «Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima dell'internamento è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale psichiatrico. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso».
Nella storia repubblicana, il testo di questo articolo sarà più volte censurato della Corte Costituzionale (nel 1982, nel 1998 e nel 2003), come avremo modo di vedere nel corso di questa cronistoria; tuttavia quel che qui preme notare è che, prevedendo limiti di durata, il manicomio giudiziario, da misura di sicurezza extrapenale, si trasforma in vera e propria sanzione penale, legandosi, per di più, alla gravità del fatto commesso, invece che alla pericolosità del soggetto, come sarebbe logico aspettarsi (156).
Questa caratteristica va inoltre ad accentuare il non richiesto profilo sanzionatorio della misura di sicurezza, scavalcando pericolosamente il principio di proporzionalità tra reato commesso e pena e quindi, lato sensu, anche l'imprescindibile principio di legalità.
In concreto, si creano i presupposti per la nascita di un vero paradosso giuridico: la durata dell'internamento può essere superiore alla pena a cui il soggetto sarebbe stato condannato se fosse stato dichiarato imputabile. Alla componente di difesa sociale si aggiunge componente retributiva (157) e a farne le spese sono gli internati.
1.6.7 1968: Un assordante silenzio
A seguito dell'introduzione del codice Rocco, al di là degli ovvi effetti, giuridici e culturali, dell'entrata in vigore del testo costituzionale, soprattutto agli art. 27 e 32 (158), la tematica dei manicomi giudiziari cade in un assordante silenzio. Dimenticata dal legislatore, ad eccezione di un unico intervento: la legge 431/1968.
Sul piano concreto le disposizioni della legge non possono certo considerarsi “rivoluzionarie”, ma hanno un'importanza notevole dal punto di vista storico-culturale, poiché introducono «la logica del rispetto della personalità, della libertà, e del diritto alla tutela della salute, fu affermata in modo irreversibile e segnò la via alle successive revisioni legislative» (159).
Si introducono infatti la possibilità di ricovero volontario in manicomio civile su richiesta del malato (art. 4) e l'abolizione dell'obbligo di annotazione sul casellario giudiziale dei provvedimenti di ricovero definitivo disposti dal magistrato. Un altro cambiamento di notevole portata è quello di consentire al malato di chiedere volontariamente l'ammissione in un ospedale psichiatrico, con la sola autorizzazione del medico di guardia, per essere sottoposto a cure o ad accertamenti.
Il malato di mente vede così riconosciuto il proprio diritto, costituzionalmente sancito dall'art. 32 Cost., ad essere curato da quella che smette di essere considerata un'infamia, per essere finalmente riconosciuta come una malattia. Si cessa quindi di ritenere la pazzia come una disgrazia ineluttabile e assolutamente incurabile e il malato come un potenziale criminale da isolare dalla comunità; si inizia invece a considerare la prima come una malattia da prevenire e da curare e il secondo come persona da rispettare e di cui prendersi cura nella tutela della sua dignità.
Non va dimenticato che la scienza psichiatra inizia l'uso massiccio degli psicofarmaci, che hanno il controverso potere di ridurre l'eccitazione violenta dei pazienti, e delle teorie di psicoterapia individuale e di gruppo.
Ma il merito di tale legge è quello di restituire potenzialmente l'infermo di mente alla psichiatria, limitando la funzione custodiale del manicomio ed esaltando il fine terapeutico: si creano i Centri e Servizi di igiene mentale territoriali con funzioni preventive, specie nella fascia pediatrica della popolazione, e curative per tutti coloro che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta volontaria.
La territorializzazione del disagio psichico trova dunque accoglienza giuridica all'interno del nostro ordinamento. Di qui a pochi anni, diventerà il mantra della riforma Basaglia, con tutte le positività e negatività che ne conseguiranno.
Certo, la legge 431 non si espone in merito al problema della chiusura dei manicomi ed al loro superamento tramite forme di assistenza psichiatrica alternativa. I tempi non sono, evidentemente, ancora maturi (160).
1.6.8 1974: La Corte Costituzionale e la durata delle misure di sicurezza
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110 del 23 Aprile 1974, determina una prima sostanziale modifica al sistema designato nel codice Rocco, dichiarando illegittimo l'articolo 207 c.p. nella parte in cui prevede la irrevocabilità della misura prima della scadenza del suo termine di durata minima.
Sul piano concreto, la formulazione originale dell'art. 207 comportava la permanenza in manicomio di molte persone che avevano cessato di essere pericolose. Nei confronti della norma erano state sollevate più volte eccezioni di legittimità costituzionale, già a partire dagli ultimi anni Sessanta, ma solo nel 1974 la Corte Costituzionale decreta illegittimo l'ultimo comma dell'articolo, attribuendo al giudice di sorveglianza la facoltà di revocare la misura di sicurezza anche prima della decorrenza del termine minimo stabilito per legge. La sentenza rappresenta un momento decisivo della battaglia contro gli istituti manicomiali, poiché, in conseguenza di questa, molte persone non più pericolose sono state finalmente liberate.
1.6.9 1974 (bis): Antonia Bernardini, imprenditrice morale inconsapevole
Da un punto di vista sociologico, il 1974 è anno cruciale, poiché la questione dei manicomi giudiziari torna al centro del dibattito giuridico e politico, grazie al ruolo fondamentale di quello che, secondo il modello interazionista simbolico, è definito imprenditore morale (161). Invero, si tratta di un'imprenditrice morale inconsapevole, poiché il suo è un ruolo non scelto, ma, tragicamente, subito.
Antonia Bernardini (162), il 27 dicembre 1974 brucia viva nella sezione “Agitate e coercite” del manicomio giudiziario femminile di Pozzuoli, mentre è legata al letto di contenzione. Morirà, a causa delle gravissime ustioni, quattro giorni dopo, il 31 dicembre 1974, all'ospedale Cardarelli di Napoli. Trascorreranno ulteriori quattro giorni prima che l'autorità giudiziaria apprenda casualmente del decesso, il 4 gennaio 1975.
La sua vicenda è paradigmatica di quanto schizofrenico possa essere il rapporto tra psichiatria e diritto: Antonia Bernardini viene arrestata il 12 settembre 1973 alla stazione di Roma Termini, per oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito di un acceso diverbio con un agente di polizia.
La storia clinica di Antonia Bernardini è piuttosto complessa e conta ventiquattro ordini di ricovero in ospedale psichiatrico, sintomatici di un disagio psichico evidente. Nonostante ciò viene condotta nel carcere di Rebibbia, sezione femminile e, dopo più di trenta giorni, il 26 ottobre 1973 viene trasferita al manicomio giudiziario di Pozzuoli. La custodia cautelare è dovuta «attesa l'entità del fatto e la personalità morale della giudicabile». L'udienza per l'esame dei fatti viene inizialmente fissata il 7 dicembre 1973, ma successivamente rinviata di un anno, al novembre 1974, due mesi oltre la scadenza dei termini di custodia cautelare previsti per il reato contestato di oltraggio (un anno).
Quindi, al momento dell'incendio che ne causerà la morte, Antonia Bernardini, non doveva trovarsi reclusa.
I tentativi dell'internata e dei suoi difensori per ottenere la cessazione (o, per lo meno, il mutamento) della misura cautelare cadono nel vuoto, nel senso letterale del termine: il Pubblico Ministero non fornirà mai alcuna risposta all'istanza di scarcerazione.
Il “silenzio” dell'autorità giudiziaria stupisce perfino la direzione stessa del manicomio, il 23 febbraio dichiarano cessata l'acuzia (163) e conseguentemente la donna diviene “trasferibile” in altra struttura. Per mesi nessuna risposta o provvedimento vengono posti in essere, il 23 settembre 1974 il Presidente del Tribunale ordina il trasferimento a Roma, nessuno si preoccupa dell'esecuzione del provvedimento, poiché (chiariranno le successive indagini) la comunicazione non aveva lasciato la cancelleria del tribunale e, conseguentemente, sia la direzione del manicomio che le autorità di Pubblica sicurezza erano all'oscuro della decisione.
Antonia Bernardini è reclusa a Pozzuoli, mentre dovrebbe essere a Roma, questo implica la sua impossibilità di presentarsi all'udienza del 13 novembre, che viene quindi rinviata per assenza dell'imputata. Nessuno, né il giudice né il pubblico ministero, si accorge che i termini della custodia cautelare sono scaduti.
Non solo Antonia Bernardini è reclusa, anziché libera, è a Pozzuoli, anziché a Roma, ma viene coercita per tre volte e per periodi, via via, più lunghi: prima 12 giorni, poi 28 e infine, oltre i 30, dal 14 novembre fino al giorno dell'incendio (164).
Vengono intentati procedimenti penali e amministrativi a carico di: Francesco Corrado, direttore del manicomio, per omesso controllo sull'attività dello psichiatra, che era da lui stesso sostituito al tempo del fatto, poiché in ferie, Giuseppe Tampone, psichiatra, per aver disposto la contenzione senza atto scritto, che ne sancisse la natura e la durata e in carenza di motivazione, cinque vigilatrici, per omesso controllo sull'internata.
Alla condanna in primo grado segue l'assoluzione in sede di Appello.
Al di là delle vicende giudiziarie degli imputati, a seguito di un aspro confronto parlamentare (165) e delle morti sospette di altre due internate (Liliana Codini, Teresa Quinto Calducci), il manicomio giudiziario di Pozzuoli viene chiuso e trasformato in carcere femminile. La contenzione, invece, è, a tutt'oggi, prassi terapeutica.
1.6.10 1975: Da manicomio giudiziario a O.P.G. Nomina non sunt consequentia rerum (166)
Si approva il nuovo Ordinamento penitenziario (l. 354/1975). La portata riformatrice di tale normativa è notevole per quando riguarda gli istituti di pena, mentre è molto modesta per gli istituti di esecuzione delle misure di sicurezza (tra i quali il manicomio giudiziario).
Si potrebbe affermare che è questa una riforma nominalistica, poiché si limita a cambiare la denominazione di manicomio giudiziario, in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, nome tutt'oggi in uso.
L'art. 62 statuisce, infatti: «Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: Colonie agricole; Case di lavoro; Case di cura e custodia; Ospedali psichiatrici giudiziari. In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale. Possono essere istituite: sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa; sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario; sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione».
È solo un cambiamento formale, ma che riflette l'idea ben più sostanziale che i folli-rei debbano essere curati prima che puniti, in strutture più simili ad ospedali che a carceri.
È altrettanto innegabile che i benefici della riforma del sistema penitenziario si siano comunque riflessi indirettamente e positivamente anche nell'ambito degli O.P.G. Infatti si abbandona la prospettiva meramente custodiale del sistema penitenziario italiano, per una applicazione più efficace del dettato costituzionale (in primis dell'art. 27) e quindi un'affermazione dell'idea rieducativa della pena. In particolare, anche l'internato potrà usufruire delle opportunità trattamentali finalizzate al reinserimento sociale, le c.d. misure alternative alla detenzione.
Una delle innovazioni più significative apportate dalla legge, riguardano la previsione della possibilità per l'internato in O.P.G. di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare alle attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48). Il regime di semilibertà per gli internati è però particolare rispetto a quello applicabile ai detenuti comuni, per questi ultimi infatti la semilibertà può essere concessa solo se la condanna riguardi specifici reati (sono esclusi ad esempio, i reati più gravi, quali rapina, estorsione, sequestro di persona) oppure solo se il condannato ha già scontato almeno la metà della pena; tali restrizioni non valgono invece per gli internati. La semilibertà può essere loro concessa in ogni tempo e prescindere dal reato commesso (167).
Vi sono almeno altre due importanti novità, che meritano di essere approfondite, una di carattere organizzativo, un'altra più sistematica.
La prima è contenuta nell'art. 11.1 ord.pen. in cui si dispone che ogni istituto carcerario, oltre a un servizio medico generale, possa contare sull'opera di almeno uno specialista in psichiatria: tale previsione ha prodotto sull'O.P.G. l'effetto di un notevole sfoltimento della popolazione di detenuti inviati in O.P.G. in osservazione psichiatrica.
La seconda riguarda l'introduzione nel nostro ordinamento del Magistrato di Sorveglianza, che va a sostituire il Giudice di Sorveglianza, ma con poteri e compiti peculiari. Le attribuzioni di tale organo giurisdizionale contenute nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario sono espressione di una «concezione del Magistrato di Sorveglianza essenzialmente quale organo di garanzia della legalità nell'esecuzione della sanzione detentiva di tipo tradizionale, sia pure in un'ottica più spiccatamente ispirata alla finalità della rieducazione» (168).
Fondamentale è inoltre il neonato potere-dovere di vigilanza, ex art. 69 ord.pen., egli deve assicurare l'attuazione della legge penitenziaria. Tale controllo può riguardare tutto ciò che concerne, non solo l'organizzazione, ma anche la gestione degli istituti, compresi gli O.P.G.
Tale attribuzione del Magistrato di sorveglianza è stata definita «un potere diffuso di conoscenza e valutazione riguardante i vari servizi [...] e la loro adeguatezza alle prescrizioni dell'ordinamento penitenziario ed alle esigenze della popolazione carceraria» (169). Il controllo del Magistrato di sorveglianza non deve, inoltre, essere inteso solo come mezzo per assicurare unicamente la legalità dell'attività penitenziaria, ma deve intendersi comprensivo anche di una valutazione di merito, in quanto si tratta di «valutare la funzionalità dell'azione penitenziaria rispetto al raggiungimento degli scopi che le devono essere propri» (170).
1.6.11 1978: La primavera dei matti. La grande riforma
È il 13 maggio 1978, il parlamento a larghissima maggioranza (171) approva la l.180/1978, poi confluita nella legge n. 833/1978 sulla Riforma del Sistema Sanitario Nazionale, dopo un iter parlamentare inusualmente rapido, anzi rapidissimo: il 19 aprile il Consiglio dei Ministri presenta il disegno di legge “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, le Commissioni Igiene e Sanità di Camera e Senato lo approvano in sede legislativa, il 2 e il 10 maggio (172).
Non sono giorni qualunque, il 9 maggio nel bagaglio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani a Roma, cambia la storia d'Italia: Aldo Moro, penalista barese, nonché Presidente del Consiglio viene ucciso dalla Brigate Rosse dopo cinquantacinque giorni di sequestro. E chi, in quel contesto storico e politico, può permettersi di pensare ai “matti”?
Come se non bastasse, entro la fine dell'anno, gli Italiani devono essere chiamati a pronunciarsi su otto quesiti referendari, proposti dal Partito Radicale. Uno di questi riguarda l'abrogazione di alcuni articoli della l. 36/1904, che, in caso di esito favorevole del quesito referendario, avrebbe sancito la chiusura dei manicomi civili e giudiziari.
Franco Basaglia e il movimento antipsichiatrico italiano, da tempo chiedevano una riforma delle cure psichiatriche, basandosi su due principi fondamentali: la territorializzazione delle cure e la responsabilizzazione del malato.
L'attesa riforma arriva, ma è Basaglia stesso, a rifiutarne la paternità (173): «Questa legge nasce come un compromesso per superare lo scoglio del referendum, che avrebbe eliminato una legge deprecabile, ma avrebbe lasciato un vuoto normativo che comunque andava colmato. Un compromesso politico quindi è quello che è. Esso va visto nell'ambito della volontà del governo di far rientrare questa normativa nella progettata riforma sanitaria. E' uno stralcio, una norma transitoria. Questo alimenta le perplessità sulle contraddizioni che la nuova normativa contiene, e le speranze che essa possa condurre a posizioni più avanzate» (174).
Ma quella intervista ha altri aspetti sociologicamente interessanti: «Una cosa è abbastanza importante: che le forze politiche abbiano apprezzato ciò che è accaduto negli ultimi anni in manicomi smantellati da psichiatri democratici, preparando una legge i cui motivi ispiratori sembrano coerenti con simile apprezzamento. Sotto questo aspetto, si tratta di una nostra piccola vittoria. [La norma che accomuna la psichiatria all'assistenza medica, prevedendo la cura dei malati di mente negli ospedali generali, N.d.A] ha un certo peso, soprattutto in relazione alla iniqua legge del 1904 che con l'alibi della “pericolosità” di certi individui suggellava l'abbraccio mortale fra psichiatria e giustizia, favorendo segregazioni e torture. Ma attenzione alle facili euforie. Non si deve credere d'aver trovato la panacea a tutti i problemi del malato di mente con il suo inserimento negli ospedali tradizionali. La nuova legge cerca di omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento umano al corpo. E' come se volessimo omologare i cani con le banane. Facciamo l'esempio di chi ha un tumore, oppure una febbrona o il verme solitario. Se va a finire all'ospedale, c'è la ricerca della causa del suo male e in alcuni frangenti il ricovero s'impone (in ossequio all'articolo 32 della Costituzione) per evitare contagi. Ma se ricoveri - cioè togli la libertà - a una persona perché ha pensieri bizzarri o disturbi psichici, perché lo fai? A che cosa si riferisce quel ricovero? Che cosa può voler dire “grave alterazione psichica”? La sofferenza psichica nasce da una contraddizione: l'uomo più è represso, più manifesta sofferenza psichica; più la sua esistenza è libera da condizionamenti, meno soffre».
Certo si era molto lontani dal dare forza di legge a quel germe della ribellione, auspicato dallo stesso Basaglia: «Cosa ha annientato il malato? L'autorità. Per riabilitarlo occorre abituarlo a ribellarsi. Dato però che il nostro sistema sociale non è interessato alla riabilitazione del malato mentale, in quanto non ha lavoro neanche per i sani, bisogna riformare anche la società» (175).
Tuttavia è necessario riconoscere alcune positività di quella norma, pur sottolineando che non vi sia un solo riferimento ai folli-rei e agli O.P.G., nonostante il coraggioso tentativo di una giurisprudenza minoritaria di considerare implicitamente abrogato l'art. 222 c.p. (ricovero in O.P.G.) dall'art. 11 della riforma in esame (176). Tale posizione è considerata dalla dottrina totalmente «priva di fondamento» (177).
Questo vulnus, a seconda delle interpretazioni e dei punti vista, può essere letto come grave lacuna, opportunismo politico, incapacità di affrontare con la necessaria serenità un problema complesso, calcolata dimenticanza o semplice contingenza («gli O.P.G. erano strutture controllate dal Ministero di Grazia e Giustizia, e non da quello della Sanità come i manicomi civili. La riforma riguardava la sanità, non la giustizia» (178)).
Quel che è certo è che la riforma sancisce alcuni punti di non ritorno della cura del disagio psichico, che, in generale, rispondono a «un approccio che richiede un'integrazione del portatore di sofferenze psichiche all'interno del tessuto sociale, attraverso l'abbandono della prospettiva dell'esclusione sulla quale si è fondata la precedente normativa manicomiale» (179).
Vanno pertanto rilevate conquiste metodologiche e culturali, a cui ancora oggi tendono asintoticamente le proposte di riforma degli O.P.G e, più in generale, delle misure di sicurezza: «[La riforma del 1978, N.d.A.] ha riportato quel clima culturale, che si era mosso intorno alla riforma, o meglio alla rivoluzione, che aveva fatto sancire la chiusura dei manicomi civili. Un effetto di due tipi: il primo costituito dalla diminuzione della popolazione internata in O.P.G.
Il secondo effetto si è espresso sulla conduzione che sempre più ha perso il rigore della custodia per aprirsi a veri e propri interventi terapia riabilitativa, con la ristrutturazione dei luoghi e l'invenzione di “terapie” che si erano imposte anche nella psichiatria. Esistono iniziative di terapia occupazionale, di arte e musico terapia, di interventi di gruppo... Insomma, se gli O.P.G. sono stati al di fuori della riforma legislativa, non sono stati esclusi da iniziative di rinnovamento, proprio perché a dirigerli c'erano degli psichiatri e quindi una cultura che cambiava esattamente come quella di chi lavorava nella “nuova psichiatria”. Si farebbe quindi un errore e un'ingiustizia verso coloro che operano in queste strutture, se si volesse affermare che queste strutture sono rimaste immobili e indifferenti a ciò che accadeva non solo nella psichiatria italiana, ma in quella mondiale. Tutti insomma, dallo psichiatra, all'agente di polizia penitenziaria, da allora, sono più attenti al bisogno del malato. E già questo termine malato, che si è imposto su delinquente è un, piccolo grande, segnale di cambiamento».
Per quanto riguarda il primo effetto sottolineato dall'analisi di Vittorino Andreoli, vale a dire la diminuzione della popolazione internata in O.P.G. a seguito della riforma, occorre anticipare una parte dell'analisi statistica, a cui verrà dedicato largo spazio nel prossimo capitolo.
È necessario infatti indagare la fondatezza di una delle principale critiche mosse alla legge 180/1978: l'aver provocato, con la chiusura dei manicomi, una vera e propria criminalizzazione della malato psichiatrico.
È quella che Luigi Daga definisce l'esaltazione della «funzione vicariante» (180) dell'O.P.G nei confronti del soppresso manicomio civile.
Si afferma infatti con grande sicurezza, che l'aver chiuso i manicomio, ha fatto gravare sulla società un cospicuo numero di soggetti, che, al di là del manicomio, non avevano alternative e che, conseguentemente sarebbero entrati nel “circuito penale” per reati di piccola gravità e quindi internati in O.P.G., in quanto prosciolti folli.
Va proprio in questo senso la lettura di una certa dottrina: «Dopo la legge 180 i già gravi problemi di gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari hanno subito quindi una notevole accentuazione. Di ciò è testimone anche l'incremento negli anni delle presenze, dovuto al moltiplicarsi del numero di ammissioni per reati di lieve entità. Infatti, quando era in vigore la vecchia legge del 1904, l'autorità di polizia preferiva ricorrere ad una gestione medico-psichiatrica di piccoli reati come risse, molestie ed altri di live entità, disponendo il ricovero in ospedale psichiatrico, anziché attivare l'azione penale.
Dopo la riforma ciò non è più possibile e anche per reati lievi scatta facilmente la denuncia alla magistratura. Ne deriva che gli O.P.G. hanno dovuto assumere su di loro uno dei ruoli prima svolti dal vecchio manicomio civile, ma con una carica di violenza addizionale, per effetto del tipo di gestione essenzialmente carceraria ed in evidente contrasto con qualsiasi finalità terapeutica.
Dopo la legge 180 la contraddizione fra nome di istituto terapeutico e sostanza di istituto meramente carcerario non si è spenta ma, al contrario, si è esaltata con la presenza in OPG di un numero elevato di prosciolti, molti dei quali bisognosi di interventi socio-assistenziali, e di un numero non molto elevato, ma pur sempre critico, di detenuti sani e di elevata pericolosità» (181).
Questa dura critica è fondata? Come sempre, occorre non fermarsi a leggere le statistiche, ma interpretarle, altrimenti si rischia di avallare il non vero e distribuire responsabilità iniquamente. Nella Tabella 1.4 sono riassunti, divisi per sesso, il numero di internati dal 1950 al 2000. Effettivamente vediamo che nel periodo della riforma e dell'antipsichiatria (gli anni Settanta), vi è un effetto elastico, con il numero di internati in costante diminuzione dal 1970 (1542 internati) al 1977 (1116), ma nell'anno dell'approvazione della legge 180 il dato torna a salire, anche se di poche unità (1149). Il trend ascendente rimane tale e, anzi accelera, nei primi Anni Ottanta, quando verosimilmente la riforma inizia ad influire maggiormente sulla realtà. Perché il dato torni a scendere occorre aspettare il 1985 (1361 internati). Al di là del fatto che l'oscillazione rimane nell'ordine del centinaio di unità (a livello percentuale è del 14% circa), neanche lontanamente paragonabile con i dati del primo dopoguerra (costantemente sopra i 2000 internati fino al 1963), occorre, ad essere intellettualmente onesti, prendere in considerazione i dati relativi al rapporto internati in O.P.G. e detenuti. Si veda quindi la tabella 1.5.
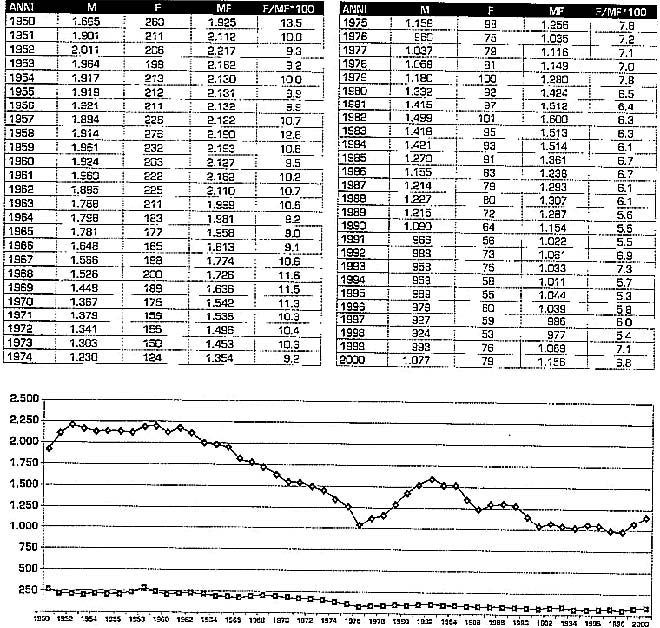
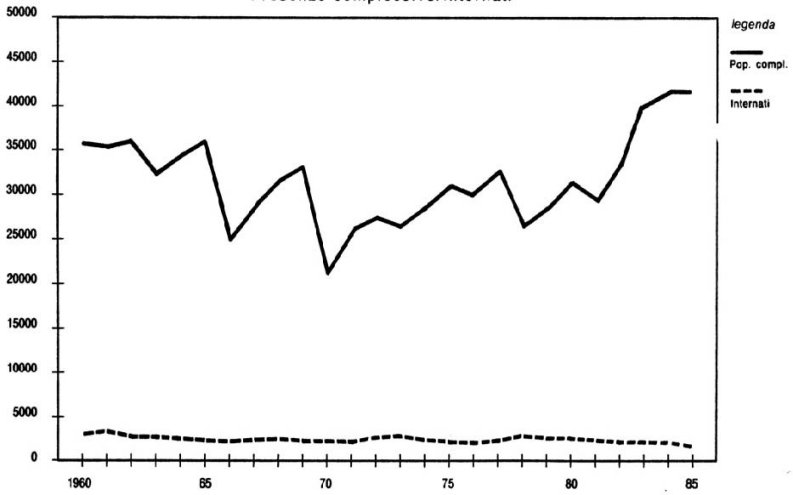
È molto significativo vedere la retta del numero di internati in O.P.G. sostanzialmente invariata nei tre decenni salienti della riforma psichiatrica, a fronte di una retta del numero di detenuti assolutamente schizofrenica, che nel giro di quindici anni, passa dalle 21 379 unità del 1970 alle 41 850 del 1985, praticamente un raddoppio, un'ascesa inarrestabile, che continua tutt'oggi. «L'O.P.G. non si è quindi diffuso, ma anzi si è progressivamente ridotto nella pratica. In ogni caso occorre realisticamente tener presente, nelle grandi scelte, le esigenze di difesa sociale, che sono concrete e reali e riguardano non soltanto una ideale generalità di cives ma le persone singole, le famiglie, le comunità coinvolte nel fenomeno criminale, come nel fenomeno della follia» (184).
Come si rileva quindi dal quadro statistico appena evidenziato, dire che il superamento dei manicomi civili della l.180/1978 ha avuto ripercussioni negative sugli O.P.G. è, per meno, ingeneroso. Il rischio di tali affermazioni è quello di nascondere il problema principale del sistema penale dell'ultimo mezzo secolo: l'uso smodato della detenzione, ma questo è un problema molto più vasto, trattarlo in questa sede significherebbe sminuirlo.
Se una critica va mossa alla legge Basaglia, non è sul piano numerico quantitativo, ma su quello qualitativo: l'aver, in molti casi, spostato il problema del malato psichiatrico dal manicomio ad altri luoghi: la casa, la famiglia, la comunità in cui è tornato, né tecnicamente né culturalmente pronti ad accoglierlo. L'associazione “Vittime della 180” (185) a tal proposito denuncia: «La chiusura dell'Ospedale Psichiatrico ha riaperto il manicomio. Gli odierni manicomio sono la famiglia o l'SPDC (186), ambedue inadatti ad una efficacie cura. L'abbandono e la disgregazione del malato, che una volta avveniva solo nei più inefficienti ospedali psichiatrici, si ripete oggi in ogni casa, con l'aggravante del coinvolgimento e della distruzione delle altre vite. La famiglia è pressoché sola a combattere la malattia, specie nel momento più critico e delicato, cioè agli inizi. Anzi si può dire che la cura del malato giovane e violento è oggi in Italia pressoché impossibile. La stessa diagnosi è molto difficile ed è infatti fatta spesso dopo anni. Una buona diagnosi richiederebbe l'osservazione del malato per un certo periodo e senza le inevitabili alterazioni dovute agli psicofarmaci ed ai calmanti. Invece o rimane in famiglia o viene ricoverato nel repartino dell'Ospedale Generale, dove la prima cura a cui verrà sottoposto sarà il massiccio impiego di psicofarmaci».
Al di là del livore ideologico, si denuncia effettivamente un palese difetto di esecuzione delle nuove norme: «mancò l'attivazione delle c.d. strutture intermedie, ossia strutture di medio-lungo degenza che, senza riprodurre i limiti delle istituzioni manicomiali, consentissero l'accoglienza in piccole comunità dei malati portatori dei disturbi più gravi. Alla logica di esclusione dei malati di mente, nel custodialismo della precedente normativa, si era sostituita una logica di inclusione solo apparente» (187).
1.6.12 1982: Il necessario attivismo della Corte Costituzionale
Inizia il ventennio in cui ad occuparsi maggiormente di folli-rei non è il legislatore, bensì i giudici costituzionali, che assolvono così il loro fondamentale ruolo politico, lucidamente descritto da Gustavo Zagrebelsky: «Come guardiana della costituzionalità della vita costituzionale, la Corte deve essere portatrice fedele dei valori del diritto, ma al contempo deve promuovere nella vita politica l'indispensabilità della propria funzione, essendo partecipe consapevole, a questo solo scopo e senza coinvolgimenti estranei alla propria posizione imparziale, degli sviluppi politici e del loro significato. Fallirebbe il suo scopo, chi pensasse che il diritto costituzionale debba o anche solo possa essere pensato isolandolo in una prospettiva pura, cioè scissa dalle sue basi di efficacia, illudendosi così di renderlo massimamente normativo in quanto sottratto all'influenza di qualunque fattore politico» (188).
Se, infatti, alla luce della riforma del 1978, il quadro normativo è rimasto immutato, sicuramente quello politico, culturale e sociale è cambiato radicalmente.
Con la fondamentale sentenza 139 dell'8 luglio 1982 la Corte Costituzionale «dichiara l'illegittimità costituzionale degli art 222.1, 204.2, 205.2 numero 2 del Codice Penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte della giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura» (189).
Occorre tuttavia placare gli entusiasmi, infatti la presunzione di pericolosità sociale dell'infermo di mente autore di reato continua ad esistere e resta, seconda la Corte, costituzionalmente fondata, è invece priva di giustificazione psichiatrica e criminologica la presunzione di persistente pericolosità, da valutarsi al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza. Ecco perché i commentatori considerano l'intervento della Corte una «variazione minima» (190) e una «abolizione della pericolosità presunta passata per la cruna dell'ago» (191).
Ciò nonostante è da plaudire la scelta della Corte di trascendere l'aspetto squisitamente de iure condito, per formulare alcune considerazioni sulla effettiva gestione e organizzazione degli O.P.G. La scelta è dettata dalla necessità di rispondere ad alcune ordinanze di remissione dei giudici di merito, che vedono proprio nelle carenze gestionali e terapeutiche degli istituti, un chiaro vizio di costituzionalità, poiché si sacrifica il carattere rieducativo a scapito del solo carattere segregante della misura di sicurezza.
Pur non potendo sul punto accogliere la questione di legittimità prospettata, trattandosi di problemi trascendenti la disciplina normativa, la Corte sottolinea: «le carenze lamentate dai giudici rimettenti, in base a personali, sofferte esperienze e risultanti anche da indagini ufficiali condotte o promosse da autorità a ciò competenti, esigano la più attenta considerazione e la più sollecita iniziativa da parte del legislatore e dei pubblici poteri. Il problema umano e sociale del trattamento da riservare ai soggetti prosciolti perché non imputabili per infermità psichica non può essere affrontato e risolto in termini formali e nominalistici -di etichetta verrebbe fatto di dire-ma impone l'adozione di misure concretamente idonee alla cura e non soltanto alla custodia di quei soggetti medesimi, essendo evidente che la loro risocializzazione dipende dalla guarigione o quanto meno dal miglioramento delle loro condizione psichiche».
Non si risolve invece l'altro macroproblema delle misure di sicurezza legato alla previsioni di termini minimi di durata, tuttavia inizia il tramonto della anomala connotazione retributiva dell'O.P.G., che cede gradualmente il passo alla funzione special-preventiva a scapito del profilo di neutralizzazione e di difesa sociale: una maggiore attenzione alla personalità del soggetto e alla sua concreta evoluzione non poteva che entrare in aperto contrasto con gli schemi rigidi del Codice Rocco.
L'attività della Corte pone le basi per l'auspicata «sollecita iniziativa del legislatore e dei pubblici poteri», che arriverà quattro anni più tardi, nel 1986, con l'approvazione della c.d. Legge Gozzini (legge n. 663/1986). «Quasi di soppiatto all'interno di una riforma dell'ordinamento penitenziario, si sopprimono qualsiasi forma di presunzione di pericolosità nell'applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza» (192).
1.6.13 1998: I minori e l'O.P.G.
L'O.P.G. è protagonista di tre importanti proposte di legge: nel 1983 (proposta di legge Vince Grossi), nel 1996 (proposta di legge Corleone), 1997 (proposta di legge congiunta consiglio regionale Toscana ed Emilia Romagna), che sui ci limitiamo ad enunciare e che spiegheremo approfonditamente nell'ultimo capito.
Nel 1998 è ancora la Corte Costituzionale a prendere una decisione importante, sancendo l'illegittimità costituzionale (193) dell'art. 222 c.p. nella parte in cui si prevede l'automatismo del ricovero in O.P.G. del minore totalmente incapace. Ex sentenza n.324 del 1998 (194) si chiarisce che: «Il trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva alle specifiche esigenze proprie dell'età minorile».
A seguito di tale decisione della Consulta, la Cassazione (195) ha poi preferito applicare la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, «ritenuta più idonea a soddisfare le istanze di contenimento della pericolosità del minore, in considerazione delle modalità di esecuzione della misura stessa» (196).
Sul complesso tema dei folli-rei minori, occorre compiere un “salto temporale” e segnalare il duplice tentativo perpetrato nel 2004 dal Governo Berlusconi II che, nel silenzio e nell'omertà diffusa, istituisce, a Castiglione delle Stiviere, attraverso un iter amministrativo burocratico tanto complesso quanto sospetto, un c.d. O.P.G. per minori, dove sono internati nove adolescenti, tutti extracomunitari.
Solo la denuncia pubblica, avanzata dal Forum Salute Mentale e ripresa dai media nazionali, permette di bloccare sul nascere, grazie all'interessamento dell'allora sottosegretario Guido Guidi, una struttura che non trova giustificazione all'interno del nostro ordinamento, soprattutto alla luce della suddetta decisione della Consulta. Si legga con attenzione, ai fini di una completa riflessione sociologica, il seguente stralcio di cronaca riguardante i fatti appena narrati (197):
[...] Antonino Calogero, direttore dell'ospedale psichiatrico spiega: “Può ospitare al massimo dieci ragazzi. Ora ne abbiamo quattro. Nei mesi passati, dopo l'avvio in luglio, ce ne sono stati al massimo sei, contemporaneamente. Il reparto è stato ricavato accanto a quello femminile. Non c'è alcuna possibilità di incontro con i degenti adulti, e anche lo staff è diverso: uno psichiatra, uno psicologo, due educatori, un infermiere professionale, undici assistenti”. Aggiunge che la sperimentazione “nasce dalla necessità di far fronte ai problemi psichici emergenti fra i minori detenuti”. Questa, dice, “è l'ultima ratio, o almeno così ha funzionato”. Come sono stati scelti i ragazzi per il reparto sperimentale? Uno psichiatra che vuole rimanere anonimo dice: “Li hanno convinti dicendo che a Castiglione si sta bene, e che c'è anche la piscina. Poi, una volta verificato che il regime era stretto, sono cominciati i problemi e i tentativi di fuga”. Il direttore Calogero dice che sono stati “inviati da Roma su segnalazione dei centri per la giustizia minorile, in base ad alcune caratteristiche della diagnosi, delle motivazioni, del percorso”. Il sottosegretario Cursi aggiunge [...]: “La comunità ha accolto sino ad oggi complessivamente otto minori che hanno riscontrato disturbi della personalità di tipo borderline (due minori), disturbi di grave condotta (due, di cui uno associato a ritardo mentale), disturbo antisociale (uno) e schizofrenico (uno), nonché portatori di disturbo di personalità paranoidea (uno), e un minore con diagnosi da definire”. Quello che non dice è che, verosimilmente, si tratta in grande maggioranza di ragazzi con problemi di tossicodipendenza. [...] Problemi che, di norma, si affrontano all'interno delle comunità e non certo degli ospedali psichiatrici. I “disturbi di grave condotta” e i “disturbi antisociali” sono pane quotidiano negli istituti, ma nessuno aveva mai pensato di curarli con l'isolamento. Nessuno che, ovviamente, non si ponesse innanzitutto l'obiettivo del contenimento, dell'ordine da mantenere. Questi di Castiglione delle Stiviere sono tutti ragazzi segnalati dai centri di giustizia minorile, dice il direttore. Chissà quali. Da queste parti nessuno lo sapeva. Non sapeva della sperimentazione Livia Pomodoro, presidente del Tribunale per i minori di Milano. Non sapeva Emilio Quaranta, procuratore dei minori di Brescia. Cade dalle nuvole anche don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile milanese Beccaria: “Qui da noi, come altrove, se ci sono ragazzi con problemi psichici, si provvede con il trattamento interno. È una cosa assolutamente nuova che si pensi a una struttura apposita: in 32 anni che faccio questo mestiere non ne ho mai sentito parlare. Sono molto preoccupato, perché si sa che, fatto un ospedale, si trovano poi i malati”. Che il problema esista, questo è certo. [...] Quello che a molti pare incredibile è che, una volta deciso di creare una struttura nuova e sperimentale ad hoc, la si piazzi dentro al manicomio criminale. [...] A norma di legge quei ragazzi non dovrebbero stare lì, ma il divieto di legge è, diciamo così, aggirato dalla spiegazione che il reparto sarebbe totalmente separato da quelli che ospitano adulti. Ma sulla questione la risposta del governo lascia qualche dubbio: si dice il “processo terapeutico” assicura la “non commistione”. Ma poi si accenna a “circolazione negli spazi comuni” e di “partecipazione alle attività”. C'è poi un passaggio curioso: “Il collocamento in comunità specialistiche, in grado di accogliere minori particolarmente difficili soggetti a misure penali, deve tendere ad evitare processi di etichettamento”. E per tenersi ben lontani da “processi di etichettamento” si prendono dei ragazzi e li si manda dentro al manicomio criminale. Si punta al loro reinserimento isolandoli, nel bel mezzo di una struttura di cura e contenimento per adulti, dopo un sinistro avvertimento: “Stai un po' più tranquillo, o ti mando a Castiglione delle Stiviere”.
È davvero sintomatica, al di là della legittima denuncia giornalistica, l'apparente totale mancanza di quelli che i costituzionalisti statunitensi definiscono checks and balances, cioè quel sistema di “pesi e contrappesi” che costituisce il fondamento stesso del sistema istituzionale moderno e del rapporto tra poteri. Un governo può avviare un'importante e controversa sperimentazione, senza che i “tecnici” (in questo la magistratura di sorveglianza e il tribunale per i minori) ne sappiano alcunché. Questo è possibile poiché si fa leva su una doppia caratteristica: i piccoli numeri e la non percezione del problema sociale.
Da una parte c'è un difetto di tipo quantitativo (una decina di minori “agitati”, sono statisticamente irrisori, praticamente un nulla numerico), dall'altra un'opinione pubblica distratta che “ha altri problemi ben più gravi”.
Numeri e attenzione, sono queste le due coordinate da cui dipenderà il futuro degli O.P.G.?
1.6.14 2003: La sentenza della Corte Costituzionale n.253/2003: l'inizio di una nuova epoca
La sentenza n. 253 del 2003 (giudice relatore Valerio Onida) è sicuramente la decisione più significativa presa dalla Corte Costituzionale sul tema folli-rei della storia repubblicana (198).
Il 10 luglio 2002 il G.U.P. di Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sul reato di tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale, accoglie con ordinanza l'eccezione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 32 Cost., chiedendo alla Corte di pronunciarsi su due questioni principali (199):
1) L'incostituzionalità dell'art 219 c.p., primo e terzo comma, rispetto all'art. 3 Cost., nella parte in cui nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una Casa di Cura e di Custodia (primo comma), con possibilità di sostituire, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla la stessa possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per vizio totale di mente.
Paradossalmente, il codice prevede una disciplina più favorevole per il seminfermo, sul quale grava comunque una responsabilità penale, che non per l'infermo totale di mente.
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, evidenziando come il richiamo all'art. 219 c.p. fatto dal giudice a quo costituisca piuttosto un tertium comparationis riguardante un'altra categoria giuridica (il seminfermo di mente).
2) L'incostituzionalità dell'art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di merito di adottare, nei riguardi del folle-reo socialmente pericoloso, in luogo del ricovero in O.P.G., una diversa misura di sicurezza, idonea a soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura dell'infermo di mente con quelle di controllo della sua pericolosità sociale.
Il giudice a quo contesta come il ricovero in O.P.G. sia un “obbligo” imposto dalla legge e non una scelta, che possa tener conto delle peculiarità del soggetto e delle sue esigenze terapeutiche. Paradossalmente la scelta sussiste invece nel caso di minore infermo di mente (grazie alla sent. 324/1998 il giudice può optare per il riformatorio giudiziario o per la “libertà vigilata”) e di seminfermo di mente (la scelta in questo caso è tra: casa di cura e di custodia e libertà vigilata). «In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: art. 215, primo comma, n. 3, cod. pen.) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), “idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati” (art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale» (200).
Tale rigidità è ingiustificata sia sotto il profilo normativo (perché, come spiegato, crea una disparità tra soggetti appartenenti alla stessa categoria giuridica: gli infermi di menti, siano essi parziali o totali, maggiorenne o minorenni) sia sotto il profilo scientifico (perché, prevedendo solo una misura altamente segregante, come l'O.P.G., si sottintende una presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente, rispetto ai seminfermi e ai minori non imputabili).
Ma vi è soprattutto, nell'opinione della Corte, un'incompatibilità evidente tra l'O.P.G. e le inderogabili esigenze di tutela della salute, costituzionalmente garantite ex art. 32.
Il ragionamento dei giudici costituzionali si fa, sul punto, molto interessante: «Fino ad oggi però la Corte si è trovata di fronte a questioni volte o ad un intento meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la introduzione di una nuova disciplina di creazione giurisprudenziale, non ancorata a contenuti normativi già esistenti: così che essa si è indotta a pronunciarne la infondatezza, o più spesso la inammissibilità, vuoi perché non disponeva degli strumenti necessari per intervenire nel senso indicato, vuoi perché le questioni prospettavano profili di fattuale inadeguatezza delle strutture di ricovero più che di inadeguatezza delle previsioni normative.
È tuttavia significativo che in più occasioni la Corte abbia avvertito l'esigenza di indicare, là dove era possibile, soluzioni pratiche adeguate, e soprattutto di esprimere la propria valutazione circa il “non soddisfacente trattamento riservato all'infermità psichica grave (...) specie quando è incompatibile con l'unico tipo di struttura custodiale oggi prevista”, nonché circa l'opportunità di una “attenta revisione” dell'intera disciplina in questione, “sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario, sia alla stregua di una valutazione relativa all'adeguatezza di tale istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente”».
Il problema pare essere insomma la totale antistoricità dell'O.P.G., che continua ad esistere, nonostante l'evoluzione della farmacologia e della psichiatria consentano oggi una maggiore capacità sia di controllo sia terapeutica: se paragonato ai nuovi modelli di intervento possibili l'internamente in O.P.G. appare, oltre che antiterapeutico, anche inidoneo allo scopo di difesa sociale, alimentando, anziché contenendo, comportamenti violenti e il senso di sofferenza degli internati (201).
Se è vero che la Consulta nulla (o pochissimo) può fare sulle problematiche organizzative e gestionali degli O.P.G. e sull'acceso dibattito sulla necessità di contenzione, è altrettanto vero che è suo compito ribadire la necessità del perfetto equilibrio tra principi costituzionali di pari valore: la cura e la difesa della collettività.
Tale compito è ancor più necessario qualora occorra evitare certi paradossi diventati usus giuridico, come, ad esempio, i «periti obbligati a disobbedire e/o a mentire, con la riserva mentale, che non essendo per lui l'internamento in O.P.G. soluzione né attuale, né pietosa, né terapeutica, l'impostura fosse morale; anzi, non essendo il concetto di pericolosità sociale neppure più riconoscibile secondo lo stato della psicopatologia, si trattasse di una santa menzogna» (202). Concretamente, ante 2003, capitava quindi che, pur di evitare lo shock di un internamento in O.P.G., il perito giudicasse “non pericoloso” il soggetto che aveva commesso reati oggettivamente (203) non gravi, nonostante fosse comunque bisognevole di cure, cosicché venisse abbandonato al suo destino o magari affidato a servizi territoriali disorganizzati, semplicemente perché non esisteva nessun altra alternativa.
«In definitiva, sia che si riconosca la pericolosità sociale al solo scopo di non abbandonare del tutto i sofferenti psichici, sia che la si escluda per sottrarli ad una struttura ritenuta unanimemente antiterapeutica, gli psichiatri forensi erano destinati ad un fardello di responsabilità non più sopportabile» (204) e, oltretutto, giuridicamente e deontologicamente discutibile.
Il perito dovrebbe, al contrario, oltreché effettuare una diagnosi e una ricostruzione criminodinamica del soggetto e del fatto contestato, aggiungere una prognosi, contenente suggerimenti sul trattamento sanzionatorio più opportuno ai fini della cura e del reinserimento, tenendo conto, concretamente, dello spettro di possibilità offerte dal territorio, ma se tale “spettro” viene preventivamente impedito dalla legge, come si può davvero uscire da un'ottica vessatoria-retributiva, lasciando più spazio alle esigenze di cura?
Ecco allora la soluzione normativa della Corte: «mentre solo il legislatore (la cui inerzia in questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato» (205).
E “tra le misure che l'ordinamento prevede” ha un ruolo preminente la libertà vigilata, strumento sufficientemente flessibile e capace di plasmarsi alle esigenze del folle-reo. Essa può essere infatti, concessa in un'apposita clinica, in una comunità terapeutica o, se ve n'è la possibilità, al domicilio del soggetto o di un famigliare: «è chiaro, però, come si rischi di arrivare ad uno snaturamento della misura della libertà vigilata, fatta poggiare, tradizionalmente, sul presupposto della capacità di autodeterminazione del soggetto destinatario, come configurerebbero, fra gli altri, gli art. 190 disp. attuative c.p.p., 212.4 e 231 c.p. Gli articoli richiamati configurano, infatti, prescrizioni che presuppongono la capacità di autodeterminarsi, nonché la capacità di scelta e di libertà di movimento. Si pensi, ad esempio, all'obbligo di conservare la carta precettiva delle prescrizioni e di presentarla alla richiesta dell'autorità o a quello di non trasferire la propria residenza o dimora senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, tutte regole la cui violazione integra, tra l'altro, il reato di cui all'art. 231 c.p.» (206).
Al di là di tale sopportabile snaturamento della libertà vigilata, va riconosciuto alla Corte il merito di aver abbattuto l'ennesimo cancello segregante, intuendo che l'unica risposta giuridicamente ed eticamente sostenibile ai problemi dei folli-rei non può che essere «dall'altra parte del cancello» (207).
1.6.15 2005: L'O.P.G. diventa problema internazionale
L'O.P.G. da problema nazionale, diventa tematica internazionale. Il sistema dell'esecuzione penale italiana e, in particolare, il caso degli O.P.G., viene affrontata da Alvaro Gil-Robles, primo Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa (208), che visita, tra il 10 e il 17 giugno 2005, numerose carceri maschili, femminili e minorili italiane, nonché l'O.P.G. di Aversa. Nella relazione finale nota: «Le strutture mi sono parse vetuste, tali da offrire ai ricoverati condizioni di vita al limite della decenza, malgrado i considerevoli sforzi del personale dirigente. L'istituto manca di mezzi necessari sia per ristrutturare certi spazi e sostituire il mobilio vetusto sia per garantire attività e programmi diversificati». Non manca di sottolineare il problema del sovraffollamento, ma il passaggio più interessante sono le conclusioni, in cui il Commissario dichiara: «In una società prospera e benevola come quella italiana, è difficile ammettere che persone colpite da malattie mentali molto gravi finiscano in strutture penitenziarie, per mancanza di strutture non giudiziarie disponibili».
Identico stupore e sdegno caratterizzano, tre anni più tardi, nell'aprile 2008, la visita del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti disumani e degradanti (C.P.T) del Consiglio d'Europa. Il comunicato stampa riassuntivo della visita svolta all'O.P.G. di Aversa fotograva una situazione non dissimile a quella rilevata tra anni prima: «Per quanto concerne l'ospedale psichiatrico giudiziario Filippo Saporito di Aversa, il rapporto pone in evidenza le scadenti condizioni della struttura e la necessità di migliorare il regime quotidiano di degenza dei pazienti, aumentando il numero e la varietà delle attività trattamentali quotidiane loro garantite. La delegazione ha inoltre riscontrato che alcuni pazienti erano stati trattenuti nell'O.P.G. più a lungo di quanto non lo richiedessero le loro condizioni e che altri erano trattenuti nell'ospedale anche oltre lo scadere del termine previsto dall'ordine di internamento».
Estremamente interessante da un punto di vista tanto sociologico, quanto giuridico l'evasiva e stringata risposta del Governo Italiano: «L'ospedale è in corso di ristrutturazione e la legge non prevede un limite per l'esecuzione di misure di sicurezza temporanee non detentive».
In pratica il Governo sostiene che le misure di sicurezza possono avere durata illimitata: è un approccio alla tematica quanto mai sommario e impreciso, che non tiene conto dle quadro normativo posto in essere dal codice penle e dal codice di procedura penale, che prevedono un periodico accertamento in concreto della pericolosità sociale e una durata della misura di sicurezza detentiva variabile a seconda della gravità del reato commesso, ma in ogni caso, non superiore ai dieci anni. Con la risposta del Governo, non solo si rischia di minimizzare il problema dell'internamento, ma anche di infliggere un duro colpo a decenni di sviluppo di civiltà giuridica.
1.6.16 2008: L'attesa regionalizzazione
Con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il c.d. Decreto Bindi (209), si riordinava la medicina penitenziaria, andando così a completare la riforma del 1975: si sanciva e si prevedevano misure per appianare ogni differenza in termini di assistenza sanitaria tra popolazione “libera” e popolazione sottoposta a pena o misura di sicurezza. La previsione più significativa era l'affidamento alle Aziende Sanitarie locali (e quindi alle Regioni e, indirettamente, al Ministero della Salute) di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle strutture e beni strumentali afferenti alla sanità penitenziaria, fino ad allora affidati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e quindo al Ministero di Grazia e Giustizia (210).
La svolta non era solo formale, ma sostanziale, poiché proseguiva nel solco della normalizzazione dell'esecuzione della pena, rimasta storicamente “diversa e distaccata” rispetto al resto della società e degli apparati burocratici statali. Affidando la salute della popolazione detenuta e internata alle cure dello stesso personale e delle stesse strutture del resto della popolazione, si tentava di scalfire la “chiusura” di un mondo a se stante.
Tuttavia è sintomatico che nessuno dei nove articoli del decreto facesse esplicito riferimento agli O.P.G.
Ancora una volta il legislatore creava un vulnus (era già successo con la l.180/1978), evitando di affrontare un problema forse troppo complesso per la politica e troppo dimenticato dalla società.
Dovranno passare nove anni affinché gli O.P.G. vengano legislativamente riconosciuti come parte integrante del sistema sanzionatorio penale (in quanto misure di sicurezza detentive) e quindi come segmento della medicina penitenziaria.
È l'art. 5 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2008 riguardante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” a decretare (211): «Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, sono trasferite alle regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie, sono trasferiti, con le modalità di cui all'art. 4, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 1, è istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposito comitato paritetico interistituzionale».
Come esplicitamente riferito dal decreto, occorre quindi concentrarsi sull'ormai celebre tra gli addetti ai lavori, Allegato C “Linee di indirizzo per gli interventi negli O.P.G. e nelle Case di Cura e di Custodia” (212).
Al di là del puntuale contenuto (si tenga conto che molte sono soltanto indicazioni date dal Governo, più che disposizioni giuridicamente vincolanti) occorre soffermarsi sulle problematiche sollevate e, a tutt'oggi irrisolte, attraverso le testimonianze dirette degli addetti ai lavori, suddivisibili in tre categorie: la territorialità, la c.d. doppia direzione, le dimissioni e le proroghe (su cui si tornerà diffusamente nel capitolo III).
1) Territorio e “bacini in piena”: Nel preambolo del decreto viene esplicitamente enunciato l'intento di fare del principio di territorialità il futuro totem degli O.P.G.: «L'ambito territoriale costituisce, dunque, la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunità per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone. Il principio del reinserimento sociale, sancito nell'articolo 27 della Costituzione, per coloro che, autori di reato, sono stati prosciolti per infermità mentale e ricoverati in O.P.G. può e deve essere garantito attraverso la cura, che ne è fondamentale presupposto, e l'azione integrata dei servizi sociosanitari territoriali.
Peraltro il principio di territorialità è parte integrante dello stesso ordinamento penitenziario che all'articolo 42 stabilisce che “nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie”.
Per tutte queste ragioni, il principio di territorialità costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli O.P.G. e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze della Corte costituzionale che non legano l'applicazione della misura di sicurezza in modo univoco ed esclusivo all'O.P.G.» (213).
La strada per raggiungere l'obiettivo ora enunciato è suddivisa in tre fasi cronologicamente susseguenti l'una all'altra: in una prima fase, contestuale all'entrata in vigore del decreto, si prevede anzitutto il passaggio di competenza sugli O.P.G. dall'Amministrazione Penitenziaria alle Regioni (214). E già a questo punto si rivela il primo intoppo, dei sei O.P.G. oggi presenti sul territorio italiano, solo per cinque si è concluso con successo il passaggio di competenze. L'O.P.G di Barcellona Pozzo di Gotto è infatti l'unico ancora interamente riconducibile al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, con un Amministrazione Regionale che, nonostante le numerose pressioni, rimane restia a procedere ad una rapida regionalizzazione della struttura. In realtà tutte le regioni e province autonome italiane non hanno ancora recepito il decreto, che quindi, su quei territori, rimane semplicemente lettera morta.
Contestualmente a tale presa in carico, i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio insistono gli O.P.G. dovrebbero, in collaborazione con l'equipe responsabile della cura e del trattamento dei ricoverati dell'istituto, procedere ad «un primo e opportuno sfoltimento del carico di internamento degli attuali O.P.G., il che rende possibile una migliore gestione personalizzata, un più idoneo rapporto tra operatori e internati ed un maggiore possibilità di programmare le ulteriori fasi successive» (215).
Tale sfoltimento dovrebbe verificarsi con dimissioni o trasferimenti mirati di tre categorie di pazienti: i soggetti imputabili e quindi detenuti in art. 148 c.p. (sopraggiunta infermità mentale del condannato) e i c.d. osservandi (in O.P.G. per un periodo prestabilito, solitamente trenta giorni, per effettuare osservazioni psichiatriche previste dall'art. 112 del nuovo Ordinamento penitenziario DPR 230/20009) dovrebbero essere destinati alle nascenti “sezioni di cura e riabilitazione all'interno delle carceri”, i soggetti prosciolti ex art. 222 c.p. che hanno concluso la misura di sicurezza in considerazione della cessata o fortemente scemata pericolosità sociale dovrebbero essere affidati alle Regioni del luogo in cui risiedono, affinché si attuino specifici progetti di inclusione sociale.
A oltre tre anni di distanza non è avvenuto alcuno sfoltimento, anzi la popolazione internata è aumentata. Secondo una rielaborazione dei dati ufficiali forniti dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, l'aumento dal 2007 (prima dell'entrata in vigore del decreto), al 31 marzo 2011, è di circa il 15% (147 soggetti), una percentuale non esagerata, ma sufficiente ad osservare come le intenzioni del decreto siano state totalmente eluse. Solo la metà degli O.P.G. è riuscita infatti a ridurre il numero di internati.
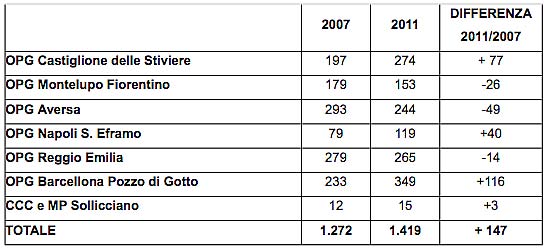
Antonino Calogero, direttore sanitario dell'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere, dove l'aumento degli internati è stato tra i più rilevanti (poco meno del 40%), spiega così la difficoltà di applicare il decreto, che si limiterebbe a tracciare ipotesi teoriche, difficilmente applicabili in concreto: «Per riuscire a dimettere un paziente così complesso come l'autore di reato, occorrono la confluenza di tanti fattori ed in primis la cessazione della pericolosità sociale esaminata dalla Magistratura di Sorveglianza. Ma anche la presa in carico di una equipe del territorio, un domicilio con assistenza psichiatrica. Nella pratica occorrono risorse, operatori preparati, alleanza terapeutica, capacità di fare superare al paziente “barriere visibili ed invisibili (stigma)”, come “il desiderio di essere liberi ma anche la paura di uscire da un contesto più rassicurante” rispetto ad una società spesso, ostile, non preparata, ma neanche sufficientemente supportata dalla rete di servizi necessari ad accoglierli» (217).
Il fallimento della prima fase produce inesorabilmente l'insuccesso “a cascata” delle due fasi successive: entro un anno dall'entrata in vigore del decreto è prevista la creazione dei c.d. bacini di internati: «ogni O.P.G., senza modificarne in modo sostanziale la capienza e la consistenza, si configuri come la sede per ricoveri di internati delle Regioni limitrofe o comunque viciniori, in modo da stabilire immediatamente rapporti di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli internati alla realtà geografica di provenienza» (218).
Si prevedeva, in via orientativa e quindi non giuridicamente vincolante, che:
- a Castiglione delle Stiviere sarebbero stati ospitati soggetti provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Essendo questa l'unica struttura ad avere un padiglione femminile (in attesa dell'imminente apertura di un padiglione analogo a Barcellona Pozzo di Gotto) deve ospitare le internate donne provenienti da tutta Italia.
- a Reggio Emilia quelli di Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche e Emilia Romagna
- a Montelupo quelli di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna
- ad Aversa e a Napoli-Secondigliano quelli di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia
- a Barcellona Pozzo di Gotto quelli di Sicilia e Calabria.
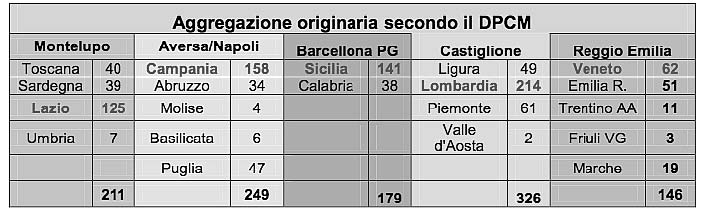
Ad oggi, i bacini esistono sì, ma solo “sulla carta”. Non esiste un solo O.P.G. che ospiti internati esclusivamente provenienti dal proprio bacino, i c.d. internati extrabacino sono presenti ovunque in quantità più o meno rilevante.
Sintomatica per la sua gravità, la situazione dell'O.P.G. Di Reggio Emilia dove gli internati extrabacino restano sostanzialmente la metà del totale (141 su 284 al 31 Agosto 2008). Ecco la situazione nel dettaglio.
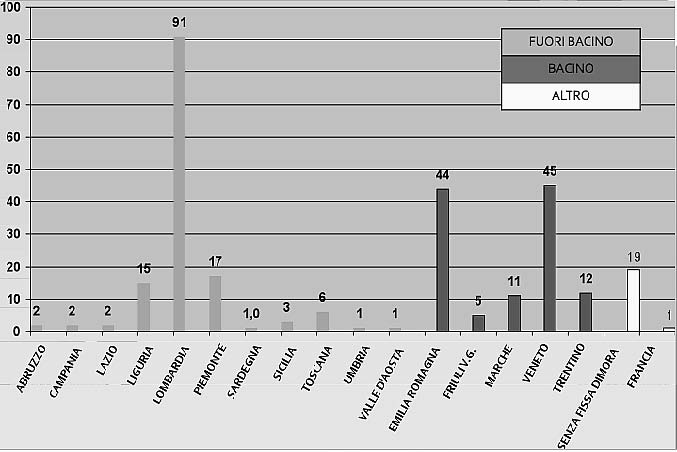
La negatività di tale situazione è duplice: la presa in carico delle singole Regioni è resa molto difficoltosa (banalmente, l'operatore sanitario locale non può visitare, se non con onerose trasferte, un internato molto distante) ed è difficile pensare e attuare un percorso di reinserimento in un contesto socioculturale diverso da quello in cui l'internato e la sua famiglia vivono e risiedono.
A parziale scusante del mancato rispetto dei bacini vi è un'evidente vulnus legislativo: il dato oggettivo della residenza non tiene conto di situazioni particolari, come il caso degli internati senza fissa dimora o stranieri senza residenza. In che bacino rientrano costoro? Non è dato sapersi.
Senza contare che in molti casi, come rilevato da una ricerca empirica condotta dalla Regione Veneto, la residenza è puramente fittizia e molti Dipartimenti di Salute Mentale non conoscono affatto l'internato, nonostante risulti residente nel proprio territorio di competenza. Si calcola approssimativamente che un terzo degli internati è sconosciuto ai Dipartimenti.
Ugo Zamburru, direttore del D.S.M. Dell'Asl 4 di Torino ammette (221): «L'unico effetto rilevante che la sanità territoriale ha avuto dall'entrata in vigore del decreto è che ora, per lo meno, riusciamo ad ottenere una comunicazione scritta con allegata cartella clinica da parte della direzione dell'O.P.G. sui pazienti dimessi e sui quali abbiamo la competenza territoriale. Prima del 2008 i pazienti appena dimessi dall'O.P.G. si presentavano autonomamente o accompagnati dai famigliari in ambulatorio, senza che ne sapessimo nulla, passavano mesi prima di ricevere informazioni sensibili sulla salute del paziente».
Tutto ciò potrebbe apparire una banale e ininfluente questione organizzativa, ma così non è, per capirlo basta un semplice dato: se i bacini fossero rispettati sarebbe risolto d'un tratto il problema del sovraffollamento e tutte le strutture resterebbero sotto la soglia di tollerabilità, con ovvi giovamenti sia per gli internati che per il personale e con una possibilità di successo del percorso di reinserimento notevolmente accresciuta.
La terza ed ultima fase del decreto, da attuarsi entro due anni dall'entrata in vigore, prevede «la restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell'assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all'interno della struttura, anche in preparazione alla dimissione e all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza, dando così piena attuazione al disposto dell'art. 115 c. 1 D.P.R. 230/2000.
Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno dalle strutture O.P.G. con livelli diversificati di vigilanza, a strutture di accoglienza e all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria dove la struttura o il servizio è ubicato.
Tramite specifico accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte.
Nelle fasi transitorie, le persone affette da disturbi psichici cui a partire dal 1º gennaio 2008 è stata applicata la misura di sicurezza saranno destinate alle sedi trattamentali più prossime alla residenza, tenendo conto della fase attuativa del Progetto di regionalizzazione degli OPG e delle forme alternative in essere per la esecuzione della misura di sicurezza».
L'utopia del raggiungimento di tale terza fase è implicita nella lettera del decreto, che viene condizionata dalle «risorse finanziarie», agli accordi politici «raggiunti in sede di conferenza Stato Regione», in definitiva si è trovato un modo giuridicamente ineccepibile, per ammettere la non preminenza della tematica O.P.G. nell'agenda di politica criminale.
2) Doppia direzione, rischio inefficienza. Tra le distorsioni più evidenti del DPCM 1/4/2008 vi è la previsione di una “doppia direzione” (sanitaria e penitenziaria), che rispecchia la storica ambivalenza dell'O.P.G., esigenza di cura della persona ed esigenza contenitiva di sicurezza pubblica, insomma se le strutture sono, nei fatti, un po' ospedali e un po' carceri, si è semplicemente e colpevolmente scelto di non scegliere. Provocando, una sorprendente battuta d'arresto rispetto al percorso di riforma della salute mentale, iniziato fin dal 1978.
Ogni O.P.G. (222) deve avere un direttore sanitario (su cui per altro vi è addirittura una disputa terminologica, poiché la denominazione di “direttore” viene considerata da alcuni inopportuna, tant'è che la legge parla di referente sanitario) e un direttore amministrativo.
Il primo è un medico psichiatra, responsabile della funzione “ospedaliera” dell'istituto dipendente dell'Asl, coordina il personale medico e paramedico, segue i percorsi di riabilitazione degli internati, il secondo è in tutto e per tutto paragonabile ad un direttore di un penitenziario “ordinario”, con poteri sanciti dal Regolamento Penitenziario e dipendente del Dap.
Nonostante le apparenze e le dichiarazioni ufficiali, è inutile negare le malsopportazione reciproca di tale situazione ibrida, che, nei casi più gravi, porta ad inefficienze della struttura, costi aggiuntivi e piccole o grandi “gelosie” tra membri del personale, al limite del grottesco (si pensi alla magistratura di sorveglianza, che per soffocare sul nascere eventuali conflitti, è costretta a inviare lo stesso provvedimento o comunicazione in “doppia copia” ricevendo, in alcuni casi, risposte diverse).
Se si continuerà a “non scegliere” rimarginare tale gap non sarà semplice, complici burrascose dinamiche personali tra singoli, percorsi formativi e culturali molto diversi, metodi di lavoro distanti.
Le buone pratiche esistono, su tutte il ricorso ad un briefing mattutino tra gli staff della direzione penitenziaria e sanitaria, ma gli attacchi reciproci non mancano: se da un lato Anna Paola di Filippo, “donna di legge” e direttrice dell'O.P.G. di Reggio Emilia, pur invocando l'esigenza di arrivare presto ad un chiarimento legislativo, afferma con sicurezza che «La responsabilità principale è del direttore penitenziario, a cui spetta l'ultima parola», la replica di Franco Scarpa, referente sanitario dell'O.P.G. di Montelupo Fiorentino non si fa attendere «Non solo non condivido la presunta supremazia gerarchica dell'amministrazione penitenziaria, ma la reputo dannosa per gli internati, se non coordinata con oculatezza con la componente sanitaria».
Il rischio maggiore è arrivare a soluzioni intermedie, come avviene a Reggio Emilia, dove su sei reparti, cinque sono completamente sanitarizzati e coordinati direttamente dal personale medico e uno, in cui sono ristretti i soggetti più pericolosi, è sotto il pieno controllo della direzione amministrativa e quindi del personale di polizia penitenziaria.
I numeri aiutano a capire e sottendono scelte politiche altrimenti solo intuibili, ma non rilevabili. Ecco, di seguito, la suddivisione del personale operante in ciascun O.P.G. dopo l'entrata in vigore della riforma. Un commento più approfondito del seguente grafico verrà fornito quando, nel capitolo, successivo si affronterà la problematica dei costi (223).
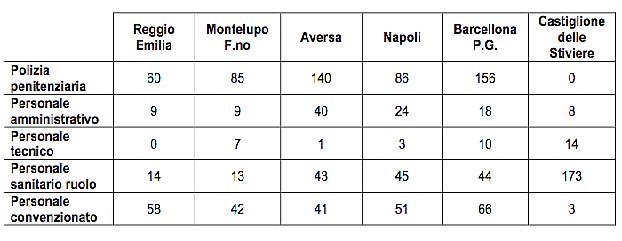
Interessante è l'opinione espressa da Angelica Di Giovanni, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che durante l'audizione del 7 luglio 2010 alla Commissione parlamentare per l'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale dichiara: «L'istituto penitenziario e quindi l'O.P.G. è in capo al Ministero della Giustizia, non al Ministero della Salute, e che quindi l'unico responsabile ultimo con il quale io, magistrato di sorveglianza, mi interfaccio è il direttore dell'amministrazione penitenziaria, non il referente della salute. Il referente della salute deve subire ciò che dice il direttore dell'istituto.
Il problema maggiore è che non si riesce ancora a comprendere, che la salute e la sicurezza procedono insieme ma l'una subordinata all'altra o, quantomeno, a pari livello. L'una non può` superare l'altra, altrimenti si potrebbero creare degli squilibri che porterebbero a risultati inattesi, insperati o non voluti. L'equilibrio, che è poi il famoso bilanciamento di interessi di cui a tutte le sentenze della Corte costituzionale, è ciò che difficilmente si riesce ad attuare.
Nella legge era scritto che gli O.P.G. non dovevano essere più istituti penitenziari; che l'aspetto salute doveva cominciare (visto che non è pena nè misura di sicurezza) a prevalere. Ma tutto questo in pratica assolutamente non lo si può realizzare. Quale il motivo? Si ritorna al punto di partenza: le ASL.
Mentre le spese relative alla cura e l'assistenza - almeno è così che dovrebbe funzionare - quando si è liberi ricadono sull'ASL di residenza, quando si è detenuti tali spese ricadono sull'ASL di competenza dell'istituto, salvo rivalse (ma sono questioni che in questo contesto non ci riguardano); quando però il detenuto esce si pone nuovamente il quesito: a chi compete sostenerne la spesa sanitaria?
Questo è quanto mi è stato riferito nell'ultima riunione tenutasi presso l'ufficio proprio dal vice presidente dell'osservatorio dell'OPG di Aversa, il quale teneva a precisare che il grosso nocciolo è rappresentato dall'interrogativo che emerge in sede di predisposizione di un progetto di dimissione, quando occorre decidere a quale ASL affidare la responsabilità e la gestione dell'ex detenuto. Ho risposto che avrebbero potuto risolvere il problema tra di loro; l'importante e` che mi dicano che il soggetto trova a Napoli un centro di salute mentale che lo accoglie e poi si rivale delle spese oppure il soggetto se ne va, faccio per dire, ad Agrigento (se è di Agrigento) ed il centro di salute mentale di Agrigento si fa carico della spesa. Sembra che sia uno dei grossi quiz: al momento non ha ancora trovato soluzione» (225).
Al di là del linguaggio piuttosto semplice e atecnico usato dal magistrato, stupisce, da un lato la naturalezza e la semplicità con cui si afferma il vincolo di subordinazione tra il referente sanitario e il direttore penitenziario (viene addirittura usato il termine “subire”), sintomatico di una cultura e di una formazione che continua a considerare gli O.P.G. più carceri che ospedali, dall'altro la sicurezza acritica con cui si individua il responsabile dell'inefficienza: le Aziende sanitarie locali, colpevoli di aprire annose diatribe su chi debba accollarsi i costi dell'inserimento dell'internato, come a voler acuire un attrito tra poteri dello Stato, non agevolando di certo il gioco di squadra, tra realtà sanitaria e realtà giuridica-penitenziaria.
1.6.17 2010-2011: L'O.P.G. in diretta
A cavallo tra l'estate del 2010 e l'inverno del 2011 l'universo O.P.G. è stato sconquassato da un avvenimento se non unico, per lo meno, molto raro nella storia repubblicana. La Commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Senatore Ignazio Marino, ha scelto di indagare approfonditamente la problematica O.P.G., in quanto materia di pubblico interesse, in forza del potere conferitole ex art. 82 Costituzione (226).
Tale inchiesta è particolarmente interessante, poiché presenta almeno due aspetti di assoluta novità, riguardanti le modalità con cui è stata condotta e divulgata, oltreché, ovviamente, per i risultati ottenuti.
Il primo aspetto riguarda l'effetto sorpresa, sottolineato dallo stesso Presidente: «Siamo riusciti, con un sopralluogo davvero a sorpresa, essendo chiaramente inaspettati, a scoprire situazioni che, probabilmente, se fossimo stati anche soltanto minimamente annunciati, non avremmo certamente trovato» (227). Le visite sono avvenute: l'11 giugno agli O.P.G. di Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto, il 22 luglio 2010 a Montelupo Fiorentino e Napoli, il 23 luglio a Castiglione delle Stiviere e Reggio Emilia.
Il secondo aspetto riguarda, l'uso di innovativi e insoliti, per un'inchiesta parlamentare, strumenti d'indagine. Ogni visita è stata infatti filmata e le immagini raccolte sono diventate un film documentario dall'eloquente titolo “Ergastolo bianco-O.P.G., dove vive l'uomo” del regista Francesco Cordio. È la prima volta che le telecamere sono riuscite ad entrare all'interno degli O.P.G. (228), il fatto è ancor più interessante se si pensa che uno stralcio del video è stato trasmesso il 20 marzo 2011 dalla trasmissione Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai Tre.
Lo strumento video diventa sorprendentemente strumento di azione politica, in grado di aumentare la percezione dell'O.P.G. come problema sociale, una sorte di imprenditore morale “multimediale”, riformulazione ultramoderna della già descritta teoria sociologica di Becker (229).
Nella pratica i risultati ottenuti dalla Commissione sono certamente di buon auspicio nell'ottica di un definitivo superamento degli O.P.G.
Vediamo nel dettaglio quali sono stati gli obiettivi più importanti raggiunti dalla Commissione:
1) Relazioni dettagliate su condizione degli O.P.G.: grazie alle visite a sorprese della Commissione d'inchiesta e alle successive audizioni dei soggetti interessati (direttori penitenziari, referenti sanitari, cappellani, magistrati di sorveglianza) si può oggi avere una descrizione dettagliata sullo stato di salute degli O.P.G. e dei suoi internati. Il dato certamente più rilevante è l'individuazione, su una popolazione internata di 1510 soggetti (230), di 389 pazienti dimissibili, secondo i già visti parametri fissati dal DPCM 1 aprile 2008 (231). Nello specifico: 105 ad Aversa, 80 a Barcellona Pozzo di Gotto, 68 a Castiglione delle Stiviere, 60 a Montelupo Fiorentino, 37 a Reggio Emilia, 39 a Napoli-Secondigliano (232).
Il 20% della popolazione internata insomma potrebbe, o meglio, dovrebbe uscire dall'O.P.G. ed essere inserito in strutture diverse (comunità terapeutiche, centri diurni, gruppi appartamento) e comunque affidati ai DSM territoriali, nel solco del dictum più volte ribadito dalla Corte Costituzionale: «Le esigenza di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente: e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze».
Proprio dal singolare fenomeno delle mancate dimissioni, nasce l'annosa questione delle proroghe delle misure di sicurezza e della loro trasformazione in un c.d. ergastolo bianco.
Qui interessa invero soltanto constatare in concreto i risultati ottenuti dalla Commissione Marino, ben sintetizzati nella tabella seguente.
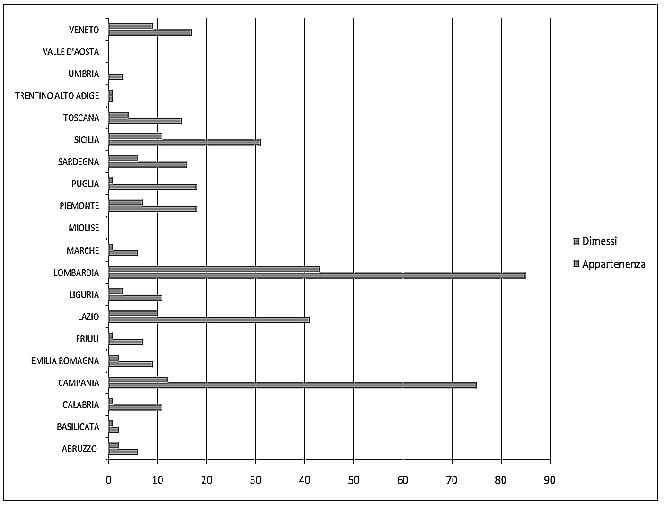
Una sola Regione, il Trentino Alto Adige, ha saputo riaccogliere sul proprio territorio il 100% dei pazienti dimissibili. Il dato non è certo confortante visto che vi era un solo internato trentino dimissibile.
Non è questa la sede per indagare, regione per regione, i motivi delle mancate dimissioni e le eventuali responsabilità. Sarebbe troppo semplicistico addossare la colpa di questo insuccesso al solo “territorio”, che tuttavia non sempre è all'altezza delle aspettative, basti pensare al mancato accesso accesso al fondo previsto dalla Legge finanziaria 2008, destinato all'attuazione del DPCM 1 aprile 2008 e ad agevolare la presa in carico dei pazienti dimissibili.
Solo il 50% delle Regioni infatti ha presentato un progetto e ottenuto l'accesso al fondo. La parte restante (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Valle d'Aosta) ha preferito restare inadempiente e rinunciare alle somme governative.
Tuttavia occorre precisare che le ragioni della mancata dimissione possono essere molteplici e variegate. Si prendano, ad esempio, due casi paradigmatici poiché agli antipodi: l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, ancora totalmente controllato dal Dap, per le già viste ragioni di non recepimento da parte della Regione autonoma Sicilia del DPCM 1 Aprile 2008 e l'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere, l'unica struttura completamente sanitarizzata fin dalla sua creazione nel 1938, in forza di una convenzione tra Stato e Azienda Sanitaria locale di Mantova. Le due strutture ospitano un numero confrontabile di internati dimissibili: 80 a Barcellona Pozzo di Gotto e 68 a Castiglione delle Stiviere.
Alla luce delle sollecitazioni della Commissione, al 31 maggio 2011 la situazione risulta essere la seguente.
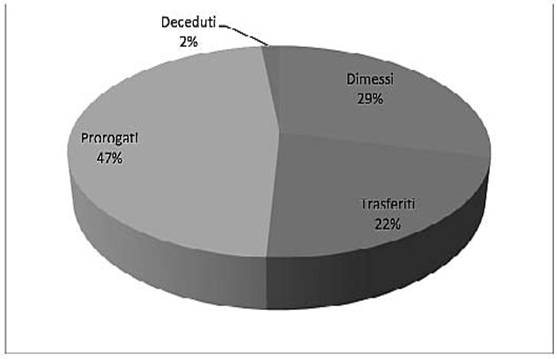
Ecco lo scorporo delle percentuali, dal quale si deducono i motivi delle mancate dimissioni:
Pazienti trasferiti ad altro O.P.G.: 13
Pazienti deceduti: 1
Pazienti prorogati: 49 (di cui 8 a causa del fallimento di una licenza finale d'esperimento, 1 ritenuto socialmente pericoloso, 6 per il rifiuto ad uscire dall'OPG, 6 senza fissa dimora, 9 risultano internati ma fanno parte del progetto Luce e Libertà (235), 10 in attesa di un posto in una comunità, 9 per la mancata presa in carico delle ASL di appartenenza).
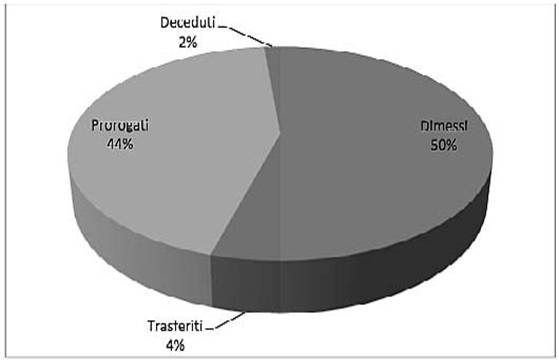
Scorporo dati:
Pazienti trasferiti ad altro OPG: 3
Pazienti deceduti: 1
Pazienti prorogati: 30 (di cui 3 a causa del fallimento di una licenza finale d'esperimento, 3 ritenuti non dimissibili, 4 per il rifiuto ad uscire dall'OPG, 14 in attesa di un posto in una comunità, 4 per la mancata presa in carico delle ASL).
La differenza tra le due situazioni è rilevante, poiché le percentuali dei dimessi da Castiglione sono sostanzialmente doppie al dato di Barcellona, mentre vi è un certo equilibrio a riguardo dei motivi delle mancate dimissioni, dove resta preminente il numero di soggetto in attesa di entrare in comunità e di quelli che non vengono presi in carico dalle Asl di appartenenza.
Tale situazione sottolinea, ancora una volta, la necessità di una maggiore collaborazione tra soggetti e istituzioni coinvolte. Tale carente coordinamento crea, tralasciando il non secondario aspetto etico e umano, una quotidiana e sistematica violazione della legge, ancor più grave se giustificata da un insostenibile fatalismo, che, almeno statisticamente, viene finalmente condannato. È tempo tuttavia che la statistica si faccia realtà.
2) Se finora il lavoro della Commissione si è mantenuto su un piano statistico-descrittivo, diventa di gran lunga più pervicace con riguardo ai provvedimenti assunti con delibera durante la seduta del 26 luglio 2011, riguardanti gli O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto e di Montelupo Fiorentino (236).
Con tali “atti gemelli” la Commissione fa valere i poteri conferiti dalla Costituzione, nonché dal Regolamento interno (237), che equiparano la sua attività a quella di un organo giurisdizionale, promuovendo azioni cautelari in attesa che, ad inchiesta conclusa, sia il Senato a decidere, su indicazioni contenute nella Relazione conclusiva della Commissione, quali saranno i provvedimenti definitivi più opportuni.
Si tratta tuttavia di provvedimenti cautelari con un alto valore tanto simbolico quanto effettivo, posti in essere poiché la Commissione ha ritenuto che «le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie riscontrate, sono tali da recare pregiudizio a diversi diritti costituzionalmente garantiti dei pazienti ricoverati: segnatamente il diritto a modalità di privazione della libertà non contrarie al senso di umanità, il diritto fondamentale alla salute, il diritto all'incolumità» e che «la descritta situazione vanifica, almeno in parte, la fruttuosità dell'inchiesta parlamentare, in quanto, con ragionevole grado di certezza, a causa della stessa si determineranno, si protrarranno, si aggraveranno, lesioni a diritti costituzionalmente garantiti, e ciò prima ancora che il Senato della Repubblica sia in condizione di intervenire con gli atti legislativi o di indirizzo indicati in sede di relazione conclusiva della Commissione».
Visti e riscontrate le violazione degli gli artt. 328 (Rifiuto ed omissione di atti d'ufficio), 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e 591(Abbandono di persona minore od incapace) c.p., la Commissione ritiene opportuno di disporre un provvedimento di «sequestro con ordine di sgombero delle porzioni di struttura più avanti specificate, dalla cui delibera disponibilità e perdurante operatività deriverebbe causazione, aggravamento e protrazione delle suddette lesioni a diritti costituzionalmente garantiti».
Nello specifico a Montelupo si ordina che entro trenta giorni vengano sgomberate 21 celle della sezione Ambrogiana, mentre a Barcellona, entro lo stesso termine, dovrà liberarsi l'intero reparto I.
Al contempo la Commissione cerca di porre un freno al drammatico e anacronistico uso della contenzione fisica, in atto in entrambi gli istituti, con situazione molto simili. La sala delle contenzioni dell'O.P.G. siciliano è così descritta: «Priva di idonei strumenti di monitoraggio a distanza e di segnalazione delle emergenze da parte del soggetto coercito, nonché irraggiungibile in maniera sollecita dal personale sanitario, essendo le chiavi di accesso nella esclusiva disponibilità del personale penitenziario, nonché provvista di un letto di contenzione in ferro, con rete rigida e non articolabile, ancorato al suolo, tale da rendere impossibile l'assunzione di una posizione seduta o semiseduta da parte del coercito, nonché adibita a prassi di contenzione che, secondo evidenze documentali, sono ricondotte a “trattamento sanitario obbligatorio”, in assenza di atti presupposti previsti dalla legge». Poco cambia nella struttura toscana. Entro quindici giorni le sale di contenzioni, in questi due istituti dovranno essere dismesse.
Tra sequestri, sgomberi eseguiti dai N.A.S. dei Carabinieri, delibere di Commissioni parlamentari che descrivono situazioni non dissimili a quelle dei manicomi criminali di inizio Novecento, la tormentata storia della esecuzione penale dei folli-rei diventa attualità.
Nonostante l'impegno, più o meno costante, di legislatore, giurisprudenza, scienza psichiatria, sociologica e forense, «siamo ancora qui a parlare di O.P.G.» (238).
Ora che il quadro dell'evoluzione storica di questa istituzione totale è completo, è possibile volgere lo sguardo ad un oltre etico e giuridico, capace di imparare dagli errori e dalle incertezza del passato, per tornare a navigare verso un orizzonte legale, geograficamente omogeneo e socialmente sostenibile.
Se è vero che l'istituzione totale è «violenza, poiché è capace di alterare tutti i cinque sensi» (239) è pur vero che è importante «simbolizzare il limite della legge, in una società apparentemente senza limiti» (240), soprattutto nei confronti di quella piccola, ma significativa quota di folli-rei, “ad alta pericolosità sociale”.
La psichiatria da un lato e il diritto dall'altra, devono saper accogliere, ma anche delimitare, riscoprendo gli aspetti positivi e necessari del «codice paterno a discapito del troppo considerato codice materno» (241).
Utopistico, ma addirittura nocivo quindi, è pensare che ogni barriera debba essere abbattuta, pensare che Marco Cavallo possa, dall'oggi al domani, correre senza steccati, senza quei “no, che aiutano a crescere e ad autolimitarsi”.
In tempi di crisi, economica e non solo, occorre tuttavia interrogarsi sul come costruire quello steccato. Darsi, come società, delle priorità e degli obiettivi, senza nascondersi dietro a fastidiosi alibi quantitativi o, ancor peggio, finanziari.
Quella per il superamento degli O.P.G. sarà pure una battaglia simbolica, ma è anche da qui che «si misura il livello di civiltà di una società» (242).
Note
1. Michel Foucault, Sorvegliare e Punire. Nascita della Prigione, Einaudi, Torino, 1976, p. 79.
2. Ibidem, p. 80.
3. Ibidem, p. 81.
4. L'“arretramento” e l'“avanzamento” sono da intendersi nel senso squisitamente storico dello sviluppo della società secondo Foucault, scevri, almeno in questa fase, da ogni giudizio etico-giuridico.
5. Società e Comunità, vengono qui scientemente considerati sinonimi e quindi interscambiabili, ma occorre notare come autorevole dottrina sociologica si sia lungamente dibattuta sulle lorodifferenze, considerando la Società, «a priori struttura aperta», e la Comunità, «a priori struttura chiusa». A riguardo si considerino Lelio Demichelis Bio-Tecnica. La società nella sua forma tecnica, Liguori Editore, Napoli, 2008 e dello stesso autore Società o Comunità, Carrocci Editore, Roma, 2011.
6. Per una dettagliata analisi statistica-numerica si veda infra Cap. III.
7. Pierre Bourdieu, La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique, in Actes de la recherche en sciences sociales, n.64, 1986, p. 3-19.
8. Sulla innovativa nozione di campo giuridico del penitenziario, cfr. Claudio Sarzotti, Il campo giuridico del penitenziario, appunti per una ricostruzione, in AA.VV., Diritto come questione sociale, Giappichelli, Torino, 2010.
9. A.J. Arnaud, M.J. Farinas Dulce, Introduction à l'analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 166.
10. Erhard Friedberg, Il potere e la regola. Dinamiche dell'azione organizzata, Etas Libri, Milano, 1994.
11. D'ora in poi, indicati con il più funzionale acronimo O.P.G.
12. Guido Neppi Modona, in Christian De Vito, Camosci e girachiavi, Storia del carcere in Italia, Edizioni Laterza, Bari, 2009, p. 9.
13. Il sociologo torinese Mauro Rostagno per raccontare in una lettera all'amico Renato Curcio la sua nuova vita da giornalista televisivo dell'emittente trapanese Rtc scrive: «Ho scelto di non fare televisione seduto dietro a una scrivania, ma in mezzo alla gente, con un microfono in pugno mentre i fatti succedono. Sociologicamente si chiama 'primato dell'esistenza sul teorico'. E già questo a Trapani è profondamente antimafioso». Sarà proprio questo metodo di lavoro assolutamente innovativo, irriverente e rivoluzionario ad armare la mano del killer di mafia Vincenzo Virga che il 26 settembre 1988 uccide, su ordine di Totò Riina, Mauro Rostagno. Sulle controverse vicende della vita di Mauro Rostagno e sul lungo e complesso iter processuale riguardante il suo assassinio si veda Enrico Deaglio, L'ultima vittoria di Mauro Rostagno, Diario, Anno XIII, n.10; Giulia Destefanis, Non vedo, non sento, non parlo. Le Strategie di contrasto della mafia nei confronti dei media, Tesi di Laurea, Università Cattolica Sacro Cuore, Milano, 2009 e Maddalena Rostagno e Andrea Gentile, Il suono in una sola mano, Il Saggiatore, Milano, 2011.
14. Cfr. Stephen Hester and Peter Englin, Sociology of Crime, Routledge, Londra, 1992, p. 42.
15. Considerati da Hester ed Englin: l'interazionismo simbolico, l'etnometodologia, e la teoria del conflitto strutturale (nel solo aspetto storico-interpretativo della costruzione del crimine e non in quello causale e struttural-determinista).
16. Hernest Blumer, Symbolic Interactionism, University of California Press, Berkeley, 1969.
17. S. Hester e P. Englin, op. cit., p. 43.
18. È proprio sull'errore del positivista di ridurre tutto a statistica, dimenticando la fondamentale variabile del contesto storico-geografico-culturale, che la critica di Blumer si fa più aspra.
19. Sulla Teoria dell'Etichettamento, si veda Howard S. Becker, Outsiders-studies in the sociology of deviance, Paperback edition, New York, 1966 e S. Hester e P.Englin, p. 93 e ss.
20. S. Becker, op. cit., p. 22.
21. Così gli interazionisti definisco il processo attraverso il quali i soggetti vengono etichettati.
22. Proprio sul processo di selezione del crimine da parte delle forze dell'ordine, si concentra l'analisi di Hester e Englin, op. cit., cap V “Policing as symbolic interaction”.
23. È necessario qui richiamare brevemente la definizione di crimine data dal sociologo canadese John Hagan, riassunta da Odillo Vidoni Guidoni, La criminalità, Carrocci-Le bussole, Roma, 2004, p. 67-72. Nella c.d. piramide del crimine haganiana il crimine viene definito a seconda della maggiore o minore gravità sociale, seguendo tre parametri: l'accordo sulla valutazione negativa dell'azione criminale, la percezione del danno sociale prodotto e la severità della reazione sociale. Quest'ultimo parametro può variare dalla semplice derisione all'ostracismo o peggio al vero e proprio allontanamento dalla comunità. Il grado di severità sociale corrisponde tendenzialmente, salvo eccezioni alla durezza della sanzione penale. La combinazione dei tre parametri haganiani permette di distinguere tra crimini consensuali, crimini conflittuali, devianze sociali o semplici diversioni sociali.
24. Cfr. Ulrich Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, 1 ed., traduzione di Walter Privitera e Carlo Sandrelli, Carrocci Editore, Roma, 2000.
25. Silva Sànchez, L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società industriali, Giuffrè-Quaderni di diritto penale comparato internazionale ed europeo, Milano, 2004, p. 11.
26. Paolo Marconi, Spazio e sicurezza. Descrizione delle paure urbane, Giappichelli, Torino, 2004, p. 57.
27. «Negli anni Cinquanta e Sessanta, a differenza delle classi economicamente svantaggiate e di quelle medio basse, le classi medie dei professionisti difficilmente avevano esperienza diretta di eventi criminoso» (il riferimento è soprattutto agli episodi della c.d. microcriminalità, N.d.A), David Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, Net edizioni, Milano 2007, p. 257.
28. Marco Pelissero, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Giappichelli, Torino, 2008, p. 17.
29. V. supra nota 23.
30. Vidoni Guidoni, op. cit., p. 69.
31. Pelissero, op. cit., p. 19.
32. «L'opinione pubblica è oggi più incline a identificarsi nella vittima più che nell'arbitro, nel governato più che nel governante, nel contropotere più che nel potere, nel giustiziere più che nel legislatore». Antoine Garapon, I custodi del diritto, Giustizia e democrazia, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 86.
33. Garland, op. cit., p. 71.
34. L'Osservatorio di Pavia nasce nel 1994 e si sviluppa come istituto di ricerca e di analisi della comunicazione. L'obiettivo fondante dell'Osservatorio è la tutela del pluralismo sociale, culturale e politico nei mezzi di comunicazione. Si occupa principalmente della compilazione e divulgazione del Rapporto Media e Sicurezza in collaborazione con Demos e Fondazione Unipolis.
35. Chiaramente il rilevamento del numero di reati, come d'altronde la maggior parte dei rilievi statistici, non può tener conto del c.d. numero oscuro, cioè di quella quantità di reati che, per le ragioni più disparate, non vengono denunciati, rimanendo quindi “non conosciuti” e quantitativamente incalcolabili.
36. Il concetto di notizia è qui da intendersi dal punto di vista gioralistico-mediatico.
37. Si considerano esclusivamente il numero assoluto di servizi dedicati a episodi di c.d “cronaca nera” dei sette telegiornali principali (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7) nelle edizioni serali (prime time).
38. Su un campione di 2000 famiglie eterogeneamente selezionate sul territorio italiano, si considera la percentuale di coloro che hanno risposto “Poco” o “Per nulla”, alla domanda “Quanto consideri il tuo Paese sicuro?”.
39. Vi sono tendenzialmente uno o due “casi criminali” all'anno; il picco più recente (secondo semestre 2010) è dovuto al delitto di Avetrana. In soli 4 mesi (dal 29 agosto 2010, giorno della scomparsa al 31 dicembre 2010) l'uccisione della giovane Sarah Scazzi è stato affrontata 867 volte. In assoluto il “caso criminale” più rilevante in Italia nell'ultimo decennio, resta il delitto di Cogne con 2032 servizi (dal 30 gennaio 2002 al 31 dicembre 2010). Fonte: IV Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in Europa (Osservatorio di Pavia).
40. IV Rapporto sulla Sicurezza in Italia e Europa (Osservatorio di Pavia), p. 44-49.
41. La quantità di notizie riferite a crimini è nettamente superiore per Rai 1: 1023 notizie contro le 514 di Tve, le 307 di Bbc One, le 255 di France 2 e le 60 di Ard, una media per l'Italia di quasi tre notizie al giorno.
42. Paola Barretta e Antonio Nizzoli (a cura di), IV Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in Europa, Osservatorio di Pavia, Pavia, 2011, p. 49.
43. Peter Alexis Albrecht, Kriminologie. Eine Grundlegung zum Strafrecht, Verlag C.H. Beck, Monaco, 2005, p. 371.
44. Pelissero, op. cit., p. 17.
45. Gianluigi Ponti e Isabella Merzagora, Psichiatria e giustizia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1993, p. 86.
46. Cfr. David Garland, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford, 2001.
47. Per una analisi più compiuta della “privatizzazione della sicurezza”, sia sul piano internazionale dei conflitti bellici tra Stati, sia su un piano interno di gestione dell'ordine pubblico cfr. Simon Chesterman and Chia Lehnardt, From Mercenaries to market, The Rise and Regulaton of Private Military Companies, Oxford, Oxford University Press, 2007. Gli autori individuano storicamente due cause scatenanti della privatizzazione: (a) la fine della Guerra Fredda tra blocco Occidentale e blocco Sovietico, che produsse circa 7 milioni di personale militare senza occupazione, i quali furono riassorbiti in gran parte dalle nascenti agenzie di sicurezza privata (le c.d. Private Security Companies o contractors); (b) la neoliberal rush (la svolta neoliberista), che a partire dagli Anni Ottanta, grazie alle politiche economiche di Margaret Thatcher nel Regno Unito e Ronald Reagan negli Stati Uniti, influirono sugli gli assetti dei mercati internazionali in nome del “To commercialize whatever can be commercialized” (privatizzare tutto ciò che può essere privatizzato).
48. Alessandro De Giorgi, Commento all'opera di Garland, Jura Gentium, 2005.
49. Garland, op. cit., p. 228.
50. Pelissero, op. cit., p. 22.
51. È lapalissiano che il privato cittadino che monta una telecamera a circuito chiuso è ormai considerato “normalità” e non crea certo quel consenso e quella visibilità della reazione sociale, che invece trasmette la “militarizzazione” di interi quartieri da parte delle forze di polizia o una maxi retata (per usare un linguaggio volutamente sensazionalista) organizzata per contrastare la prostituzione, piuttosto che lo spaccio di stupefacenti in determinati contesti urbani. Il primo comportamento è una tipica risposta adattiva, il secondo è una risposta non adattiva.
52. De Giorgi, op. cit.
53. Massimo Pavarini, I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia della pena, Edizioni Martina, Bologna, 1994, p. 450-455.
54. Intendendo attori economici, che non hanno, nè economicamente nè organizzativamente, alcun legame con le Istituzioni pubbliche o con le Agenzie statali in genere.
55. L'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce infatti: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».
56. Pelissero, op. cit., nota 104 p. 23.
57. Il testo completo della legge è consultabile online.
58. Pier Luigi Vigna, Legislazione complementare per la Polizia di Stato, Laurus Robuffo, Roma, 2008, p. 138 e ss.
59. È proprio in nome di questi condizionamenti che lo psicotico ha un “passaggio all'atto”, cioè compie il reato.
60. Pelissero, op. cit., p. 23.
61. Garapon, op. cit., p. 91.
62. Quella della “finestra rotta” (Broken window Theory) è la metafora usata nel 1982 dai criminologi James Wilson e George Kelling per spiegare la necessità della funzione retributiva della pena e l'importanza di un intervento tempestivo e severo dell'Autoità per evitare, soprattutto in determinati contesti urbani degradati, che l'imitazione del crimine possa generare una spirale di violenza difficile da interrompere, poiché la criminalità è, per sua stessa natura, contagiosa. Cfr. Wilson e Kelling, Broken windows, in The Atlantic Monthly, 1982, p. 29.
63. Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, Manuale di Diritto Penale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 10.
64. Cfr. Garland, op. cit., p. 239 e ss.
65. Cfr. Emilio Dolcini, Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2006, n.2-3, p. 69.
66. De Leonardis, Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio, Giuffrè, Milano, 2005.
67. La riflessione di Antonio Scurati (La Stampa, 24 luglio 2011) riguarda la strage di Oslo: il 22 luglio 2011 il trentaduenne Anders Behring Breivik irrompe nell'isola norvegese di Utoeya, dove era in corso un campeggio organizzato dai Giovani Laburisti Norvegesi e fredda a colpi di fucile 93 persone. È sociologicamente interessante notare che, per quasi ventiquattr'ore, inquirenti e mass-media accreditano “la pista islamica”. Breivik è invece un norvegese, fondamentalista cristiano e legato politicamente alla destra xenofoba. Ecco parte dell'analisi di Scurati: «Tutti gli Anni 50 e 60 sono stati dominati da una forma di paura esternalizzante. Il mondo suddiviso in blocchi induceva a proiettare ogni male sul nemico comunista esterno, applicando il paradigma proiezione-esclusione (tutto il male viene da fuori, nessuno deve venire da fuori) e paventando l'invasione (da qui anche la fortuna della fantascienza). Ma già a cominciare dai '70 quel paradigma è stato scalzato da quello del “nemico in casa”. I feroci comunisti oramai crescevano nelle nostre dimore, erano i nostri figli ideologicamente traviati, i terroristi nostrani. Di questo passo la paura si «internalizzava». Tramontato il terrorista autoctono, a subentrargli nell'immaginario del terrore furono altri nemici interni: i serial killer psicopatici alienati dalla vita metropolitana iperconsumista (oppure ancora i nostri figli adolescenti alienati da quella stessa vita ma in cerca della nostra eredità). La vergognosa menzogna con cui la destra spagnola cercò di strumentalizzare le stragi di Atocha attribuendole all'Eta segnò l'ultima occasione in cui si cercò di riesumare il paradigma introiezione-eliminazione a discapito di quello proiezione-esclusione. Non funzionò. La mossa fallì anche perché cadeva nel pieno di un decennio tutto consacrato al “nemico esterno”. La reazione psico-mediatica all'attentato di Oslo ci dice che, purtroppo, non siamo ancora usciti da quel decennio. E allora torna l'interrogativo di prima: che effetti sta producendo sulla nostra comunità il perdurare di questa forma di paura? L'effetto principale va ricercato nella rimozione di una verità inconfessabile che il paradigma proiezione-esclusione porta sempre con sé. A volte questa rimozione si spinge fino alla denegazione: la verità è lì, davanti agli occhi di tutti, eppure ci si ostina a non vederla. In questo caso, la verità denegata è che buona parte del sentimento e del pensiero reazionario della destra europea -soprattutto quella nordica ma non solo -è fortemente tentato da una deriva violenta, xenofoba e razzista. E' questo il nemico interno occultato e alimentato dal fantasma del nemico esterno (...)».
68. Sul medesimo fatto criminale (v. supra nota 60), Ilvo Diamanti (La Repubblica, 24 luglio 2011) nota: «(...) il riflesso condizionato degli osservatori e dei commentatori, di fronte a tanto orrore, ha reagito, dapprima e a lungo, cercando una spiegazione coerente -e in fondo rassicurante -con le proprie ragioni, i propri giudizi -e pregiudizi... Richiamando il fantasma delle cellule Qaediste, la Jiad. In altri termini: il Terrore Islamico che aizza lo Scontro di Civiltà. Il Nemico evocato, subito, sulle cronache delle edizioni on-line (talora, anche cartacee) dei giornali. Alcuni, in particolare, particolarmente riluttanti -e renitenti -a rassegnarsi, anche di fronte all'evidenza. Invece no. L'assassino, il Mostro, è un giovane norvegese. Biondo, cristiano fondamentalista, anti-islamico. È difficile sopportare il disagio e la vertigine prodotti da questa vicenda. Troppo incoerente e irragionevole di fronte alle nostre ragioni - e alla nostra ragione. Noi: costretti ad ammettere che l'Odio può esplodere dove si coltiva il bene comune. In modo più violento che altrove. E si può esprimere, in modo in-descrivibile, nel “nostro” mondo, per mano dei “nostri”. Non dell'Altro: il “nemico” islamico e terrorista».
69. Su cui, per un'analisi più approfondita, cfr. Cap. II.
70. Pelissero, op. cit., p. 24.
71. Marinucci e Dolcini, op. cit., p. 572-573.
72. La definizione è di Indro Montanelli (Corriere della sera, 18 gennaio 1998) che definì la famiglia Rocco «un allevamento di cavalli di razza», poiché tutti e quattro i figli maschi diventarono fini giuristi: oltre ad Alfredo, Arturo fu professore di diritto e procedura penale all'Università di Sassari, Napoli e Roma e fondatore della scuola moderna del tecnicismo giuridico, Ugo, professore ordinario di diritto processuale civile a Napoli e Ferdinando, presidente del Consiglio di Stato dal 1947.
73. Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, parte I, 1929, p. 244.
74. Marinucci e Dolcini, op. cit., p. 572.
75. Seguendo la precisa analisi di Guido Neppi Modona, Legislazione penale, in Il mondo contemporaneo, vol.I, tomo 2, La Nuova Italia, Firenze, 1978, p. 584 e ss, vale la pena fare una breve precisazione sui principi salienti dei due orientamenti dottrinali citati: «La Scuola classica, maturata nell'ambiente politico-culturale di derivazione illuministica, riteneva che l'uomo fosse assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni e poneva quindi, a fondamento del diritto penale, la responsabilità morale del soggetto intesa come rimproverabilità per il male commesso e una concezione etico-retributiva della pena. Il merito di questo orientamento è la razionalizzazione di principi quali quello della materialità e offensività del fatto, della colpevolezza, dell'imputabilità, della retribuzione della pena. Tre sarebbero invece i principali limiti: aver relegato il diritto penale nella sfera astratta di un diritto naturale razionalistico lontano dalla realtà naturalistica, aver limitato la difesa sociale dalla criminalità alla sola pena, non avere prestato attenzione alla esecuzione della pena e quindi alle finalità di recupero del reo, in quanto per i classici il problema penale ha termine con il passaggio in giudicato della sentenza.
La Scuola positiva, che conta tra i suoi principali esponenti Lombroso, Ferri, Grispigni affonda le proprie origini filosofiche nel positivismo metodologico della fine del XIX secolo. In opposizione al postulato del libero arbitrio affermavano il principio del determinismo causale dal quale discendevano i seguenti corollari: 1) Il reato non interessa più come ente giuridico distinto dall'agente, ma come fatto umano individuale che trova spiegazione nella struttura bio-psicologica del delinquente, quale espressione della pericolosità del soggetto; 2) al posto della volontà colpevole, della responsabilità morale e dell'imputabilità viene a sostituirsi la pericolosità sociale, intesa come probabilità che il soggetto sia spinto a compiere dei reati; 3) un sistema di misure di sicurezza viene a sostituirsi alla pena retributiva. La Scuola positiva ha così sottolineato il problema della personalità del delinquente e dei suoi condizionamenti bio-psico-sociologici, ha avuto il merito di avere tenuto conto della realtà sociale in cui il reato viene a compiersi e di aver introdotto accanto alla tradizionale prevenzione generale l'idea della prevenzione speciale e della risocializzazione del delinquente. Tra i suoi limiti: l'aver deresponsabilizzato l'individuo attraverso le schematizzazioni deterministiche, l'aver rimesso in discussione le garanzie di legalità e di certezza in nome della difesa sociale e della giustizia concreta una volta aver incentrato il diritto penale su tipologie criminologiche di autori. Lo stesso principio nulla poena sine delicto veniva messo in discussione, dal momento che era stata sostituita la colpevolezza per il fatto con la pericolosità: quindi anche i soggetti che risultavano pericolosi socialmente, pur non avendo ancora commesso il fatto, avrebbero dovuto essere sottoposti a misure di sicurezza».
76. Si omette scientemente di affrontare i problemi giuridici causati da tale presupposto, perché poco funzionali alle tematiche affrontate in questo lavoro, tuttavia per una disanima più ampia e completa cfr. Marinucci e Dolcini, op. cit., p. 574-575.
77. Cfr. Roberto Garofalo, Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione, Fratelli Bocca, Torino, 1891.
78. Vincenzo Mastronardi, Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi, Giuffrè, Napoli, 2001 (IV edizione), p. 118.
79. La norma era stata più volte censurata anche da importanti decisioni della Corte Costituzionale: su tutte la sentenza 139 del 1982 e la 249 del 1983. Vedi infra cap. II.
80. L'art. 31.2 della Legge Gozzini dispone infatti: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è pericoloso socialmente».
81. Fondamentale anche la lettura dell'art. 679 c.p.p. E dell'art. 69 ord.penit., poiché “vanno oltre” il codice penale e prevedono che per applicazione della misura di sicurezza la pericolosità sociale debba persistere nel momento in cui la misura deve essere eseguita e che il magistrato di sorveglianza possa revocare la misura anche prima che sia decorsa la durata minima fissata in fase di cognizione.
82. Pelissero, op. cit., p. 36.
83. Marinucci e Dolcini, op. cit., p. 572.
84. Massimo Niro è magistrato di sorveglianza a Firenze, si cita qui la relazione “Misure di sicurezza e alternative all'O.P.G.”, tenuta durante il convegno “La salute mentale dei detenuti e degli internati in Toscana: presente e futuro.”, Villa Demidoff, Firenze, 11 luglio 2008.
85. Adelmo Manna, Imputabilità e nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzione giuridiche” alla “terapia sociale”, Giappichelli, Torino, 1997, p. 64.
86. Cfr. ibidem, p. 67.
87. Art. 220 c.p.p.: «La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».
88. Manna, op. cit., p. 67.
89. Cfr. Pelissero, op. cit., p. 110 e ss.
90. Dessenker, Gefahrlichkeit und Verhaltnismaßigkeit. Eine Untersuchung zum Maßregelrecht, Berlino, 2004, p. 184.
91. Sui quali cfr. diffusamente Padovani, La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense, vol. XIII, Giuffrè, Milano 1990.
92. La dottrina risalente ha dato vita a un lungo dibattito sui rapporti concettuali tra imputabilità e colpevolezza. L'ambiguità è data dalla scelta del codice Rocco di non collocare sotto lo stesso titolo sia le disposizioni sulla colpevolezza che quelle sull'imputabilità, ricalcando così la tradizione dettata dal codice Zanardelli. Il codice del 1930 crea invece sistematicamente due concetti diversi: con l'art. 42 c.p. definisce la colpevolezza, con l'art. 85 c.p. l'imputabilità. Tuttavia le differenza tra coscienza e volontà della condotta ex art. 42 e capacità di intendere e volere ex art. 85 non apparivano così evidenti. Oggi invece dottrina e giurisprudenza hanno pacificamente accettato come distinti i due principi: l'imputabilità precede ontologicamente la colpevolezza, perché è una condizione del soggetto, un dato preesistente alla volizione e pertanto, esistente anche indipendentemente da essa e dalla commissione di alcun atto penalmente rilevante. L'imputabilità, in definitiva, non è una qualificazione della volontà perché si pone su un piano preliminare ed è come se stesse “fuori” dal reato, in quanto entità indipendente. Cfr. Dawan, op. cit., p. 38-39.
93. Paolo Girolami e Ugo Palagi, Imputabilità e pericolosità sociale tra essere e dover essere. Notazioni medico giuridiche, in Giurisprudenza Penale, numero I, 1999, p. 146.
94. Cfr. Daniela Dawan, I nuovi confini dell'imputabilità nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2 e ss.
95. Così si definisce la parte dinamica di una perizia psichiatrica per stabilire la capacità di intendere e volere, contrapposta alla parte statica (il classificare).
96. Ugo Fornari e Silvia Coda, imputabilità e pericolosità sociale: nuove prospettive nella valutazione forense, in Adelmo Manna, op. cit., p. 53.
97. Cfr. Marinucci e Dolcini, op. cit., p. 295 e ss.
98. Si parla, in questo caso, di presunzione assoluta di non imputabilità.
99. L'elenco non è da considerarsi tassativo, anzi è la stessa giurisprudenza ad aver rilevato ulteriori casi di incapacità di intendere e volere, tra le estensioni del principio ex art. 85 c.p. più interessanti vi sono: la suggestione ipnotica, la suggestione in veglia e la segregazione dalla nascita.
100. Dawan, op. cit., p. 33.
101. Dawan, op. cit., p. 22.
102. È interessante notare come, dal punto di vista lessicale, il codice penale, pur considerando il concetto di imputabilità saliente e centrale, non riesce ad andare oltre a “definizioni in negativo” che dicono cosa non è l'imputabilità, elencando categorie di soggetti non imputabili.
103. AA.VV., Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1930.
104. Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte Generale, Giuffrè, Milano, 2008.
105. Cfr. Marta Bertolino, L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale italiano, Giuffrè, Milano, 1990.
106. Cosa che invece, nella prassi processuale, avviene puntualmente, come nota criticamente Dawan, op. cit., p. 29-30, poiché «spesso manca una anche minima conoscenza del giudice della basilari conoscenze di psichiatria forense». La stessa Corte di Cassazione sembra essersi arresa all'evidenza (Cassazione, sez I, 4 novembre 1991), affermando che è inesigibile da parte del giudice di merito l'obbligo di indagine volto ad accertare quale sia, in termini percentuali l'incidenza del vizio di mente, accertato in sede peritale: «La valutazione del vizio di mente, sfugge alla conoscenze tecniche del giudice di merito, sicché essa deve ritenersi implicita nella valutazione clinica operata dal perito». Il rischio che il perito diventi giudice è piuttosto elevato.
107. Ponti e Merzagora, op. cit., p. 70.
108. Considerate nella dottrina più risalenti su un piano inferiore rispetto alle malattie vere e proprie e definite semplici abnormità psichiche.
109. Cfr. Manna, op. cit., p. 5 e Dawan, op. cit., p. 98 nota 5.
110. Il riferimento è all'indimenticabile Marco Cavallo, la scultura di legno e cartapesta, raffigurante un cavallo azzurro, realizzata nel gennaio 1973 durante un laboratorio artistico dallo scultore Vittorio Basaglia e dal regista Giuliano Scabia insieme agli internati del manicomio aperto di San Giovanni a Trieste, diretto da Franco Basaglia. Proprio durante quel laboratorio si stravolse definitivamente quello che restava dell'ordine e della disciplina manicomiale, già minata dall'inedita decisione di tenere aperti i cancelli d'ingresso della struttura. L'idea fu di Angelina Vitez, internata italoamericana a Trieste nel reparto Osservazione donne, che trascorreva le giornata a disegnare un cavallo “riempito” sistematicamente di sei oggetti: un vaso di fiori, una pentola, una casa, un albero e un Pinocchio. La “passeggiata” di Marco Cavallo per le vie di Trieste, sospinto dagli internati, segnarono, anche simbolicamente, un punto di non ritorno verso il superamento dell'istituzione manicomiale. Sulla vicenda cfr. Elisa Frisaldi, Marco Cavallo. Dall'ospedale psichiatrico la vera storia che ha cambiato il modo di essere del teatro e della cultura, Alphabeta Verlag, Merano (Bz), 2011.
111. Cfr. Erving Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismo dell'esclusione e della violenza, Einaudi, Torino, 2003 (ed. originale 1961).
112. Incipit della prefazione di Alessandro Dal Lago in Goffman, op. cit., p. 9.
113. È proprio da Goffman e dalle sue analisi cosi' poco schematizzabili, che nasce e si sviluppa negli anni Sessanta e Settanta quella controcultura, capace a sua volta farsi “imprenditrice morale”, lasciando, sotto le spoglie della c.d. Antipsichiatria, un segno indelebile nella storia giuridica e cultura del Novecento, culminato, almeno Italia, con l'approvazione della l.180/1978 (la c.d. Legge Basaglia).
114. L'espressione è di Martin Luther King nel celebre discorso I have a dream, pronunciato a Washington il 28 agosto 1963.
115. Goffman, op. cit., p. 33-34.
116. Ibidem, p. 35 e ss.
117. Goffmann, op. cit., p. 43.
118. Vedi, infra, cap. III.
119. Goffman, op. cit., p. 71.
120. Richard McCleery, The strange journey, University of North Carolina Extension Bulletin, XXXII, 1953, pag 24.
121. Goffman, op. cit., p. 88.
122. Franco e Franca Basaglia, postfazione all'opera di Goffman, op. cit., p. 218.
123. Ibidem., p. 220.
124. Basaglia, op. cit., p. 221.
125. Tutte le notizie relative alla cronistoria dell'O.P.G. sono tratte da quattro testi fondamentali, a cui si rimanda, per ulteriori approfondimenti: Giulia Simonetti, Ospedale psichiatrico giudiziario: aspetti normativi e sociologici, tesi di laurea, Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze, 2003; Romano Canosa, Storia dei manicomi in Italia, dall'Unità ad oggi, Feltrinelli, Milano, 1979; Giovanna Pugliese e Giovanna Giorgini (a cura di), Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari, Datanews, Roma, 1997 e Dario Stefano Dell'Aquila, Se non ti importa il colore degli occhi. Inchiesta sui manicomi giudiziari, Filema, Napoli, 2009.
126. Davide Ferrario, Sangue mio, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 11.
127. Cfr. Giuseppe Pantozzi, Storia delle idee e delle leggi psichiatriche, Centro studi Erickson, Milano, 1994.
128. Attualmente, a sottolinearne le capacità umane e scientifiche, l'O.P.G. Di Aversa è intitolato “Filippo Saporito”.
129. Filippo Saporito, Su gl'incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale, Aversa, 1908, p. 362.
130. Vedi supra cap. I, par. 1.3.
131. Cfr. Pelissero, op. cit., p. 80 e ss.
132. In questo passaggio sono contenute tutte le atroci ingenuità della Scuola positiva, che credeva nell'esistenza di un delinquente nato, da individuarsi con tecniche bio-antropometriche.
133. Cesare Lombroso, Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia, in Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di scienze, Lettere e art.i, 1872, vol. 5, p. 72 ss.
134. Cesare Lombroso, L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria, Roma, 1897.
135. Dal nome dell'allora Guardasigilli del Regno Giuseppe Zanardelli.
136. Alberto Manacorda, Folli e reclusi, La Casa Usher, Perugia, 1988, p. 131.
137. Michel Foucault, Il manicomio illimitato, in Follia e Psichiatria, a cura di M. Bertani e A. Rovatti, Giuffrè, Milano, 1994, p. 150.
138. Cfr. Pelissero, op. cit., pg.86 e ss.
139. Relazione ministeriale al codice penale, in Luigi Bozzo, il codice penale e la sua genesi con note di giurisprudenza ed altre utili per la sua pratica, Roma, 1890.
140. Il testo completo della relazione è consultabile in Andrea Scartabellati, L'umanità inutile. La questione follia in Italia, Franco Angeli Editore, Milano, 2001, pag 135 e ss. Da qui arrivano tutte le citazioni e i riferimenti diretti della relazione, che seguono.
141. Gli stessi autori notano come in altri Paesi e nello specifico, in Inghilterra istituti dedicati esclusivamente ad accogliere i prosciolti folli siano ormai solide realtà. Nel testo originale si fa specifico riferimento all'esperienza di Broadmoor.
142. Riportata da Ugo Fornari, Irresistibile impulso e responsabilità penale: aspetti normativi, in Rivista Sperimentale di Freniatria, vol. CXII, n. 1, 1988, pp. 43-85.
143. Filippo Saporito, op. cit., p. 363.
144. Enrico Tanzi, Psichiatria forense, Vallardi, Milano, 1911, p. 129.
145. Cfr. S. Merlini, Libertà personale e tutela della salute mentale: profili costituzionali, in Democrazia e Diritto., 1970, p. 55.
146. Cfr. G. Rabagliatti, Manicomi, in Novissimo Digesto, vol. X, UTET, Torino, 1957, p. 177.
147. Cfr. Romano Canosa, op. cit., p. 177.
148. Per dettagli, cfr. Anna Maria Vecchietti, Salute mentale e riforma sanitaria, Giuffrè, Milano, 1983, p. 4 e ss.
149. Vecchietti, op. cit., p. 11.
150. Cfr. Saporito, op. cit., p. 363.
151. Sarà questo, come vedremo infra par. 1.6.16, uno dei nodi del DPCM 1 Aprile 2008.
152. L'entrata in vigore del codice Rocco viene ora affrontata dal punto di vista degli effetti che ha sul manicomio giudiziario come istituzione totale.
153. Pelissero, op. cit., p. 91.
154. Giusto Giusti (a cura di), Trattato di medicina legale e scienze affini, V edizione, Cedam, Padova, 1999, p. 675.
155. Antonio De Mersico, Delle misure amministrative di sicurezza, ne Il codice penale illustrato articolo per articolo, a cura di Ugo Conti, Milano, 1934, p. 834.
156. Il Florian, durante i lavori preparatori del codice, sollevò forti dubbi riguardo l'introduzione di limiti di durata, notando criticamente: «L'indole della misura di sicurezza, la quale squisitamente adatta alla persona, non può che ragguagliarsi alla pericolosità della stessa, pericolosità contingente e variabile».
157. Pelissero, op. cit., p. 94.
158. Sono i due articoli che più influenzano il dibattito (e le decisioni della Corte Costituzionale in tema di folli-rei). L'art. 27 statuisce: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». L'art. 32 riguarda il diritto alla salute e dispone: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
159. Anna Maria Vecchietti, op. cit., p. 28.
160. Cfr. Giulia Simonetti, op. cit., p. 14.
161. Il concetto di moral entrepeneur viene introdotto nel dibattito sociologico dal'interazionista simbolico Howard Becker, nella già citata opera Outsiders. Studies in the sociology of deviance (Cap. VII, p. 148-175). Secondo il pensiero beckerriano esistono due tipologie di imprenditori morali: i rule creators (creatori di norme) e i rule enforcer (difensori della norma). La figura dell'imprenditore morale è fondamentale nella visione beckreriana, poiché le norme non sarebbero nient'altro che il frutto di un conflitto (il c.d. conflitto sociale, su cui si basa, tra l'altro, le teoria dell'etnometodologia). Sarà la persuasività e la forza dell'imprenditore morale a bilanciare il conflitto, a “convincere” la società e, conseguentemente il legislatore, a propendere per una particolare soluzione normativa da preferire alle altre.
I rule creators sono dei “crusading reformer”, cioè dei riformatori battaglieri, che cercano di “pubblicizzare” (nel senso di rendere collettivi) i propri bisogni e le proprie convinzioni morali, il loro intento è far sentire come necessità improcrastinabile una certa riforma. Ovviamente, per essere convincenti, hanno bisogno di proporre concretamente soluzioni sostenibili e accettabili dal più ampio numero di persone possibili. Per questo motivo necessitano dell'appoggio di c.d. professionisti, cioè tecnici della materia, che sappiano trasformare le loro crociate morali in soluzioni tecnicamente valide (è Becker stesso ad usare l'ambiguo termine di crusade - crociata - a cui, secondo gli interpreti, dovrebbe essere data una connotazione neutra e non per forza negativa, come si potrebbe invece supporre da una prima traduzione superficiale). Se nella prima fase di creazione della norma e cioè quella di proposta e discussione, i rule creators hanno un ruolo preminente, nella seconda fase, cioè quella di applicazione ed esecuzione, entrano in gioco i rule enforcer. Nella visone originale dell'autore, quella di enforcer è solitamente una professione remunerata (ad es. gli agenti di polizia), essi non sono necessariamente moralmente persuasi dal contenuto della norma, anzi, paradossalmente, possono pensarla diversamente, ma ciò poco importa, poiché agiscono su un piano differente, che è quello della difesa della norma. C'è una duplice necessità che conduce e ispira l'azione degli enforcer: giustificare il proprio ruolo e, soprattutto, conquistare il rispetto nelle interazioni con gli altri consociati. Per questo motivo sono in una posizione particolarmente delicata: se agiscono troppo alacremente, cosicché nessun consociato ha interesse a mettere in dubbio l'effettività della norma, il loro ruolo si svuota di senso e la società penserà di non averne bisogno, se, invece, saranno troppo permissivi, verrà loro rimproverato l'incapacità e il fallimento della propria missione.
162. La scelta di ricostruirne brevemente la storia di Antonia Bernardini aiuta a capire, da un punto di vista sociologico, il ruolo dirompente degli imprenditori morali, anche se, inconsapevoli, da un punto di vista giuridico, la necessità improcrastinabile di una riforma della legislazione della malattia mentale. Non secondaria è la scelta di raccontare perché diventi memoria collettiva, perché urge meditare «che questo è stato». (Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1976, p. 1). Per una ricostruzione completa della vicenda di Antonia Bernardini, cfr. Dario Stefano dell'Aquila, op. cit., p. 53 e ss.
163. Il termine tecnico psichiatrico con cui viene definito l'apice della malattia psichiatria, comunemente conosciute come “crisi”.
164. Esistono quattro tipologie di contenzione: fisica, ambientale, chimica (o farmacologica), psicologica (o relazionale). I mezzi per attuare la contenzione sono: fasce o cinture da applicare al letto, spondine di protezione del letto, il corpetto da carrozzina (il paziente non può così alzarsi dalla carrozzina a rotelle), mezzi di contenzione per segmenti corporei (cavigliere, polsiere, testiere), mezzi di contenzione con postura obbligta (cuscini anatomici), altri mezzi (cintura pelvica, divaricatore inguinale, tavolino inamovibile, carrozzina basculante, poltrone basse).
165. Cfr. Atti parlamentari VI legislatura, Seduta 29 ottobre 1975, Intervento Sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia, Camera dei Deputati, Roma, p. 24310.
166. Giustiniano, Institutiones, libro II, 7, 3.
167. Per una disamina più approfondita, soprattutto sotto il profilo statistico, dell'applicazione delle misure alternative a oltre trent'anni dalla riforma in esame, cfr. la ricerca a cura di Giovanni Torrente Tribunali di Sorveglianza e giurisprudenza in materia di concessione di misure alternative.
168. Francesco Bricola, il carcere riformato, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 265.
169. Antonio Margara, Il magistrato di sorveglianza quale garante di conformità alla legge dell'attività penitenziaria, in V. Grevi, Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, in C.N.P.D.S., Pene e misure alternative nell'attuale momento storico, p. 215.
170. Ibidem, p. 216.
171. Il voto contrario più politicamente e numericamente pesante è quello del gruppo dei Radicali Italiani.
172. Cfr. Maria Antonietta Farina Coscioni, Matti in libertà. L'inganno della legge Basaglia, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2011, p. 55.
173. Nonostante il testo della legge 180/1978 non accolga del tutto le tesi dell'antipsichiatria, passerà comunque alla storia come «legge Basaglia».
174. Intervista a Franco Basaglia di Franco Giliberto, testo completo su Archivio storico de La Stampa, edizione venerdì 12 maggio 1978, p. 11.
175. Franca Ongaro Basaglia (a cura di) Scritti. II, 1968-1980. Dall'apertura del manicomio alla nuova legge sull'assistenza psichiatrica, Einaudi, Torino 1982.
176. Cfr. sentenzaTribunale di Roma, 2 aprile 1979, in Foro Italiano, 1980, II, c. 156.
177. Pelissero, op. cit., nota 62 pag. 98.
178. Vittorino Andreoli, Anatomia degli Ospedali psichiatrici giudiziari italiani, Dipartimento Amministrazione Penitenziari-Ufficio studi e ricerche, Roma, 2002, p. 18.
179. Pelissero, op. cit., p. 97.
180. Luigi Daga, O.P.G.: sistema penale e sistema sanitario, Rassegna Penitenziaria, 1982.
181. Giulia Simonetti, op. cit. Della medesima opinione sono anche Adelmo Manna, Il trattamento sanzionatorio del malato di mente autore di reato e le prospettive di riforma, in Rass. Criminol., 1994, p. 269 e Giovanni Russo, Il manicomio giudiziario come luogo di trattamento per detenuti difficili, in Riv. It. Med. Leg., 1982, p. 928.
182. Vittorino Andreoli, op. cit., p. 32.
183. Luigi Daga, op. cit., p. 26.
184. Ibidem, p. 13.
185. L'associazione è formata da parenti, amici, psichiatri, psicologi, giuristi che si relazionano con psicotici gravi. Tra le principali attività vi è l'aggiornamento quotidiano del sito Vittime della 180, in cui si raccolgono testimonianze, storie, dati, pareri su quelli che, nell'opinione dei creatori, sarebbero i “disastri” della legge Basaglia. La scientificità e l'obiettività di tali pareri è spesso dubbia o inesistente, tuttavia, da un punto di vista sociologico, è interessante conoscere e studiare il ruolo degli imprenditori morali del campo giuridico folli-rei.
186. SPDC è l'acronimo di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, più comunemente conosciuto come “repartino”, il reparto di psichiatria degli ospedali civili in cui si effettuano ricoveri volontari e obbligatori dei pazienti psichiatri.
187. Pelissero, op. cit., p. 98.
188. Gustavo Zagrebelsky, Appunti e limiti dell'interpretazione giudiziaria della Costituzione, in Lezioni di Giustizia Costituzionale anno accademico 2008/2009, Università di Torino, testo non editato, p. 68.
189. Corte Cost 8-27 luglio 1982, n.139, in Rivista Italiana Diritto Processuale Penale, 1982, p. 1584, con nota di Ettore Musco.
190. Ettore Musco, op. cit., p. 1585.
191. Giuliano Vassalli, L'abolizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna dell'ago, in Giurisprudenza Costituzionale, 1982, p. 218.
192. Pelissero, op. cit., p. 105.
193. Il vizio di costituzionalità è rilevato per contrasto con i principi costituzionali ex art 2, 3,27 e 32.
194. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n.324/1998, in Cassazione Penale, 1998, p. 3214.
195. Cfr. Cassazione, Sez. I, 19 maggio 1999, in Cassazione Penale, 2001, p. 1485 e ss.
196. Cfr. Maria Teresa Collica, op. cit., p. 218.
197. Tratto da Francesco Revelli, Il manicomio dei ragazzi cattivi: un reparto nell'ospedale criminale, La Repubblica, 14 febbraio 2005. Per una rassegna completa sulla vicenda cfr. Forum salute mentale sezione OPG/carcere.
198. La dottrina ha espresso diversi pareri su tale sentenza, tra i più significativi, si segnalano: Maria Teresa Collica, op. cit., p. 218 e ss; Famiglietti, Verso il superamento della pena manicomiale, in Giurisprudenza Costituzionale, 2003, p. 2118 e ss; Mario Minniti, La Consulta apre la strada a misure più flessibili rispetto all'OPG, in Diritto e Giustizia, 2003, p. 46 e ss; (dal punto di vista psicopatologico forense) Merzagora Betsos-Martelli, I cascami del positivismo: ancora su OPG e pericolosità sociale, In rivista Italiana Medicina Legale, 2003, p. 1149 e ss.
199. Cfr. Ordinanza di rimessione iscritta al n. 514 del registro delle ordinanze 2002, in Gazzetta Ufficiale n. 47/2002, prima serie speciale.
200. Consulta Online, Sent. 253/2003 Corte Cost., p. 6.
201. Maria Teresa Collica, op. cit., p. 221.
202. Merzagora Betsos-Martelli, op. cit., p. 1150.
203. Il profilo soggettivo del reato non poteva essere in nessun modo valutato, vistà la non imputabilità dell'infermo di mente.
204. Carrieri e Catanesi, La perizia psichiatrica sull'autore di reato: evoluzione storica e problemi attuali, in Rivista Italiana di medicina legale, 2001, p. 15.
205. Conclusioni sent. 253/2003 Corte Cost.
206. Maria Teresa Colica, op. cit., p. 223.
207. Simone Cristicchi, Dall'altra parte del cancello..., traccia 11, minuto 1:22.
208. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa è un'istituzione indipendente, che promuove la sensibilizzazione e il rispetto dei diritti umani. Non ha poteri giurisdizionali (poiché l'organo propriamente giurisdizionale all'interno nel Consiglio d'Europa è la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo), ma può trarre conclusioni e intraprendere ulteriori iniziative sulla base di informazioni attendibili nell'ambito delle violazioni dei diritti umani subite dai singoli individui. Effettua missioni ufficiali per ottenere una valutazione comprensiva della situazione dei diritti umani. I dati raccolti durante tali missioni vengono catalogati e diffusi nei rapporti annuali del Commissario, nonché messi a disposizioni degli altri organi del Consiglio d'Europa.
209. Il decreto citato era parte integrante della più complessa e articolata Riforma del Servizio sanitario Nazionale, la c.d. Riforma Bindi, sancita ex dlgs. 229/1999: si poneva in essere un massiccio trasferimento di competenze dallo Stato alle ASL locali (e, conseguentemente, alle Regioni) riguardo i servizi e le strutture sanitarie.
210. L'art. 1 commi 1, 2 e 3 statuisce infatti: «I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi; b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate; f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari. Ogni Azienda unita' sanitaria locale, nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unita' sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini».
211. L'art. 1, delimitando l'ambito di competenza del decreto, spiega: «Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria». L'art. 2 prevede inoltre che anche l'onere del pagamento delle rette delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, alcoldipendenti e minori passi dal D.A.P. Al Servizio Sanitario Nazionale.
212. Essendo la materia trattata dall'Allegato C profondamente tecnica e analitica, scarsa è la dottrina, soprattutto giuridica, sul punto. Pertanto si farà principalmente riferimento alle informazione raccolte direttamente dall'Autore nel corso del convegno: L'O.P.G. e i suoi pazienti: dal carcere alla comunità, organizzato a Reggio Emilia (Centro internazionale Loris Malaguzzi) il 28 settembre 2010 nell'ambito della “V settimana della salute mentale” dalla Regione Emilia Romagna e dall'ASL di Reggio Emilia.
213. Stralcio della Premessa all'allegato C, D.P.C.M. 1 aprile 2008.
214. La Lombardia subentra nella gestione dell'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere, L'Emilia Romagna per quello di Reggio Emilia, la Toscana per Montelupo Fiorentino, la Campania per Aversa e Napoli, la Sicilia per Barcellona Pozzo di Gotto.
215. Cfr. D.C.P.M 1 aprile 2008, “Le azioni”.
216. Cittadini internati 2007/2011 statistiche, in StopOPG.
217. Antonino Calogero, Superamento degli O.P.G.-attuazione del DPCM 1 aprile 2008, Psichiatria, Psicologia e Diritto, Anno I, numero I, Aprile 2009.
218. Cfr. D.P.C.M. 1 aprile 2008, “Le azioni”.
219. Antonino Calogero, op. cit., p. 43.
220. Cfr. Relazione Mariella Martini, L'opg di Reggio Emilia dopo il passaggio delle competenze sanitarie all'Asl, Convegno L'Opg e i suoi pazienti: dal carcere alla comunità, Reggio Emilia, 2010.
221. Intervista rilasciata all'Autore il 6 giugno 2011.
222. Costituiscono eccezione rilevante l'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, che, a causa del già richiamato, non recepimento del decreto da parte della Regione Sicilia, non ha subito nessuna variazione e l'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere, che storicamente è struttura interamente sanitarizzata regolata da una convenzione tra lo Stato e l'Asl di Mantova e continua a mantenere un'unica direzione sanitaria.
223. Vedi infra par. 3.1.4.
224. Cfr. Antonino Calogero, op. cit., p. 44.
225. Il testo completo dell'audizione è consultabile online.
226. L'art. 82 dispone: «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria».
227. Cfr. Audizione 16 giugno 2010.
228. Le immagini e i documenti audiovisivi dall'interno dell'O.P.G. sono davvero rari. Si segnalano in particolari due sporadiche eccezioni: il videodocumentario Socialmente pericolosi di Fabio Lazzaretti, Karousefilm, 2001 (interamente girate nell'O.P.G di Aversa) e il servizio Pazzi Criminali, andato in onda il 21 ottobre 2007 su Tg2Dossier.
229. Vedi supra nota 156.
230. Dato ufficiale DAP al 31 maggio 2011.
231. Vale a dire: internati che hanno concluso la misura di sicurezza e la cui pericolosità sociale è scemata grandemente o assente, i detenuti con disturbi psichici occorsi durante la detenzione nelle carceri “ordinarie” o in O.P.G. per un periodo di osservazione psichiatrica.
232. Dati ufficiali diffusi dalla Commissione d'inchiesta durante l'incontro pubblico di presentazione dei lavori, svoltosi a Roma, Palazzo Madama, il 9 giugno 2011.
233. Dati ufficiali diffusi dalla Commissione d'inchiesta durante l'incontro pubblico di presentazione dei lavori, svoltosi a Roma, Palazzo Madama, il 9 giugno 2011.
234. Dati ufficiali diffusi dalla Commissione d'inchiesta durante l'incontro pubblico di presentazione dei lavori, svoltosi a Roma, Palazzo Madama, il 9 giugno 2011.
235. Il progetto Luce e Libertà prevede la realizzazione di pannelli fotovoltaici per il reinserimento sociale degli internati di Barcellona. Ideato dal Dipartimento Salute Mentale dell'Asl di Messsina, è dedicato agli internati dell'Opg di Barcellona Pozzo di Gotto che sono prossimi alla scadenza della misura di sicurezza o con misura di sicurezza scaduta ed in proroga. L'obiettivo è quello di favorire la reintegrazione socio-lavorativa nei territori di origine di almeno 56 internati attraverso un programma sperimentale che prevede una metodologia scientifica per il superamento dell'Opg. La durata del progetto, economicamente sostenuto dalla Cassa delle Ammende è di 4 anni, ma attraverso l'utilizzo produttivo dei capitali di capacitazione, permette di auto-finanziare il modello di welfare generato per almeno 20 anni. Tutti gli internati impiegati in tale progetto sono ospitati in una speciale sezione dell'istituto “a vigilanza attenuata”, ecco perché, statisticamente, sono considerati in tutto e per tutto, “internati”.
236. Entrambi i provvedimenti sono pubblicati sul sito del Senato.
237. Rilevante il Titolo IV del Regolamento di Commissione, rubricato “Modalità procedurali e strumenti operativi dell'inchiesta”, con particolare riferimento all'art. 15 che statuisce: «La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente».
238. Questo è stato il grido di stupore e rassegnazione di Nunziante Rosania, direttore dell'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, in apertura del Convegno di Reggio Emilia, 27 settembre 2010, cfr. supra nota 205.
239. Luigi Missiroli, psichiatra, già direttore DSM Forlì, intervista rilasciata all'Autore, 22 luglio 2011.
240. Silvia Morrone, psicoterapeuta, direttrice clinica comunità “Il Montello”, intervista rilasciata all'Autore, 11 luglio 2011.
241. Cfr. supra Ugo Zamburru, intervista con l'Autore.
242. Luigi Missiroli, intervista con l'Autore.