Capitolo II
Analisi criminologica dello scandalo dei petroli
1. Premessa
Tenteremo ora di analizzare i fatti dello scandalo dei petroli alla luce di alcune teorie criminologiche.
Riteniamo che in criminologia, come in ogni scienza umana, sia necessario fare delle scelte, non potendo restare in una innocente neutralità di fronte ai diversi (e a volte antitetici) approcci che il pensiero umano offre di fronte a problemi concreti. Tra le dottrine criminologiche del XX secolo, quella che più ha attirato la mia attenzione è quella che si è chiamata "teoria della"motivazione e opportunità" di James William Coleman (1). Organizzerò il discorso sulla falsariga della trattazione di Coleman, cercando di applicare in chiave critica quanto detto dall'Autore, valutando altresì gli spunti che dal pensiero di altri ci provengono. Ricordiamo che la teoria di Coleman presenta in grande vantaggio di essere una rielaborazione moderna dei vari approcci sia psicologico-individuali, sia strutturali della tradizione criminologica americana della seconda metà del XX secolo.
2. Petrolieri come colletti bianchi
Il primo problema da affrontare è di carattere definitorio. È necessario comprendere se gli individui coinvolti nella vicenda possano essere considerati criminali dal colletto bianco.
Esistono altre nozioni, alternative a quella di colletto bianco proposta da Sutherland. Green (2), parla di crimine occupazionale definendolo come "ogni atto punibile per legge che viene compiuto grazie alle opportunità create nel corso di un'occupazione legale", sottolineando l'importanza della legalità dell'occupazione entro i cui confini viene compiuto il crimine. Green individua quattro tipi di crimini occupazionali:
- crimine occupazionale organizzativo (da cui traggono benefici organismi economici o datori di lavoro);
- crimine occupazionale dell'autorità dello Stato (commesso nell'esercizio dell'autorità statale);
- crimine occupazionale professionale (commesso da professionisti nella loro attività di professionisti);
- crimine occupazionale individuale (commesso da individui quali semplici occupati).
La nozione di Green è in accordo con quella di Sutherland, in quanto tende ad escludere i comportamenti di coloro che "accumulano ricchezza attraverso l'illegalità, in quanto la loro ricchezza non designa rispettabilità ed elevato status sociale" (3).
Una diversa nozione, alternativa rispetto a quella di crimine del colletto bianco, è quella di crimine imprenditoriale o economico, che consiste in comportamenti illeciti che, adottati internamente a una organizzazione legittima e in congruità con gli obbiettivi di questa, danneggiano i dipendenti, i clienti e il pubblico in generale. (4) Connessa a questa formulazione, è la distinzione tra crimini per le imprese e crimini contro le imprese. I crimini per le imprese vengono comunemente assimilati al crimine imprenditoriale o economico (5). Questa distinzione però presenta la debolezza di voler considerare in maniera troppo omogenea i crimini contro le imprese.
Vanno inoltre considerate separatamente, secondo Box (6), le imprese, definite di carattere criminale, che vengono deliberatamente costituite "con l'esplicito e solo proposito di condurre attività criminali" (7). I reati commessi da queste imprese non vanno confusi con il crimine economico propriamente detto.
Come si vede, anche intorno alla semantica con cui si vuole indicare una vasta ma omogenea gamma di crimini, molto si è discusso e svariate soluzioni alternative, di cui abbiamo fatto solo pochi esempi, si sono avvicendate. Per evitare di perdersi in sterili problemi definitori, si è scelto di adottare la definizione coniata da Sutherland.
I protagonisti dello scandalo dei petroli sembrano calzare perfettamente i panni del colletto bianco. Si tratta, in tutti i casi, di "persone rispettabili e di alto grado sociale" e i loro crimini vengono commessi nel corso della loro professione.
Problemi non insorgono neanche relativamente all'identificabilità dei fatti considerati, come "crimini", secondo l'ampia accezione indicata da Sutherland. In questo caso, non si tratta di comportamenti non assoggettati alla giustizia penale, ma ad altre forme più 'blande' di repressione (giudizio civile, amministrativo o soluzioni extragiudiziarie). Si tratta di comportamenti sanzionati in seguito a regolari giudizi penali, con sanzioni efficaci, nel rispetto della legalità.
Nessun dubbio di carattere definitorio si pone nei confronti dei 'protagonisti' dello scandalo, né nei confronti di quei soggetti solo secondari della vicenda a cui abbiamo fatto più volte riferimento, spesso tralasciando, per motivi di sintesi, di precisarne i nominativi. Si tratta di colletti bianchi che hanno commesso crimini omogenei. Anche se le fattispecie di reato possono sensibilmente variare a seconda dei casi, l'elemento di omogeneità sta proprio nell'occasione che ne ha determinato la commissione, l'esercizio di un'attività economica a cui tutti i protagonisti hanno dato contributi personali e dalla quale tutti hanno tratto vantaggi economici e di altro genere.
3. Le motivazioni
Seguendo il pensiero di Coleman, è necessario individuare sia le motivazioni, attinenti alla sfera soggettiva, sia le opportunità, legate alla sfera oggettiva, che hanno determinato la criminogenesi.
Consideriamo, innanzitutto, le motivazioni.
Prendiamo come riferimento Carlo Boatti. Ripercorriamo in maniera sintetica le caratteristiche salienti di questo personaggio. Egli ha, fin da tempi anteriori alla sua partecipazione allo scandalo, una buona posizione all'interno della struttura sociale. È console in Italia del Gabon e possiede diverse imprese che fanno a lui capo, godendo di un elevato tenore di vita. È anch'egli, come Bruno Musselli, "cavaliere del lavoro", riconoscimento che sintetizza quella che è la sua capacità imprenditoriale e la sua attitudine verso gli impegni professionali.
Boatti inizia la sua attività in maniera apparentemente lecita, commercia fin dai primi anni Settanta nel settore dei prodotti petroliferi, divenendo fornitore, in certe occasioni, di imprese che già da tempo praticano il contrabbando. Nel 1975 la situazione muta radicalmente. Egli entra in contatto con Musselli e con altri protagonisti della vicenda, si lascia da essi guidare nell'organizzazione della struttura del contrabbando e inizia effettivamente un'attività illecita.
Il suo approccio all'attività criminale sembra essere una scelta forzata, una sorta di 'ultima spiaggia' di fronte alle difficoltà economiche che le sue aziende stanno incontrando nel settore. In un passo delle sue difese nel processo (8), egli precisa che a determinare l'inizio del contrabbando sono state la necessità di salvare il suo gruppo dalle difficoltà economiche e dalla forte concorrenza di tutte le altre aziende del Nord Italia, che avevano risolto la momentanea crisi e la contrazione della domanda di prodotti petroliferi che ad essa era seguita, scegliendo l'evasione delle imposte. Egli è contrabbandiere "conformista", nel senso che tende solo a conformarsi a quello che è la situazione operativa del settore economico in cui agisce. In questo senso, egli ci appare conformista rispetto ai valori propri del sottogruppo in cui si trova a operare e, attraverso l'associazione differenziale, egli assorbe questi stessi valori. Ma non solo.
Boatti è persona colta, rispettata, socialmente egli svolge ruoli prestigiosi. Proprio per questo è impensabile che egli sia, in qualche modo, da considerare isolato dai valori etici della comunità cui appartiene. Secondo l'etica, prima ancora che secondo la legge, la violazione delle norme, la commissione di illeciti, sono comportamenti inaccettabili. La società non si risparmia dallo stigmatizzare condotte di tal genere. Lo si vede da ciò che accade nel momento in cui scoppia lo scandalo dei petroli. La sola idea che potesse essere avvenuta una truffa di quelle dimensioni determina una forte reazione da parte dell'opinione pubblica, con riflessi anche sullo stesso mondo politico. I sospettati di essere stati gli artefici dello scandalo non reagiscono minimizzando l'accaduto o disinteressandosi di ciò che stava avvenendo, ma apprestano da subito le proprie difese, eliminano, per quanto loro concesso, le prove dei fatti, alcuni fuggono all'estero. Tutto ciò ci conduce a pensare che il peso dello stigma non debba essere assolutamente sottovalutato, come chiave di lettura di certi comportamenti tenuti. Così, Boatti, di fronte alla scelta tra il permanere in una condotta legittima, andando incontro alla probabile (dal suo punto di vista) rovina economica, o scegliere il crimine, risollevando le sorti del suo gruppo, non può non avere provato un forte conflitto interiore, tra i propri valori etici e le aspettative illecite che gli si paravano innanzi.
Per risolvere quello che Matza avrebbe definito 'drift', egli adotta delle razionalizzazioni, sotto forma di tecniche di neutralizzazione.
Egli dice, in un suo interrogatorio, "Io ne ero a conoscenza (riferendosi al contrabbando, n.d.r.) e le motivazioni di queste operazioni illecite si debbono ricercare nelle necessità economiche nel settore petrolifero notoriamente in crisi nell'ambito della raffinazione da anni". A mio parere non si tratta di una semplice giustificazione ex post facto, presentata ai giudici nel tentativo di difendersi, ma di una vera e propria razionalizzazione, riportata a fatto concluso, ma che trova la sua origine nel momento in cui il soggetto ha compiuto le scelte che lo hanno portato alla commissione del crimine. Questa particolare razionalizzazione può essere ricondotta a quella che Matza aveva definito "il richiamo a lealtà superiori", o, secondo Clinard, "l'esigenza di sopravvivere o di raggiungere fini economici vitali". La salvezza dell'impresa nel momento di difficoltà economica, si ricollega a un imperativo proprio del sottogruppo sociale a cui Boatti appartiene, dove la competizione economica detta le regole che devono essere rispettate, dove, tra i valori fondamentali ritroviamo, da un lato il desiderio di un rapido arricchimento ("making a fast buck", secondo l'espressione usata da Robert Lane (9)), dall'altro, la paura di cadere ("fear of falling" (10)) ossia il timore di perdere il risultato della propria attività. Questo secondo fattore, che opera a livello soggettivo come componente motivazionale, è quello che più direttamente riguarda il caso di Carlo Boatti, ma che può essere esteso a tutti i protagonisti della vicenda nel momento in cui all'esigenza di "arricchirsi in fretta", si sostituì quella di "conservare le proprie ricchezze".
Tutto ciò è espressione della "cultura della competizione", come viene definita da Coleman. Non si tratta, tuttavia, di norme, valori e imperativi, estranei alla cultura del gruppo dominante. Non è, per questo, espressione di una sottocultura, né tanto meno di una sottocultura delinquenziale. La nostra società, intesa come gruppo dominante, possiede, tra i suoi valori principali, proprio la competizione economica vista come valore positivo, come produttrice di benessere per la società nel suo complesso. Da ciò deriva l'esaltazione di coloro che contribuiscono al benessere sociale con la propria impresa e, diversamente, una stigmatizzazione di coloro che rivestono posizioni inferiori, a causa della propria 'pigrizia' o 'inettitudine'. L'enfasi posta sulla produttività e sul successo, determina un incremento del senso di insicurezza e della paura di fallire nel gioco della competizione. Tutto ciò rende la motivazione della scelta criminale sempre più forte, rispetto all'inibizione derivante dall'etica e dal desiderio di rimanere rispettosi della legge.
È possibile spiegare la dinamica della motivazione, che porta a compiere reati da parte di individui che godono di un certo potere economico e sociale, secondo un'ottica economicistica, alternativa rispetto all'interazionismo simbolico di Coleman, ma che, a mio parere, riesce a dimostrare la scelta deviante in maniere molto efficace. In ciò, faremo riferimento alla rilettura della "legge della diminuzione dell'utilità marginale" propria della microeconomia, in chiave criminologica, così come ha fatto Stanton Wheeler in una saggio recente di grande interesse. (11).
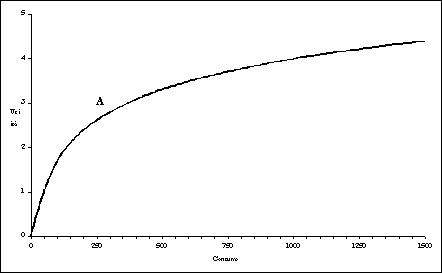
Secondo la legge della diminuzione dell'utilità marginale, espressa nella figura 1, la quantità di utilità (qui nel senso di "felicità, piacere, ricompensa" (12)) che l'individuo trae da ogni singola unità di consumo (qui nel senso di "denaro guadagnato") cresce in maniera discontinua. La curva di utilità marginale, infatti, cresce in modo più ripido fino al punto A, per poi aumentare in modo sempre più attenuato, per ogni ulteriore unità di consumo. Ciò significa che l'incremento di soddisfazione che il soggetto gode per il primo miliardo guadagnato è decisamente superiore rispetto alla soddisfazione per i miliardi successivi.
La domanda che ci si pone a questo punto è la seguente. Perché il soggetto dovrebbe voler "rischiare molto quando ha già molto?" (13). La maggior parte dei soggetti, secondo Wheeler, si comporta proprio secondo la legge espressa in figura 1, evitando il rischio una volta raggiunto un livello soddisfacente di utilità. Accanto a questi individui detti "risk neutral" (14), ne esistono altri, chiamati "risk seeker" (15), che si comportano secondo una diversa legge, espressa nella figura 2.
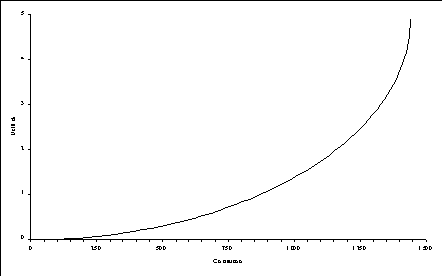
Il "risk seeker" non vede una progressiva diminuzione dell'utilità all'aumentare dei guadagni, ma un suo aumento esponenziale.
Se la prima curva può rappresentare l'ascesa di tutti i protagonisti dello scandalo dei petroli, negli anni del loro boom economico, tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Ottanta, in cui hanno costruito ingenti fortune sfruttando le pratiche illecite ideate da alcuni "petrolieri innovatori" (di cui parleremo), la seconda, rappresenta la situazione degli stessi protagonisti in una fase successiva, in cui l'esigenza di emergere lascia il campo a quella di "evitare di ricadere indietro" (16).
Il "risk seeker", da un punto di vista economico, sembra contraddire la legge della diminuzione dell'utilità marginale. Il che, secondo Wheeler, è soltanto una contraddizione apparente. Vediamo in che senso. Secondo Kahneman e Tversky (17), nelle economie moderne vale il principio secondo cui "le perdite hanno un impatto molto maggiore dei guadagni": "L'aggravamento che un individuo sperimenta nella perdita di una somma di danaro appare essere molto maggiore rispetto al piacere che prova nel guadagnare la stessa somma". Si tenga inoltre presente che alle perdite economiche si sommano, inevitabilmente, le perdite di status sociale e di prestigio, posto che il potere economico, nella maggioranza dei casi, determina lo status e il prestigio di un individuo. Wheeler combina il principio di Kahneman e Tversky con la legge dell'utilità marginale. Da ciò risulta il grafico rappresentato nella figura 3.
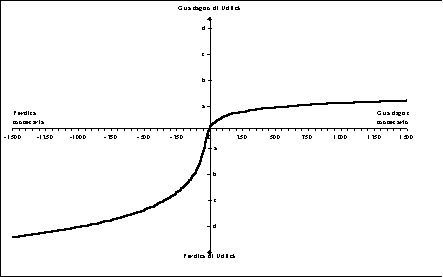
La curva nella figura 3 non è altro che la combinazione tra curva convessa dell'utilità marginale e la curva concava del comportamento del "risk seeker".
Ritorniamo al nostro caso concreto. Immaginiamo che il gruppo Boatti abbia un bilancio in attivo di un miliardo. La situazione, prima della scelta del crimine, è rappresentata in figura 3 nel punto '0', all'intersezione degli assi del diagramma. Una perdita di appena il quindici percento determina un abbassamento dell'utilità soggettiva a metà del suo livello precedente. Immaginiamo che il petroliere debba acquistare una grossa partita di prodotti petroliferi, su cui grava un'imposta pari al quindici percento del patrimonio netto. Se decide di pagare l'imposta, tale somma verrà considerata come una perdita, nel caso in cui decida di evadere l'imposta, essa verrà sommata al patrimonio netto come un guadagno di impresa. Se si considera la scelta dal punto di vista soggettivo, dell'utilità che trae dalla commissione del reato e di ciò che perde dalla sua mancata commissione, si comprende come essa debba cadere, con molta probabilità, sulla commissione del reato.
La teoria di Wheeler è utile per spiegare la continuazione delle condotte criminali da parte di tutti i petrolieri coinvolti nella vicenda nel momento in cui l'attività di contrabbando ha raggiunto il suo apice, in termini di prodotti petroliferi movimentati e di profitti. Per questo riteniamo che, sebbene si sia parlato esclusivamente di Carlo Boatti, lo stesso discorso possa valere nei confronti degli altri soggetti, almeno relativamente al momento in cui si trattò di conservare lo stato di fatto che si era venuto a creare, quando le posizioni e i ruoli all'interno dell'organizzazione contrabbandiera si erano cristallizzati.
Si è visto come Boatti, all'inizio della sua attività criminale, avesse appreso, in particolare, le modalità per individuare e sfruttare le opportunità illecite offerte dal settore petrolifero. L'apprendimento avvenne attraverso "l'intima e costante associazione", per usare la terminologia di Sutherland, con altri petrolieri già dediti al contrabbando. Si è visto, quindi, il ruolo fondamentale giocato, nella scelta deviante, dall'associazione differenziale con i vari Gissi e Musselli. Si deve sottolineare però, come quel know-how appreso da Boatti, fosse stato 'invenzione' di altri, che in tempi più remoti avevano plasmato le modalità di frode alla particolare struttura normativa del settore economico. Qualcuno che conosceva le leggi, che aveva esperienza nel settore, che sapeva, non solo come commettere i reati, ma anche come assicurarsi che quei reati non fossero scoperti.
Per questi soggetti, che chiameremo "contrabbandieri innovatori", non si trattava di raggiungere un fine, sfruttando le opportunità illecite offerte da un sottogruppo, bensì di creare le stesse opportunità illecite, di porre le basi perché altri soggetti aderissero alla sottocultura e apprendessero il know-how necessario, condividendo i valori e i fini propri di quel sottogruppo. Si trattava, in questo senso, di creare un sottogruppo ab origine.
È in questo quadro che si inserisce, tra gli altri, Bruno Musselli, il quale è stato indicato, sia dalla stampa che dalle stesse parole dei giudici, come "promotore e supremo organizzatore di tutto il contrabbando" (18). Musselli è un "innovatore". In questo senso, egli è un "vero imprenditore" secondo la definizione di Ruggiero (19). La sua attività è, fin dall'inizio, caratterizzata dall'incertezza e dal rischio. L'incertezza deriva dalla decisione di voler operare in un settore in cui ha poca esperienza, il rischio è legato alla insicurezza del buon esito economico. Egli, pur accettando il rischio personalmente, mobilita l'iniziativa e la partecipazione di altri, circondandosi di individui con esperienza nel campo delle tecnologie industriali (si pensi a Mario Milani, scelto per le conoscenze acquisite nel settore delle miscelazioni) e della normativa del settore (in questo caso gli "esperti" sono gli ex ufficiali della Guardia di Finanza, Gissi e Galassi). Secondo Knight (20) proprio il rischio e l'incertezza hanno l'effetto di mutare i confini dei valori morali di un individuo, in una costante precarietà etica che riflette quella materiale. Ma ciò non basta, a mio avviso, a spiegare le dimensioni di ciò che è accaduto.
I giornali hanno polarizzato la loro attenzione su Musselli, personaggio di sicuro spessore, che avrebbe fatto notizia e che traeva beneficio da questa situazione, concedendo interviste ai giornali, da cui lanciava accuse contro i giudici, definendosi "vittima" della loro persecuzione (21). Queste accuse avevano la duplice funzione di delegittimare, agli occhi dell'opinione pubblica, l'operato dei giudici e di offrire una razionalizzazione che vale come tecnica di neutralizzazione del conflitto morale. È una razionalizzazione diversa da quella proposta da Boatti ed è riconducibile a quella che Matza individua come "la condanna di coloro che condannano". Un altro personaggio, Vincenzo Gissi, legato a Musselli come si è già ampiamente visto trattando del contrabbando presso le imprese, usa una diversa tecnica di neutralizzazione. Egli dice, intervistato da un giornalista sulla corruzione della Guardia di Finanza, "È chiaro che quando un petroliere conosce un ufficiale della Guardia di Finanza, si sa di che razza di rapporti si tratta. Siamo in Italia: a Roma per accedere a qualsiasi ufficio pubblico bisogna lasciare 10 mila o 20 mila lire sul tavolo dell'usciere". Tecnica di neutralizzazione che si richiama al "tutti gli altri lo fanno" evidenziato da Coleman (22) e prima ancora da Cressey nel suo studio sull'appropriazione indebita nelle grandi imprese (23). Con ciò Gissi sembra voler esprimere l'idea di non avere fatto nulla di male nel conformarsi ad una modalità di comportamento largamente accettata nella società.
Riteniamo che non sia corretto voler rintracciare, ad ogni costo, un solo responsabile, ideatore del contrabbando. Piuttosto, se ne deve riconoscere l'origine nell'associazione di una pluralità di imprenditori innovatori, accomunati da un analogo fine, che può essere rintracciato, almeno relativamente all'inizio della vicenda, nella volontà di arricchirsi.
Aristotele sosteneva che "i più grossi crimini sono causati dall'eccesso e non dalla necessità" (24). Alcune precisazioni vanno fatte su che cosa si intenda per "volontà di arricchirsi". Non è la volontà di ottenere un passaggio di classe da parte di individui di classe inferiore. La criminalità dei petrolieri è messa in atto da persone che obiettivamente hanno già raggiunto elevati livelli di successo economico-sociale. Se per le classi inferiori, secondo la teoria delle opportunità di Merton, la devianza nasceva dal contrasto anomico tra valore universale del successo e 'discriminazioni' strutturali nella distribuzione delle chances socio-economiche, nella devianza dei colletti bianchi, gli autori degli illeciti hanno già conquistato queste chances in modo sostanzialmente (o parzialmente) legittimo.
Secondo Solivetti, alla radice del comportamento illecito sta "non l'inadeguatezza delle chances socio-economiche a disposizione, bensì uno sviluppo abnorme delle aspirazioni, che crea comunque una situazione di tensione e di frustrazione. (...) La pressione verso la criminalità di impresa sembra infatti esercitata non da pulsioni generiche verso un successo economico-sociale altrettanto generico, ma da problematiche di aspirazioni specifiche, strettamente inerenti al campo di attività nel quale il colletto bianco è inserito e alla cultura particolare che egli condivide" (25).
Queste aspirazioni non sono quelle della massa, ma sono il frutto specifico del contesto socio-culturale nel quale il colletto bianco si colloca. L'uso di strumenti illeciti nasce, a questo punto, dal non-equilibrio tra le mete del gruppo di appartenenza e le condizioni obbiettive del contesto socio-economico, ossia le opportunità lecite.
Ad aggravare il divario e a rendere la scelta deviante sempre più difficile da evitare, contribuiscono altre condizioni che influiscono sulle motivazioni soggettive. Tra queste ritroviamo l'enfasi sul raggiungimento degli obbiettivi. Secondo Gross "qualsiasi siano gli obbiettivi, è l'enfasi posta su di essi che crea il problema" (26). Nel nostro caso specifico, la tendenza a non reinvestire nelle imprese tutti gli utili del contrabbando, al fine di acquistare automobili, gioielli, tappeti, appartamenti e altri beni di lusso, percepiti soggettivamente come veri e propri "bisogni", risulta quale modo implicito di enfatizzare quelli che sono i valori predominanti del gruppo, aggravando la situazione di conflitto tra le "iper-aspettative" e le opportunità lecite oggettivamente presenti.
4. Le opportunità
Per quanto fossero forti le motivazioni dei petrolieri, da sole esse non bastarono a giustificare il contrabbando nelle sue dimensioni.
Il desiderio di arricchirsi, di conquistare una determinata posizione socio-economica o il tentativo di conservare lo status e il prestigio raggiunto, non sono sufficienti da soli a giustificare la scelta deviante. Volendo seguire il suggerimento di Ruggiero (27), in quella che lui definisce "causalità degli opposti", le motivazioni appena sintetizzate sono comuni a tutti gli imprenditori e non solo nel settore specifico dei petroli. "Ogni qualvolta si aderisce a una causalità ci si accorge che anche il suo contrario possiede una propria ragionevolezza" (28). In questo senso, basti pensare a coloro che nella ricerca del successo o nel tentativo di resistere alla concorrenza economica sul mercato, hanno optato per scelte conformiste, sfruttando le opportunità lecite loro offerte, evitando di incorrere nello stigma della devianza. Le motivazioni che spingono questi individui, sono le medesime che condizionano la scelta deviante dei contrabbandieri. La differenza sta nella diversa distribuzione delle opportunità lecite e illecite tra i vari individui. In altre parole, tutti gli individui hanno a disposizione una rosa di opportunità lecite e illecite, tra cui scegliere attraverso un giudizio comparativo; tanto più sono numerose le opportunità illecite e tanto maggiore è il "payoff" che da esse si può trarre, rispetto alle opportunità lecite, tanto maggiore sarà la probabilità che l'individuo scelga di commettere il crimine.
Gli elementi determinanti nel rendere più attrattive le opportunità illecite sono, secondo Coleman (29):
- la probabilità di incorrere in una sanzione
- la gravità della possibile sanzione
- l'entità del "payoff" atteso dalla commissione del crimine.
Quando la sanzione è percepita come improbabile o, comunque, di lieve entità (rispetto ai vantaggi che si trae dal crimine) e il beneficio che deriva dal crimine è visto come particolarmente appetibile, la scelta deviante diventa difficile da evitare.
Già Sutherland aveva messo in luce come l'apparente marginalità del numero di crimini del colletto bianco dipendesse dalla applicazione 'differenziale' della legge che veniva a loro accordata. Spesso accadeva che i giudici, chiamati a giudicarli, si esimessero dal farlo perché appartenenti alla loro stessa classe sociale, o che sottraessero i giudizi dalla competenza delle corti penali, per scegliere altre soluzioni giuridiche meno stigmatizzanti, come i tribunali civili, amministrativi o organismi stragiudiziali.
Nel caso specifico dello scandalo dei petroli, non si era trattato di ridurre la probabilità di essere condannati da una Corte penale, né di influenzare il modo in cui la legge veniva loro applicata, in modo da minimizzare le conseguenze legali del crimine. La lettera della legge era in sé chiara, l'attività di produzione e di movimentazione dei prodotti petroliferi era regolata in maniera particolareggiata, la normativa fiscale del settore non dava adito a grossi problemi interpretativi, così come la previsione di specifiche fattispecie di reato, con sanzioni tutt'altro che di lieve entità.
Tutto ciò doveva essere percepito come un ostacolo alla commissione delle frodi. Non risultano tentativi di corruzione andati a buon fine, nei confronti dei giudici. Così Donatella delle Porta e Alberto Vannucci descrivono la magistratura di quel periodo: "nel corso degli anni Settanta e Ottanta, (...) la magistratura ha (...) iniziato a esercitare una funzione di supplenza di un debole potere politico, accrescendo anche lo spirito di corpo. L'abnegazione di molti giudici, che hanno pagato con la vita la loro difesa della legalità, è stata contrapposta, nell'immaginario collettivo, all'inerzia di una classe politica debole e corrotta. Negli stessi anni si è ridotta anche l'acquiescenza rispetto al potere politico. Una nuova generazione di 'giudici ragazzini', privi di deferenza nei confronti della politica, ha iniziato a indagare sugli illeciti amministrativi e sui collegamenti tra mafia e politica" (30).
Il timore di un intervento della magistratura fu percepito come l'ostacolo fondamentale, che divideva gli imprenditori dalle opportunità illecite, legate ai fruttuosi guadagni derivanti dall'evasione dell'imposta di fabbricazione. Ciò è testimoniato con chiarezza dal fatto che la maggior parte delle risorse economiche (attraverso tangenti) e umane (stabilendo rapporti di fiducia con componenti degli Utif, della Guardia di Finanza e con uomini politici) vennero impiegate nel tentativo di neutralizzare l'ostacolo giudiziario. La tecnica che si adottò fu quella di impedire che notizie di reato giungessero all'attenzione dei magistrati, intervenendo con pratiche corruttive nei confronti degli Utif e della Guardia di Finanza, sia a livello periferico, che a livello centrale (assicurandosi la collaborazione di Giudice e Lo Prete, al vertice della Finanza e di Del Gizzo, al vertice delle Dogane). Caso esemplare di come riuscirono ad isolare la magistratura fu la vicenda del rapporto "Vitali", di cui si è parlato in precedenza. In quel caso, le nuove indagini condotte dalla Guardia di Finanza sulla "Costieri Alto Adriatico" ebbero l'effetto di eliminare ogni sospetto di reato, diversamente da quanto indicato dall'appunto del colonnello Vitali, privando i giudici di ogni elemento utile di prova. L'essere riusciti a creare una struttura di protezione per il contrabbando, ha notevolmente potenziato le opportunità illecite.
Un ultimo fattore di non secondaria importanza intervenuto ad accrescere le opportunità illecite, è la predisposizione di un sistema organizzato di imprese, al fine di garantire, da un lato, un decentramento dell'attività di contrabbando, dall'altro, un decentramento delle stesse responsabilità penali, nel caso in cui il contrabbando venisse scoperto. Ci si riferisce alla complessa struttura di "pozzi" e "cartiere", a cui si è fatto più volte riferimento descrivendo i fatti dello scandalo. In questo caso, le opportunità illecite offerte dalla struttura organizzativa dei gruppi di contrabbando incontrava un unico ostacolo, il rifiuto, da parte dei soggetti secondari responsabili dei "pozzi" e delle "cartiere", di prendere parte al crimine.
Al fine di superare questo secondo ostacolo, i protagonisti della vicenda operarono anzitutto una selezione del personale, scegliendo soggetti che più facilmente sembrano conformarsi alle pratiche illecite messe in atto dall'organizzazione. In tal senso, vengono reclutati imprenditori in difficoltà economiche, che in vista di un facile guadagno consentono di svolgere un ruolo di capro espiatorio, fidando sulle scarse probabilità di essere scoperti e sulla lieve entità della pena (si pensi al caso della Meratex di Casati, che svolgeva il ruolo di "cartiera" nei traffici tra la "Comea" e la "Siplar") (31).
Anche all'interno delle stesse imprese di maggiori dimensioni si utilizzano determinate tecniche per assicurarsi la fedeltà da parte dei lavoratori, i quali nella maggioranza dei casi sono a conoscenza del carattere illegale degli ordini che ricevono. Per eliminare resistenze nella struttura interna delle imprese, si fa ricorso a forme di pressione sui dipendenti, attraverso i meccanismi di premio o punizione, di incoraggiamento economico o rimozione, che creano condizioni obbiettive sfavorevoli rispetto alle norme. Così descrive la situazione un dipendente di Boatti: "Tra i vari modi che aveva di intimidirci, uno dei più frequenti era quello del licenziamento per tutti e a tal riguardo diceva che "non aveva più soldi", in quanto le protezioni gli costavano molto" (32).
Un'altra tecnica ampiamente usata da tutti i petrolieri per convincere i propri dipendenti a mantenere un comportamento coerente con gli interessi dell'impresa, era quella di rassicurarli di fronte ai pericoli, minimizzando le eventuali conseguenze della condotta illecita tenuta. Sempre un dipendente di Boatti, a questo proposito, spiega che il suo datore di lavoro era solito dire ai suoi subordinati "di non avere paura di nulla, date le sue protezioni pubbliche e politiche". Un ufficiale dell'Utif che si occupava della "SIPCA" di Bruino, dice "il Musselli Bruno ci tranquillizzò dicendo che la questione (l'arresto di Mottola del 1976, n.d.r.) era stata impostata e seguita da "loro" in modo da far sì che "non avesse alcun esito" (...). Il Musselli disse comunque che tutto, dopo il "boom" iniziale, sarebbe finito in una "bolla di sapone", date le loro influenze." (33)
Note
1. La teoria di Coleman è fondata sulla duplicità di motivazioni e opportunità.
Coleman sostiene che, perché un crimine del colletto bianco abbia luogo, devono presentarsi due elementi, la motivazione e l'opportunità. Il primo è legato alle cause psicologiche e sociali, il secondo alle cause strutturali. Motivazione e opportunità sono inseparabilmente interconnesse.
La motivazione può essere suddivisa in quattro elementi tra di loro correlati.
Il primo è il 'fattore personalità' e dipende dalla presenza di particolari tratti psicologici presenti tra i criminali dal colletto bianco. Sull'argomento sono stati condotti pochi studi e i risultati di questi, non sono apparsi sufficienti per tracciare un profilo psicologico del colletto bianco, non potendosi individuare un gruppo di caratteristiche comuni, sempre presenti in ciascun individuo. Tutti gli studi condotti sono giunti, d'altra parte, a una comune considerazione, che i criminali dal colletto bianco sono individui "normali", intendendo con ciò, non soggetti a patologie psichiatriche.
Secondo fattore che rientra nella motivazione è la cultura del soggetto. Il primo valore che viene in considerazione, parlando dei criminali dal colletto bianco, è il desiderio di guadagno economico. La cupidigia è comunemente ritenuta una delle principali cause dei crimini economici, ma non è assolutamente sufficiente a spiegare l'azione criminale. Un altro valore che condiziona la condotta individuale è la c.d. "paura di cascare". Molti criminali dal colletto bianco sono spinti, più che dal desiderio di incrementare le proprie ricchezze, dal timore di perdere ciò che si è acquisito. Il desiderio di incrementare i guadagni e di conservare ciò che si ha, sono due aspetti di uno stesso fenomeno che viene definito da Coleman "financial self-interest".
Un'altra potente motivazione che spinge l'individuo a divenire criminale è la volontà di apparire "vincente", indipendentemente dall'effettivo guadagno economico. Questo è uno dei valori principali in una società dove la competizione gioca un ruolo così preminente nel sistema economico. Il benessere economico e il successo sono valori propri della cultura della competizione, come complesso di norme e valori particolarmente forte nei sistemi sociali basati sul capitalismo industriale. La competizione, inoltre, è vista come produttrice di vantaggi non solo per il singolo individuo, ma per la stessa società intera, che gode vantaggi dallo sviluppo economico, conseguenza della competizione. Per questo, la competizione viene vista come "una giusta battaglia dove gli individui più capaci e che lavorano con maggiore impegno escono vittoriosi". Questa esaltazione del potere e della ricchezza ha, come corollario, una stigmatizzazione dei poveri, visti come 'pigri' e 'incompetenti'. Tutto ciò produce l'intensificazione degli sforzi volti ad ottenere il successo personale e il diffondersi di un globale senso di insicurezza, per la paura di non riuscire ad emergere tra i 'vincenti' nella competizione economica.
Le tecniche del crimine e le motivazioni favorevoli al comportamento criminale vengono apprese dall'individuo, attraverso l'associazione differenziale con i gruppi che le adottano. Non contraddicendo Sutherland, Coleman sostiene che la maggior parte dei criminali dal colletto bianco sono conformisti, nel senso che, in maniera automatica, si conformano al comportamento del sottogruppo di appartenenza. Una minoranza di essi, d'altra parte, "persiste nel mantenere peculiari concezioni della realtà anche con poco supporto da parte della società ed ignorando lo stigma che da questo atteggiamento può nascere". Questi soggetti sono 'innovatori', anticonformisti che creano nuove idee e definizioni, per poi trasmetterle agli altri individui. È ad essi che Coleman si riferisce quando parla di "vera devianza".
Un terzo fattore che influisce nella motivazione del crimine è la neutralizzazione del controllo sociale. La società, attraverso la scuola, i mass-media, la politica, la religione, insegna valori etici e proclama l'importanza di mantenere in tutti i settori un alto livello di eticità. È impensabile, quindi, che questi valori esulino dal bagaglio culturale dell'individuo, tanto più se egli appartiene alla categoria dei colletti bianchi. L'enfasi posta sull'etica determina, come conseguenza, una forte stigmatizzazione verso coloro che la violano, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza. Il timore di essere etichettati come violatori della morale (prima ancora che della legge) è per tutti, ma soprattutto per i colletti bianchi, qualcosa di "ripugnante".
In questo stato di cose, gli individui generalmente "vagano" tra una scelta conforme alla morale ed una ad essa contraria, determinando una situazione di conflitto interiore. Questa viene superata ricorrendo alle tecniche di neutralizzazione, teorizzate per primo da Matza, che consentono all'individuo di violare importanti standards normativi, evitando di considerare se stessi come criminali o devianti.
Non si tratta, comunque, di semplici giustificazioni ex post facto, bensì di vere e proprie razionalizzazioni che operano nel momento in cui il soggetto sta compiendo l'atto deviante.
Rispetto alle tecniche di neutralizzazione che interessano i criminali dal colletto bianco, Coleman ne propone alcuni esempi, precisando che una loro completa enunciazione non è possibile.
In tal modo, troviamo la "razionalizzazione del prestito", quando un individuo si appropria di cose altrui dicendo a se stesso che "le sta solo prendendo in prestito e che presto le restituirà".
Un altro esempio è la tecnica di neutralizzazione per cui il criminale si convince di "non fare male a nessuno". A questo proposito, Coleman riporta la seguente dichiarazione, raccolta in un processo contro alcuni colletti bianchi: "Illegale? Sì, ma non criminale... Io credo che azione criminale significhi danneggiare qualcuno, e nessuno di noi l'ha fatto."
Altra tecnica consiste nel considerare la legge violata come "non necessaria o ingiusta". Molti dei colletti bianchi riconosciuti colpevoli di reati economici si difendono, accusando i governi di inopportune interferenze attraverso leggi inappropriate, utilizzando spesso l'ideologia capitalista del laissez faire.
Altre tecniche di neutralizzazione consistono nel sostenere che il comportamento criminale "era necessario per sopravvivere o per raggiungere uno fine economico vitale" o che "tutti si comportano allo stesso modo", e, per questo, non c'è nulla di male nel conformarsi al comune comportamento dei propri pari.
Anche le tecniche di neutralizzazione prendono corpo all'interno di un sottogruppo, prima ancora che un individuo le utilizzi. Esse, nella maggioranza dei casi, vengono apprese; raramente, sono frutto di invenzione; spesso, vengono adattate alla propria situazione personale.
Quarto fattore che influenza la motivazione è legato alla presenza di un'organizzazione. L'impresa incontra diverse difficoltà nella commissione del crimine, prima delle quali è la necessità di convincere i propri dipendenti a eseguire le proprie direttive, anche se in violazione di norme. Tra le tecniche utilizzate per assicurare il conformismo con le aspettative dell'organizzazione è la minaccia del licenziamento. Di eguale effetto sono le minacce di retrocessione o di mancata promozione nella carriera, che alcuni percepiscono allo stesso livello della perdita dell'occupazione.
L'organizzazione spesso rappresenta un sottogruppo con propri valori etici. Questi vengono impersonati principalmente dagli individui al vertice delle organizzazioni. Di regola, ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni, seleziona il proprio personale, in base alla tendenza di ciascuno a tenere comportamenti vantaggiosi per l'azienda stessa. È quindi inevitabile che gli individui scelti siano quelli più portati al conformismo e al rispetto della sottocultura dell'impresa.
L'eccesso di lavoro, che è causa dell'affievolirsi dei legami con la famiglia, con gli amici, con la comunità, determina che il solo rapporto interpersonale del lavoratore sia con il mondo del lavoro. Questa situazione porta a una sorta di 'intorpidimento morale' del lavoratore. È l'impresa ad indicare al lavoratore i fini da raggiungere e i mezzi che devono essere usati per il loro raggiungimento. A ciò si aggiunge la forte frammentazione delle mansioni, all'interno dell'organizzazione, che determina, a volte, la mancata percezione dell'illegalità dell'operazione compiuta nel suo insieme, oltre ad offrire una chance in più di impunità a chi quell'operazione ha programmato, essendo spesso difficile, soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni, risalire a chi prende le decisioni.
Secondo Coleman, tutte queste condizioni portano a un progressivo isolamento del manager dal mondo esterno. Così si allontana l'individuo da chi, esternamente, potrebbe stigmatizzare il suo operato e si crea la convinzione che non esistano altri valori e opportunità diversi da quelli offerti dal proprio lavoro.
Eppure, la motivazione, per quanto sia forte da sola non è sufficiente perché l'individuo decida di commettere un crimine. È necessaria anche l'opportunità. Se non c'è l'opportunità non c'è crimine.
Il grado delle opportunità varia al variare di diversi fattori, tra cui la percezione soggettiva della probabilità di essere scoperti, la presunta severità dell'eventuale sanzione, l'entità del beneficio (pay-off) atteso dalla commissione del crimine. Ogni opportunità è valutata in comparazione con le altre disponibili e viene scelta quella che, tra tutte, appare come la più attraente.
La distribuzione delle opportunità illecite varia considerevolmente a seconda del tipo di mercato in cui un'impresa opera. Diversi studi hanno verificato che nei mercati più competitivi, dove maggiore è la lotta tra le imprese per emergere, più alti sono i tassi di criminalità. Nei mercati con molteplici imprese, i crimini sono connessi all'esigenza di diventare più competitivi, attraverso la commissione di frodi, pubblicità ingannevole, pratiche di spionaggio. Al contrario, in situazioni di oligopolio, i crimini sono piuttosto legati a pratiche di imposizione dei prezzi (price fixing), o di violazione della normativa antitrust. Le ricerche finalizzate a individuare le fattispecie criminali più diffuse, a seconda del tipo di mercato in cui le imprese operano, appaiono piuttosto difficili, secondo Clinard e Yeager, per la carenza di metodologie d'indagine efficaci.
Alcuni studi, hanno, tuttavia, evidenziato che in mercati in cui è presente una forte tassazione, le imprese sembrano costrette a vendere parte dei prodotti evadendo le imposte, per mantenere alto il volume delle proprie vendite. Needleman e Needleman hanno criticato questa coercizione operante sulle imprese. È un sistema 'facilitativo' del crimine, piuttosto che coercitivo. Le forti tassazioni rendono la scelta criminale più appetibile, ma non per questo impongono all'impresa tale scelta. Infatti, accanto a crimini direttamente legati alla forte imposizione fiscale, esiste sempre una vasta sfera di crimini economici che ad essa non possono essere eziologicamente ricollegati.
Un'altra variabile che influenza le opportunità criminali è la struttura organizzativa del mercato, costituito da diverse imprese simili che hanno la possibilità di conoscere vicendevolmente le proprie azioni. Di regola, tali imprese non sono tutte su uno stesso livello, ma tendono a disporsi secondo una piramide, con al vertice le imprese dominanti nel mercato, e alla base quelle che possono essere considerate marginali, di minori dimensioni. La presenza di poche grandi imprese al vertice facilita la formazione di cartelli e di oligopoli e conseguentemente l'accrescersi delle opportunità criminali.
Un'altra variabile è costituita dalla complessità del sistema normativo in un determinato settore economico. Più complesso è il sistema, maggiore è il numero di norme coercitive, maggiore è la pressione fiscale esercitata sulle imprese, più numerose sono le opportunità illecite.
Un'ultima considerazione va fatta per la facilità con cui le pratiche illegali 'contagiano' le imprese che operano in uno stesso mercato. Grazie anche alla mobilità dei lavoratori da un'impresa ad un'altra, la conoscenza riguardo alle opportunità illecite viene trasmessa tra le imprese, con la stessa velocità con cui circolano le tecniche di neutralizzazione.
2. G. S. Green, Occupational Crime, 1990, Nelson-Hall, Chicago, p.13.
3. E. H. Sutherland, White Collar Crime: The Uncut Version, Yale University Press, New Haven, 1983, p.7.
4. Cfr. L. S. Schrager e J. F. Short, "Toward a Sociology of Organizational Crime", in Social Problems, n. 25, 1977, pp. 407-19.
5. Cfr. S. Box, cit.
6. Ivi, p. 22.
7. Ibidem.
8. "Io ne ero a conoscenza (riferendosi al contrabbando, n.d.r.) e le motivazioni di queste operazioni illecite si debbono ricercare nelle necessità economiche nel settore petrolifero notoriamente in crisi nell'ambito della raffinazione da anni", cfr. sent. 2/06/1988 cit., p. 440.
9. R. E. Lane, The Regulation of Businessmen: Social Conditions of Government Economic Control, New Haven, Yale University Press, 1954, p.90.
10. D. Weisburd, S. Wheeler, E. Waring e N. Bode, Crimes of the Middle Classes: White-Collar Offenders in the Federal Courts, New Haven, Yale University Press, 1991, p. 224.
11. Cfr. S. Wheeler, "The Problem of White-Collar Crime Motivation", in K. Schlegel e D. Weisburd, cit., pp. 108 e ss.
12. Ivi, p. 110.
13. Ivi, p. 111.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. "avoiding falling back", ivi, p. 115.
17. D. Kahneman e A. Tversky, "Prospect Theory: An analysis of decision under risk", Econometrica, 1979, n. 47, pp. 263-291.
18. Cfr. sentenza di I grado del Tribunale di Milano, 15 giugno 1983, in G. Galli, cit., p. 185.
19. V. Ruggiero, cit., p. 81.
20. F. H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, New York, 1921.
21. Cfr. l'intervista a Musselli in "I miei affari con Freato", in Panorama, 10 novembre 1980, p. 63.
22. J. W. Coleman, cit., p.368.
23. Cfr. D. R. Cressey, Other People's Money: The Social Psychology of Embezzlement, New York, The Free Press, 1953.
24. Aristotele, Politica, libro II, cap. VII.
25. L. M. Solivetti, cit., p.53.
26. E. Gross, "Organizational Crime: A Theoretical Perspective", in N. Denzin, Studies in Symbolic Interaction, Greenwich, Jai Press, 1978, p.55.
27. Cfr. V. Ruggiero, Delitti dei deboli e dei potenti, esercizi di anticriminologia, Bollati Boringhieri, 1999, pp. 11 e ss.
28. Ibidem.
29. J. W. Coleman, cit., p.372.
30. D. della Porta e A. Vannucci, Un paese anormale. Come la classe politica ha perso l'occasione di Mani Pulite, p.54.
31. Cfr. contrabbando presso la "Siplar", par. 2.2.3.2.
32. Sent. 2 giugno 1988, cit., Vol II, p.455.
33. Sent-ord. 14 agosto 1985, cit., p.258.