Capitolo primo
Il lavoro penitenziario
1. Il lavoro nell'ordinamento penitenziario: finalità e caratteri
Il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario avente come fine ultimo la rieducazione e la risocializzazione del condannato in attuazione del disposto costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (1) (art. 27 terzo comma). L'art. 15 della legge contenente le norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (l. 354 del 26 luglio 1975) prevede che il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi "principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno", e inoltre che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato [sia] assicurato il lavoro". L'art 20 ord. pen. stabilisce l'obbligatorietà del lavoro per i soli condannati, infatti tale obbligo non può riguardare gli imputati i quali, vigendo la presunzione d'innocenza (2), non devono essere sottoposti al trattamento penitenziario, ma possono essere ammessi a svolgere attività lavorative soltanto laddove ne facessero richiesta e purché non sussistano giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria (art. 15 terzo comma, ord. pen.).
Notevole attenzione al lavoro in esecuzione pena è posta anche dalle Regole penitenziarie europee approvate con Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (87) 3 del 12 febbraio 1987, parzialmente modellate sul testo delle Regole minime per il trattamento dei detenuti, contenute nella Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955, e recentemente integrate da un'ulteriore Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (3). Tale documento, definito come "carta dei diritti dei detenuti" (4), ha ispirato anche la legislazione italiana in materia penitenziaria, ponendo i tratti salienti di un trattamento penitenziario che sia conforme al principio di umanità della pena, dunque non lesivo della dignità della persona umana, e finalizzato non alla segregazione ed esclusione del detenuto dalla società ma al suo reinserimento. Strumento fondamentale a tal fine è il lavoro, concepito come anello di congiungimento fra il momento dell'esecuzione pena e il ritorno in società; l'art. 3 della raccomandazione (87) 3 dispone che "la finalità del trattamento dei condannati deve essere [...] nella misura in cui lo permette la durata della pena, quella di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione" (5).
La fondamentale importanza del lavoro quale elemento di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto è d'altronde rafforzata dalla centralità attribuita allo stesso, in generale, nella società dei "liberi" e riflessa nell'ordinamento giuridico (6); tale assunto si ricava innanzitutto da alcune disposizioni contenute nei principi fondamentali della Costituzione italiana: "l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" (art. 1), "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4). Inoltre l'art. 35 prevede che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", e di certo il lavoro penitenziario può considerarsi compreso nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Si può dunque sostenere con sicurezza che le disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro (artt. 20 e ss. l. 354 e artt. 47 e ss. D.P.R. 230/2000, cosiddetto "regolamento penitenziario") diano attuazione alle previsioni costituzionali su menzionate (7), a meno di non voler affermare che la detenzione faccia venire meno lo status di cittadino della persona ristretta nella propria libertà personale (8), e dunque la esenti dai doveri "inderogabili" di solidarietà economica, politica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione e dal diritto-dovere di lavorare per contribuire al progresso della società di cui all'art. 4.
Il lavoro è visto come elemento principale del trattamento penitenziario in quanto abituando il detenuto a svolgere un'attività produttiva, non solo contribuisce al suo sostentamento ed eventualmente fornisce una fonte di sostegno economico alla famiglia, ma soprattutto favorisce l'acquisizione da parte dello stesso di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale. A tal fine è necessario che si tratti di un lavoro produttivo, gratificante e in particolare remunerato.
In secondo luogo in prospettiva del reinserimento sociale a seguito della detenzione, il lavoro in istituto dovrebbe essere organizzato in maniera tale da far acquisire al detenuto delle capacità professionali spendibili all'esterno così da essere in grado di reggere alla frenetica competizione che caratterizza il mercato occupazionale oggigiorno. In tal senso il lavoro assolve soprattutto una funzione di prevenzione speciale, anti-recidivante, dal momento che se è vero che la maggior parte dei delitti commessi in Italia sono delitti contro il patrimonio (9), la possibilità di avere una fonte di sostentamento e di guadagno 'alternativa' e socialmente accettata e incoraggiata, dovrebbe fungere da deterrente al compimento di ulteriori reati (10). Al riguardo è stato obiettato che "l'idea dell'efficacia taumaturgica del lavoro carcerario è legata allo stereotipo del delinquente povero e socialmente emarginato", al contrario "perde di valore rispetto alla moderna criminalità organizzata ed ampiamente lucrativa, alla criminalità politico-terroristica ed alla criminalità degli affari e dei colletti bianchi", infatti rispetto a questi nuovi tipi di devianza il lavoro carcerario servirebbe al più "per combattere il taedium carceris" (11). Tuttavia questa obiezione non sembra portare a disconoscere l'importanza del lavoro carcerario, innanzitutto perché la maggior parte della popolazione penitenziaria rientra appieno nello stereotipo del "delinquente povero e socialmente disadattato", e secondariamente perché nei confronti dei detenuti per i quali il lavoro non sortirebbe alcuna funzione rieducativa, lo svolgimento di un'attività impegnativa sarebbe comunque un valido rimedio all'abbrutimento e agli effetti degradanti della detenzione (12).
Il legislatore ha previdentemente attribuito al lavoro penitenziario dei requisiti indispensabili affinché potesse assolvere la funzione di strumento principale del trattamento rieducativo: innanzitutto il lavoro in carcere non deve avere "carattere affittivo" (art. 20 secondo comma ord. pen.), ovvero non può essere considerato come componente di maggiore inasprimento della pena, alla stregua dei cosiddetti "lavori forzati" (13), pertanto perché il lavoro non costituisca mera fatica fisica, e quindi sofferenza aggiunta alla privazione della libertà, sono particolarmente importanti anche la specie e l'organizzazione delle attività lavorative assegnate ai detenuti. In questa ottica, non si può partire dal presupposto della considerazione del lavoro come "bene in sé per la funzione medicinale-rieducativa che assolve" (14) indipendentemente dalle modalità con cui deve essere svolto, dai risultati che produce, dalle prospettive concrete che offre, in quanto prescindendo da queste considerazioni si dovrebbe valutare positivamente anche un lavoro del tutto improduttivo e marginale così che si finirebbe di fatto con il privilegiarne la funzione afflittiva.
In secondo luogo il legislatore ha previsto che il lavoro penitenziario debba essere remunerato (art. 20 secondo comma ord. pen.). La retribuzione come controprestazione per l'attività lavorativa svolta durante la permanenza in istituto, da un lato, evita la sensazione di essere sfruttati, dall'altro dà in concreto l'idea dell'utilità del proprio lavoro, per sé in quanto diviene fonte di guadagno e di sostentamento, e per la comunità in cui si è inseriti, dal momento che ogni attività lavorativa rappresenta il risvolto tangibile del proprio ruolo sociale. Perché la remunerazione riesca a produrre tali benefici effetti psicologici sul detenuto, o meglio, più in generale sul lavoratore, è necessario che siano rispettati i criteri stabiliti dall'art. 36 della Costituzione: proporzione alla qualità e quantità del lavoro e, in ogni caso, sufficienza per "assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". In definitiva dovrebbero valere per il lavoratore-detenuto gli stessi criteri di determinazione della retribuzione che valgono per il lavoratore-libero, invece per avvantaggiare la posizione del detenuto-lavoratore sul mercato del lavoro, in quanto a competitività rispetto alla domanda di lavoro del libero lavoratore, il legislatore è intervenuto proprio in punto di retribuzione, legittimando alcune differenze in negativo per il lavoratore-detenuto (15).
Altra caratteristica saliente del lavoro penitenziario è l'obbligatorietà, infatti l'art. 20, terzo comma, dell'ordinamento penitenziario prevede che il lavoro sia "obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro", mentre "i sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche" (16). In entrambi i casi si evince che il lavoro è inteso come elemento positivo del trattamento, pertanto salvo particolari ragioni che possono sussistere nei casi di infermità o minorazione psichica, lo svolgimento di un'attività lavorativa è obbligatoria, in quanto obbligatorio è il trattamento rieducativo. Questo non significa che il detenuto sia costretto a partecipare all'opera di rieducazione laddove manchi di volontà (17), ma che sussiste pur sempre l'obbligo di impostare la pena e la sua esecuzione sul principio rieducativo. Dunque deve comunque essere offerta una chance di riabilitazione e risocializzazione al detenuto che volesse profittarne, da ciò consegue che l'obbligo in questione abbia un duplice orientamento, verso il detenuto che partecipa al trattamento e verso l'amministrazione penitenziaria che deve fornire gli strumenti adeguati alla rieducazione della popolazione penitenziaria (art. 15 secondo comma, ord. pen.). Al riguardo l'art. 20 ord. pen. stabilisce che "negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale" (18).
Altra caratteristica fondamentale del lavoro penitenziario è la finalizzazione rieducativa, ovvero l'essere strumento principale del trattamento ai fini della risocializzazione del detenuto. Pertanto il legislatore ha previsto che "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". L'obiettivo principale della normativa in materia di lavoro penitenziario dovrebbe così essere quello di favorire ad ogni modo il reperimento di attività lavorative e di organizzarle in maniera tale che non vi sia alcuno scarto fra il lavoro 'libero' e il lavoro intra moenia. Se questo traguardo fosse realmente raggiunto, il lavoro costituirebbe il ponte di passaggio dalla detenzione alla libertà, che avverrebbe perciò senza soluzioni di continuità, evitando quanto correntemente si verifica al momento delle dimissioni, ovvero la sensazione di poter fare tutto ciò che si vuole, e la condizione di emarginazione sociale in cui si versa per il fatto di portare con sé il marchio della detenzione.
Infine ultimo requisito o meglio condizione di legittimità, che il legislatore ha previsto per il lavoro penitenziario è l'oggettività nell'assegnazione. Infatti l'art. 20, sesto comma, detta i criteri di carattere assolutamente oggettivo, per redigere le graduatorie (le cosiddette 'liste lavoranti"), sulla cui base dovranno essere distribuiti i posti di lavoro disponibili all'interno e all'esterno dell'istituto, indipendentemente dal fatto che siano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di terzi (19). La previsione di criteri prefissati dalla legge dovrebbe consentire da un lato di gestire meglio l'assegnazione dell'esiguo numero di posti di lavoro che generalmente sono messi a disposizione nelle carceri, nonostante le molteplici richieste di lavoro dei detenuti, e dall'altro di fugare il pericolo che le opportunità lavorative vengano utilizzate come strumento di arbitrio e di abuso di potere da parte dell'amministrazione penitenziaria, finendo così nel generare nella popolazione penitenziaria l'idea che il lavoro sia privilegio di pochi e ambito di ulteriore discriminazione e ingiustizia.
2. Obbligo del lavoro e diritto al lavoro
Un lungo dibattito dottrinale si è avuto, a seguito dell'approvazione dell'ordinamento penitenziario del 1975, riguardo alla configurabilità del lavoro penitenziario come diritto o piuttosto come obbligo gravante sul detenuto. Infatti sia il Codice Rocco (artt. 22-23-25 c.p. (20)), sia il previgente regolamento penitenziario (R.D. n. 787 del 1931) affermavano senza alcuna incertezza l'obbligo del lavoro per detenuti e internati (21). La legge n. 354 invece per un verso sembra confermare l'obbligo del lavoro durante l'esecuzione della pena detentiva: l'art. 20 al terzo comma dispone che il lavoro è obbligatorio "per i detenuti e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro". Allo stesso tempo, però, in altre disposizioni contraddice l'imperatività di tale obbligo laddove prevede che "negli istituti penitenziari deve essere favorita ad ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro" (art. 20 comma primo) e che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro" (art. 15 secondo comma). Da queste ultime disposizioni sembrerebbe prima facie che il legislatore abbia previsto solo in maniera tendenziale l'obbligo del lavoro, come una sorta di direttiva rivolta più che altro all'amministrazione penitenziaria la quale deve "favorire" e "assicurare" il lavoro alla popolazione penitenziaria, con la conseguenza che in capo ai detenuti sarebbe configurabile un vero e proprio diritto ad ottenere un'attività lavorativa, considerando inoltre che il lavoro è strumento principale del trattamento rieducativo e appiglio efficace e sicuro di reinserimento sociale.
Parte della dottrina ha sostenuto fermamente che l'ordinamento penitenziario del 1975 abbia semplicemente confermato l'obbligo del lavoro per il detenuto, partendo dal presupposto che è elemento saliente del trattamento, pertanto la previsione di un obbligo ribadirebbe il "profondo valore rieducativo" del lavoro penitenziario, tale da qualificarlo come indispensabile e di conseguenza, doveroso per il condannato ad una pena detentiva (22).
Altra parte della dottrina ha invece interpretato in maniera fortemente innovativa la riforma del 1975, proponendo la qualificazione del lavoro carcerario come vero e proprio diritto per il detenuto. L'argomentazione principale a sostegno di questa tesi è rinvenuta nello stesso dettato normativo laddove si dice che ai detenuti è "assicurato" il lavoro (art. 15), da tale previsione si ricaverebbe la possibilità per il detenuto di vantare una pretesa nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, la quale se non venisse soddisfatta, darebbe luogo ad un "diritto azionabile a contenuto patrimoniale" (23). Pertanto la mancata assegnazione di un'attività lavorativa sarebbe "fatto generatore di responsabilità risarcitoria nei confronti dell'amministrazione penitenziaria" (24) per danni quali la mancata percezione della retribuzione (rectius mercede), e la perdita della capacità e qualificazione professionale. E' evidente però come una siffatta interpretazione conduca molto lontano rispetto a quanto previsto dal dettato legislativo: basta considerare soltanto che l'amministrazione penitenziaria può esimersi dall'obbligo di fornire un'attività lavorativa al detenuto adducendo un "caso di impossibilità" (art. 15 secondo comma), formula piuttosto ampia che consente un impiego piuttosto discrezionale e tuttavia legittimo (25).
L'interpretazione più plausibile e conforme allo 'spirito' della legge sull'ordinamento penitenziario sembra essere piuttosto quella di considerare il lavoro penitenziario parimenti come diritto ed obbligo per il detenuto. Le argomentazioni a sostegno di questa conclusione possono essere tratte innanzitutto dal testo di legge: "il lavoro è obbligatorio" (art. 20 terzo comma) e allo stesso tempo deve essere "assicurato" ai condannati e agli internati (art. 15 secondo comma). Ne consegue, in primo luogo che alla luce della nostra carta costituzionale, secondo la quale "le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma) (26), il lavoro penitenziario così come inteso dall'attuale ordinamento penitenziario, ha perso ogni connotato di afflittività per divenire strumento principale del trattamento rieducativo (27). L'obbligatorietà è giustificata proprio partendo dal presupposto che lo svolgimento di un'attività lavorativa è parte integrante e saliente del percorso riabilitativo, e non più pena accessoria alla detenzione, quindi l'amministrazione penitenziaria ha l'onere di adoperarsi per assicurare a ciascun detenuto tale chance di reintegrazione sociale (28).
Alcuni autori, a fondamento di questa interpretazione, hanno sostenuto che l'ordinamento penitenziario qualificando il lavoro svolto durante l'esecuzione pena come diritto e nello stesso tempo obbligo per il condannato, avrebbe dato piena attuazione all'art. 4 della Costituzione che parimenti prevede "il diritto al lavoro" e il "dovere" per ogni cittadino di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (29).
Una volta ammessa la duplice configurazione del lavoro penitenziario, occorre stabilire quali sono le conseguenze della previsione dello stesso come obbligo, e quali i vantaggi che derivano dalla sua qualificazione come diritto. Innanzitutto si deve ribadire che l'obbligo del lavoro grava solo sui detenuti condannati, e non anche sugli imputati, e sui soggetti sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro (30).
Dalla previsione del lavoro penitenziario come obbligatorio consegue che il detenuto, una volta ammesso al lavoro, deve svolgere l'attività assegnatagli, nonostante possa non corrispondere alle proprie attitudini o preferenze. Infatti il legislatore ha annoverato fra i criteri per l'assegnazione dei soggetti al lavoro la professionalità, le precedenti e documentate attività svolte e quelle cui il detenuto potrà dedicarsi dopo le dimissioni (art. 20 sesto comma ord. pen.). Stante l'esiguità di posti di lavoro a disposizione dei detenuti all'interno del carcere, è verosimile che non sia possibile rispettare integralmente tali criteri, perciò il legislatore ha provveduto a stabilire che "i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto" (art. 50 D.P.R. 230/2000, cosiddetto "regolamento penitenziario"). Ne consegue che il "volontario inadempimento degli obblighi lavorativi" integra un'ipotesi di infrazione disciplinare (art. 77 regol. penit. (31)), la quale a sua volta è presupposto per l'applicazione di una sanzione disciplinare. Sulla base di ciò, si può sostenere che l'obbligo del lavoro è coercibile sul piano disciplinare, soprattutto perché la contestazione e l'addebito di sanzioni disciplinari rilevano ai fini della valutazione dell'andamento del percorso riabilitativo, ovviamente in senso negativo, potendo pregiudicare l'accesso ai benefici, quali il permesso premio (art. 30 ter, ord. pen.) e la liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.), nonché la successiva eventuale ammissione ad una delle misure alternative (artt. 47 e ss.) (32).
La fondamentale differenza fra condannati ed imputati per quanto riguarda il lavoro penitenziario è che questi ultimi non essendo e non dovendo essere sottoposti al trattamento rieducativo di cui all'art. 13 ord. pen., possono essere ammessi a lavorare solo su espressa richiesta, e salvo che non sussistano contrarie disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria procedente o "giustificati motivi" addotti dall'amministrazione penitenziaria. Dunque nei confronti dell'imputato non opera l'obbligo del lavoro, tuttavia, laddove questi fosse ammesso a svolgere un'attività lavorativa, non potrebbe sottrarsi arbitrariamente a tale adempimento, tale conclusione si trae sulla base del presupposto che le sanzioni disciplinari sono applicabili anche agli imputati, facendo, infatti, il testo di legge riferimento ai "detenuti" e prevedendo che "delle sanzioni inflitte all'imputato sia data notizia all'autorità giudiziaria che procede" (art. 77 u.c. regol.penit.). Quindi anche il "volontario inadempimento degli obblighi lavorativi" da parte di un imputato è disciplinarmente coercibile, con la differenza che gli effetti negativi del rapporto addebitato saranno subiti a posteriori, a seguito della sentenza di condanna.
Configurando invece il lavoro penitenziario come diritto, alla luce dell'art. 4 della nostra carta costituzionale, ne consegue che il detenuto vanta una pretesa nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, alla quale corrisponde il dovere, da parte di questa ultima, di reperire un'attività lavorativa, fatta salva soltanto la possibilità di addurre la sussistenza di un "caso di impossibilità" se si tratta di un condannato o internato, ovvero un "giustificato motivo" se si tratta di un imputato (art. 15 ord. pen.). Esaminando più da vicino la normativa, si evince che la clausola di esenzione da tale onere nei confronti in particolare degli imputati è piuttosto ampia, potendo i giustificati motivi sussistere non solo per ragioni oggettive, ma anche sulla base di valutazioni discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, incluse quelle attinenti al soggetto. Nel caso dei condannati, invece, l'amministrazione penitenziaria può esimersi solo in "casi di impossibilità", clausola meno aperta rispetto ai giustificati motivi, facendo riferimento alle sole ipotesi di "difficoltà oggettive ed insormontabili" (33), escluse dunque le mere valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione penitenziaria, ma del pari piuttosto ampia da consentire una certa libertà di movimento nelle giustificazioni adducibili.
L'ultimo punto da esaminare con riferimento al diritto-obbligo dal detenuto di svolgere un'attività lavorativa e al corrispondente dovere dell'amministrazione penitenziaria di offrire tale possibilità, concerne le ipotesi di detenuti affetti da infermità o minorazione fisica o psichica. Si deve innanzitutto distinguere la categoria dei soggetti sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario, i quali "possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche", in tal caso dunque, lo svolgimento di un'attività lavorativa è riguardato dal legislatore come ausilio al trattamento (cosiddetta "ergoterapia"). Nei confronti di tali soggetti non sussiste l'obbligo del lavoro, ma qualora fossero ammessi a svolgere un'attività lavorativa, l'amministrazione penitenziaria avrebbe comunque l'obbligo di reperire un posto di lavoro, potendosi sottrarre a tale onere soltanto se sussiste un caso di impossibilità o un giustificato motivo. Infatti nel silenzio del legislatore sul punto si è ravvisato implicitamente la possibilità di applicare la regola che vale generalmente per condannati ed internati, ovvero l'esonero per l'amministrazione penitenziaria nei casi di impossibilità. Tuttavia vista la particolare condizione personale dei soggetti in questione, sembra opportuno ritenere applicabile anche la clausola di 'salvataggio' dei giustificati motivi, che per l'appunto possono riferirsi non solo a circostanze impeditive di carattere oggettivo ma anche a particolari valutazioni attinenti alle condizioni dell'internato (34).
I detenuti e gli internati che si trovano in condizioni di infermità o minorazione fisica, sono gravati dall'obbligo del lavoro ovviamente nei limiti in cui la malattia o l'anormalità consenta loro di avere una reale capacità lavorativa. Qualora sussista un'infermità o seminfermità psichica, senza però che i detenuti che ne sono affetti siano sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia o dell'ospedale psichiatrico giudiziario, questi sono ammessi a svolgere un'attività lavorativa, e dunque hanno l'obbligo di effettuarla, quando "a giudizio del sanitario sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile", godendo ovviamente di tutti i relativi diritti, in particolare in punto di retribuzione (art. 20, quarto comma, regol. penit.). Al contrario se i detenuti o gli internati infermi o seminfermi di mente non siano in grado di esprimere una reale capacità professionale, "possono essere assegnati ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale" (art. 20, quinto comma).
Nonostante l'accuratezza con cui il legislatore ha disciplinato il lavoro penitenziario dal punto di vista della sua qualificazione come diritto ed obbligo per il detenuto, nella realtà della vita carceraria, questi è inteso piuttosto come un privilegio vista la scarsità delle opportunità lavorative offerte alla popolazione dei reclusi. Non è un caso che nella maggior parte degli istituti vengano impiegati meccanismi di rotazione secondo la formula del part-time "verticale", in modo da impiegare ciascun detenuto limitatamente ad un certo periodo di tempo e consentire l'alternanza ciclica alla stessa attività lavorativa del maggior numero possibile di detenuti (35). In definitiva pertanto non si pone neppure il problema della coercizione al lavoro, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi i detenuti e gli internati sono desiderosi di essere impiegati in un'attività lavorativa, se non altro, nel peggiore dei casi, per rompere la monotonia della vita carceraria.
3. Formazione e acquisizione di capacità professionali in carcere
La fondamentale importanza attribuita al lavoro penitenziario è giustificata, come si è già avuto occasione di sottolineare, dal presupposto che il lavoro costituisce lo strumento principale di riabilitazione e reintegrazione sociale. A tal fine è necessario che il lavoro svolto in esecuzione pena consista in un'attività qualificante dal punto di vista professionale, che permetta al detenuto di acquisire delle capacità lavorative spendibili sul mercato del lavoro, una volta ritornato in libertà. Al riguardo sembra opportuna la previsione legislativa secondo cui "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale" (art. 20 comma quinto, ord. pen.). Inoltre, i detenuti e gli internati che non siano in grado di essere ammessi direttamente a svolgere un'attività lavorativa, essendo carenti di attitudini e capacità professionali, possono essere destinati a "corsi di formazione professionale" (primo comma) oppure se rientrano nella categoria dei "soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche, possono essere ammessi ad un tirocinio retribuito" (sedicesimo comma). Al riguardo vengono in rilievo anche alcune disposizioni contenute nelle Regole penitenziarie europee, in particolare l'art. 71 al quarto comma prevede che "nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi onestamente da vivere dopo la dimissione" (36) e ancora al quinto comma che "bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne e particolarmente ai giovani".
Il legislatore ha previsto così svariate opzioni, prefissandosi come traguardo quello di assicurare che il periodo trascorso in detenzione non divenga mero isolamento dalla società ma possibilità di recupero e reinserimento sociale. Pertanto è necessario che il lavoro penitenziario non sia ridotto a quelle poche attività lavorative che servono alla sopravvivenza dello stesso istituto, ma sarebbe bene modellare il lavoro all'interno su quello esterno, per fornire al detenuto uno strumento concreto di reinserimento sociale. Infatti, non basta svolgere una qualsiasi attività, è necessario bensì che si tratti di un lavoro qualificato e qualificante dal punto di vista professionale, produttivo e soprattutto remunerato, in modo da dare al detenuto la possibilità di trarne immediati e palpabili benefici, altrimenti il lavoro in carcere finirebbe col divenire "inutile e perfino controproducente, se il soggetto ne ricava misere retribuzioni con la sensazione di un autentico sfruttamento" (37). Un'attività lavorativa, poi, che non soddisfacesse i requisiti della produttività e della qualificazione propri del lavoro all'esterno violerebbe indubbiamente il principio della dignità del lavoro e non servirebbe neppure a fornire al detenuto le attitudini e le capacità richieste dal mercato del lavoro esterno, "il lavoro non sarebbe più un elemento del trattamento ma soltanto una metodologia di governo su base meramente occupazionale" (38).
Le scarse risorse economiche, umane e professionali dedicate a tale settore nonché la difficoltà oggettiva di riprodurre in carcere le molteplici e variegate attività lavorative che possono essere svolte nel mondo 'libero', fanno sì che il lavoro penitenziario si riduca nella maggior parte dei casi in due tipi di attività: i servizi d'istituto e le cosiddette "lavorazioni". I primi consistono nelle cosiddette "attività domestiche", necessarie per la vita quotidiana dell'istituto (39); le lavorazioni, invece, si risolvono in attività di tipo industriale dirette alla produzione di beni destinati principalmente, se non esclusivamente -come avviene nella stragrande maggioranza dei casi-, all'amministrazione penitenziaria (40). Scarsissimo è il numero di detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dal carcere oppure ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 ord. pen.) (41). Queste poche informazioni sui tipi di lavoro carcerario consentono di affermare che trattandosi di attività tipiche dell'istituto penitenziario, non consentono al detenuto di acquisire delle capacità lavorative o delle attitudini professionali spendibili, quantomeno facilmente, all'esterno.
Per quanto riguarda i corsi professionali, il legislatore in ottemperanza al dettato costituzionale per il quale "la Repubblica cura l'elevazione e la formazione professionale dei lavoratori" (art. 35 secondo comma), ha previsto che "negli istituti penitenziari debba essere favorita ad ogni modo [...] la partecipazione di detenuti ed internati a corsi di formazione professionale" (art. 20 ord. pen.) al fine di consentire a quei soggetti che volessero acquisire specifiche abilità e cognizioni professionali, di poterlo fare nonostante la restrizione della libertà personale. In questo modo, il periodo di detenzione sarebbe trascorso utilmente come momento di formazione e preparazione professionale, in modo da acquisire 'titoli' da spendere all'esterno e avere così più chances di reinserimento attraverso il lavoro nella società 'libera'. Tuttavia, anche in tal caso la scarsità di risorse finanziarie e di figure professionali disposte ad occuparsi dell'ambito penitenziario, determinano un generale insuccesso, sia per l'esiguo numero di corsi organizzati sia per l'altrettanto esiguo numero di detenuti ed internati che ne beneficiano. Inoltre laddove il corso professionale fosse portato a termine con buon esito, rimarrebbe sempre il problema del reperimento dell'attività lavorativa cui era finalizzato.
Infine il legislatore si è preoccupato di prevedere l'istituto del tirocinio "retribuito" per quei "soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche" (art. 20 sedicesimo comma, ord. pen.) (42). A differenza del previgente regolamento penitenziario, il tirocinio è ora previsto solo per i soggetti che essendo carenti di competenza, non possono essere direttamente ammessi al lavoro. Inoltre è stata sottolineata l'importanza di attribuire una retribuzione al tirocinante, prevedendo pertanto un obbligo ex lege. Molti autori hanno sostenuto la possibilità di assimilare la regolamentazione del "tirocinio" prevista dal legislatore penitenziario a quella dell'"apprendistato", tuttavia esistono delle notevoli differenze fra i due istituti, soprattutto in punto di presupposti per l'ammissione, basti considerare che l'apprendistato è rivolto ai "giovani" di età non superiore ai ventinove anni, mentre nel caso del tirocinio dei detenuti di sicuro si prescinde da qualsiasi limite di età (43). Rimane poi insoluto anche la questione delle modalità di assegnazione al tirocinio nonché della durata dello stesso, essendo il legislatore rimasto in silenzio al riguardo. La soluzione da più parti suggerita è quella di ritenere applicabili per quanto riguarda le modalità di ammissione al tirocinio, i criteri previsti dall'ordinamento penitenziario per l'ammissione al lavoro, essendovi affinità fra i due istituti. Invece per quanto concerne la durata del tirocinio, si potrebbe fare riferimento a quella prevista dalla disciplina sull'apprendistato non sussistendo alcun ostacolo al riguardo (44).
Concludendo il discorso sulla formazione e l'acquisizione di professionalità in carcere, si può sostenere che, fatte salve le sporadiche iniziative di introduzione di corsi professionali, l'istituto penitenziario non è certamente il posto adatto per dare vita ad un lavoro così come concepito dal legislatore ai fini della riabilitazione e reintegrazione sociale. Ciò non significa negare l'importanza del lavoro quale strumento di reinserimento, bensì porre le premesse per una soluzione alternativa. Considerate infatti la carenza di disponibilità finanziaria e di risorse, la ristrettezza fisica di un luogo quale il carcere, nel quale non possono certo essere riprodotte tutte le tipologie di lavoro del mondo 'libero', le esigenze della stessa prigione, nella quale particolare importanza assumono l'ordine e la sicurezza, e considerando più in generale l'insuccesso del modello di Stato-imprenditore, si dovrebbe, come da più parti suggerito, puntare su modelli di lavoro penitenziario alternativi e su un ruolo diverso della stessa amministrazione penitenziaria. In particolare quest'ultima più che datrice di lavoro, dovrebbe dedicarsi al mero reperimento di opportunità lavorative, alle dipendenze di terzi, siano essi privati ma soprattutto cooperative sociali (45). Se così fosse il lavoro penitenziario non sarebbe più ristretto alle attività domestiche e ai servizi necessari per la sopravvivenza dell'istituto, ma consisterebbe sempre più in opportunità di lavoro extra moenia, attraverso il beneficio dell'ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. pen, o delle misure alternative della semilibertà (art. 48) e dell'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47), così da essere realmente assimilabile al lavoro libero, in particolare in punto di tutele e di retribuzione (46).
4. Criteri per l'ammissione al lavoro
Il dato normativo costituisce il riferimento sicuro da cui partire per lo studio della procedura di collocamento al lavoro dei detenuti; il legislatore si è infatti preoccupato di disciplinare in maniera dettagliata i criteri e il procedimento per l'ammissione al lavoro, prevedendo oculatamente che proprio la funzione dell'assegnazione al lavoro sarebbe potuta divenire per l'amministrazione penitenziaria il terreno più fertile su cui coltivare privilegi ed abusi di potere. Dunque la predeterminazione ex lege di criteri certi sulla cui base distribuire i posti di lavoro disponibili fra la popolazione penitenziaria dovrebbe assicurare l'esclusione di qualsiasi scelta discrezionale da parte dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto l'art. 20 al sesto comma della legge contenente l'ordinamento penitenziario prevede che "nell'assegnazionedei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bisdella presente legge". Ancora l'art. 49 del regolamento penitenziario precisa che "nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge". Si tratta evidentemente di criteri oggettivi, sulla cui base deve essere accordata la precedenza ai detenuti e agli internati che siano stati durante il periodo di carcerazione più a lungo privi di un'attività lavorativa e che abbiano maggiore urgenza economica tenuto conto dei doveri di mantenimento della famiglia. Una volta soddisfatti questi criteri preliminari, si dovrà tener conto delle attitudini e capacità professionali del soggetto da ammettere al lavoro, facendo riferimento alle attività in precedenza svolte e alle prospettive future di lavoro, così che tendenzialmente potrebbe essere assegnata a ciascun soggetto l'attività lavorativa più confacente alle proprie abilità. Essendo detenuti ed internati sottoposti all'obbligo del lavoro, laddove non fossero disponibili attività lavorative rispondenti ai criteri suddetti, questi sono comunque tenuti a svolgere "un'altra attività lavorativa fra quelle organizzate nell'istituto" (art. 50 regol. penit.). Infine, anche se il legislatore non dispone nulla al riguardo, è pacifico che a parità di condizioni e di capacità sussiste per i condannati e gli internati nelle assegnazioni al lavoro, un diritto di preferenza -una sorta di diritto di prelazione si potrebbe dire- rispetto agli imputati (47).
Si deve sottolineare come il legislatore abbia tenuto a precisare che i criteri prefissati per l'assegnazione al lavoro debbano essere utilizzati in via esclusiva, senza dunque alcuna possibilità di deroga da parte dell'amministrazione penitenziaria, fatta salva la sola esclusione, prevista peraltro dalla medesima disposizione, dei soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare. La ratiodi tale eccezione è facilmente intuibile, visto che il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bisord. pen. è adottato come sistema di detenzione più restrittivo nei confronti di soggetti particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza negli istituti o per gli altri detenuti ed internati (cosiddetta "pericolosità penitenziaria") (48). Questo non significa che in capo a tale categoria di ristretti non sussista l'obbligo del lavoro, ma semplicemente che i criteri per l'assegnazione al lavoro potrebbero non essere quelli generalmente e oggettivamente previsti, ma altri rispondenti ad esigenze di disciplina e sicurezza nelle carceri, determinati pertanto anche in maniera discrezionale da parte dell'amministrazione penitenziaria (49).
I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria "devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto" (art. 25 bis, terzo comma, ord. pen.) e sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione, nella quale devono essere indicati separatamente i posti disponibili nelle lavorazioni interne, nelle lavorazioni esterne e nei servizi d'istituto. Nella tabella devono essere indicati anche i posti disponibili all'interno come lavoro a domicilio nonché le opportunità all'esterno a cui accedere tramite il beneficio dell'ammissione al lavoro all'esterno" (art. 47 decimo comma regol. penit.). Accanto alla previsione dei criteri per l'assegnazione al lavoro, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre un sistema, quale quello tabellare, tramite il quale è assicurata la trasparenza del mercato del lavoro penitenziario dal lato della domanda di lavoro e quindi è facilitata l'assegnazione razionale dei detenuti al lavoro; in passato infatti l'amministrazione penitenziaria era solita aumentare fittiziamente gli addetti ai servizi d'istituto per favorire, considerando anche le basse mercedi corrisposte, il maggior numero possibile di detenuti ed internati. Tale prassi se pur ispirata da buoni intenti, non è condivisibile se si parte dal presupposto che il lavoro penitenziario è elemento saliente del trattamento rieducativo, a patto che sia svolto in maniera produttiva e qualificante, senza risolversi al contrario in forme di assistenza (50).
Tuttavia, seppure è stata posta fine all'uso dell'espediente delle assegnazioni fittizie ai servizi domestici, per far fronte all'esiguo numero di posti di lavoro disponibili in istituto, l'amministrazione penitenziaria ha dato vita ad una nuova prassi, consistente in sistemi di rotazione al lavoro tramite l'istituto del cosiddetto "part-time verticale" (51), tramite il quale più detenuti si alternano nello stesso posto di lavoro per periodi di tempo determinati e in genere piuttosto brevi (52). Ai fini della dimostrazione di tale affermazione, consideriamo i dati raccolti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'anno 2003. Alla data del 14 novembre 2003 a livello nazionale generale, risultavano impiegati in un'attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria 11.596 detenuti, fra costoro 10.673 erano addetti ai servizi d'istituto, 535 alle lavorazioni industriali e 388 alle attività agricole (53). Ancora i detenuti lavoranti con orario di lavoro ridotto risultavano 6.279 nei servizi d'istituto, 283 nelle lavorazioni industriali e 21 nelle attività agricole, per un totale di 6.583 detenuti impiegati con contratto di lavoro part-time. Dai pochissimi dati sin qui raccolti emerge con estrema evidenza come più della metà dei detenuti lavoranti sia ammessa al lavoro proprio in virtù dello strumento dell'orario ridotto, altrimenti verosimilmente il numero dei soggetti in esecuzione pena ammessi allo svolgimento di un'attività lavorativa sarebbe notevolmente più contenuto.
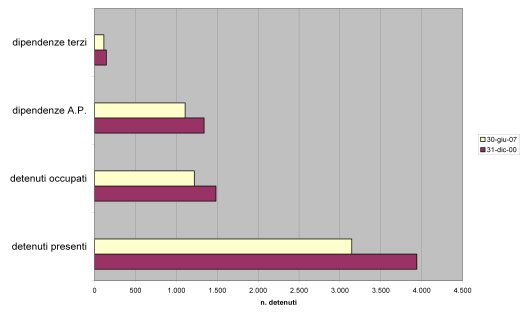
Sulla base delle tabelle indicative dei posti di lavoro disponibili e dei criteri di cui al sesto comma dell'art. 20 ord. pen., si può procedere all'assegnazione di detenuti ed internati al lavoro tramite la redazione di due graduatorie fissate in altrettante liste "delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere" (cosiddette "liste lavoranti", ex art. 20 settimo comma). E' stato previsto dunque, un sistema di pubblicità tale da poter garantire la verifica della corrispondenza delle modalità di redazione delle liste ai criteri prefissati dal legislatore. In particolare il responsabile del procedimento di ammissione al lavoro, e quindi di redazione delle liste lavoranti, sembra essere, alla luce dell'art. 49 secondo comma del regolamento penitenziario, il direttore dell'istituto, il quale ha il compito di assicurare "imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro, avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento" (54). Ai fini della redazione della graduatoria è stata prevista l'istituzione di una "commissione" composta dal direttore, da un ispettore o sovrintendente di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti questi ultimi due all'interno delle categorie di appartenenza, da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante del centro per l'impiego territorialmente competente (55) e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali (art. 20 ottavo comma ord. pen.). Alla commissione inoltre partecipa "senza potere deliberativo" un rappresentante dei detenuti e degli internati, "designato per sorteggio" (nono comma). In tal modo il legislatore ha voluto assicurare che la formazione delle graduatorie avvenga per opera di una commissione in cui siano pariteticamente rappresentati tutti i gruppi di interesse, con notevole apertura rispetto al passato alle organizzazioni sindacali, quali garanti dei diritti di tutti i lavoratori, dunque anche dei lavoratori-detenuti. È inoltre previsto che per ogni membro della commissione debba essere designato un supplente per il caso di assenza o impossibilità a parteciparvi.
Infine per tutto quanto non espressamente previsto dall'ordinamento penitenziario e in particolare dall'art. 20, è fatto rimando alla disciplina generale sul collocamento (dodicesimo comma). Al riguardo viene in rilievo l'art. 19 della legge n. 56 del 1987 che si occupa specificamente del collocamento dei detenuti e degli internati, prevedendo la possibilità per tali soggetti di iscriversi nelle liste di collocamento o di permanervi, nel caso fossero già iscritti, nonostante la detenzione. Particolarmente innovativa è la disciplina sull'iscrizione nelle liste di collocamento durante lo stato di detenzione, infatti prima dell'entrata in vigore della legge di cui si tratta, lo stato detentivo era comunemente considerato condizione ostativa all'iscrizione dal momento che le commissioni circoscrizionali per l'impiego richiedevano per poterla effettuare, la presenza fisica del lavoratore disoccupato. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 invece, non solo la richiesta d'iscrizione è ammissibile nonostante provenga dal carcere, ma è la stessa direzione dell'istituto che su richiesta dell'interessato si preoccupa di segnalare periodicamente alla commissione circoscrizionale per l'impiego (rectiusal centro per l'impiego) lo stato di detenzione o di internamento (56).
Nonostante i buoni propositi legislativi, la previsione di cui all'art. 20 ottavo comma è rimasta del tutto inattuata, dal momento che la commissione ivi disciplinata non è mai stata formata e resa operativa, cosicché la redazione delle graduatorie dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro, è gestita esclusivamente dall'amministrazione penitenziaria, in moltissimi casi seguendo criteri altamente discrezionali.
Un problema ancora irrisolto che emerge al riguardo è quello relativo all'individuazione delle possibilità e degli strumenti di tutela concessi al detenuto per far valere l'inadempimento da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'obbligo di tenere conto nell'assegnazione al lavoro esclusivamente dei criteri di cui all'art. 20 sesto comma ord. pen., ovvero nelle ipotesi in cui l'amministrazione penitenziaria nel disporre le priorità per l'ammissione al lavoro, proceda osservando criteri del tutto discrezionali o addirittura senza redigere le liste lavoranti. Infatti dal momento che il legislatore ha previsto dettagliatamente i criteri a cui l'amministrazione penitenziaria deve attenersi "esclusivamente" per la redazione delle liste lavoranti, si può concludere che in tal caso sussiste un 'potere vincolato' della P.A. cui corrisponderebbe secondo la teoria generale in materia, un diritto della controparte, nel caso di specie del detenuto e dell'internato. In linea teorica sarebbe possibile il ricorso al giudice ordinario per ottenere adeguata tutela dei diritti che si affermano violati dalla P.A. Invece nel caso di specie, stante la particolarità del rapporto che lega il soggetto leso (il detenuto) e la P.A. che si pretende responsabile (l'amministrazione penitenziaria), caratterizzato dall'indubbia supremazia autoritativa dell'una nei confronti dell'altro, e giustificato dalla finalizzazione delle funzioni e dei poteri dell'amministrazione penitenziaria all'esecuzione della pena, si deve escludere il ricorso al giudice dei diritti (57). Parimenti, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 2006, si deve rinunciare a qualsiasi attribuzione di giurisdizione in materia al giudice del lavoro; infatti senza voler in questa sede approfondire l'argomento, di cui si tratterà ampiamente nel prosieguo, la questione delle liste lavoranti è antecedente all'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro, dunque non essendovi controversia di lavoro in senso proprio, cui pare riferirsi la sentenza del 2006, pare inammissibile il ricorso al giudice del lavoro.
Questo tuttavia non esclude la tutela giurisdizionale tout court, ma lascerebbe come unica possibilità di contestazione dell'operato dell'amministrazione penitenziaria da parte del detenuto, il reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 69 sesto comma, ord. pen., che innesca un procedimento il cui esito è un'ordinanza impugnabile soltanto per cassazione. Il nodo interpretativo principale sta proprio nella vincolatività di tale ordinanza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. Ma seppure si ritenesse, come del resto si concluderà in seguito, che l'ordinanza del magistrato di sorveglianza in materia fosse vincolante per l'amministrazione penitenziaria, rimarrebbe comunque irrisolto il quomodo, ovvero come costringere l'amministrazione ad ottemperare. Al riguardo è stato sostenuto che il magistrato di sorveglianza ha soltanto una funzione di impulso, dal momento che non ha altro strumento per garantire l'osservanza della propria ordinanza se non le vie 'diplomatiche' della sollecitazione al direttore dell'istituto e laddove questi protragga l'inadempimento, della segnalazione al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) o ancora più in alto gerarchicamente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) (58).
Nell'ambito della disciplina in materia di assegnazione al lavoro, resta da esaminare l'ipotesi in cui il detenuto o l'internato non voglia beneficiare dell'opportunità lavorativa offertagli, nonostante l'obbligo che grava nei suoi confronti. In tal caso il legislatore penitenziario ha previsto l'esclusione dal lavoro "adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro" (art. 53 regol. penit.). Il presupposto per l'esclusione dal lavoro del detenuto o dell'internato è "un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi". Particolarmente significativo è la previsione secondo cui il provvedimento di esclusione debba essere adottato dal direttore dell'istituto ma a seguito del parere del GOT, considerata la gravità dello stesso e sul presupposto che il lavoro è elemento principale del trattamento penitenziario. Al contrario è da rilevare l'insufficienza in punto di garanzia del pieno contraddittorio, della disposizione che prevede soltanto come eventuale il parere del datore di lavoro e del responsabile delle attività, essendo questi in realtà le figure che concretamente riescono a valutare meglio la disponibilità del detenuto al lavoro (59).
5. La natura giuridica del rapporto di lavoro penitenziario
Un'annosa e accesa querelledottrinale e giurisprudenziale ha riguardato il tema della natura giuridica da attribuire al lavoro penitenziario, ovvero il problema di stabilire se si tratta di rapporto di lavoro di diritto pubblico o al contrario di diritto privato. Il nodo interpretativo è sorto a causa della configurazione del lavoro in carcere come obbligo gravante sul detenuto.
Una parte della dottrina, fino ad alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale, avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che essendo il lavoro penitenziario adempimento di un obbligo legalmente imposto, non può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, di diritto privato, ma deve invece qualificarsi come prestazione di diritto pubblico. La principale conseguenza di tale soluzione interpretativa è l'esclusione dell'applicazione o estensione automatica della disciplina e della legislazione protettiva in materia di lavoro subordinato al lavoro penitenziario. Cosicché viene ad essere pienamente giustificata una differenziazione fra lavoratori 'liberi' e lavoratori 'detenuti' in punto di tutele e soprattutto di retribuzione; essendo infatti gli ultimi sottoposti ad un obbligo, la mercede da questi percepita non può assumere la configurazione di retribuzione, ma è considerata una forma di corrispettivo sui generis (60).
Altra parte della dottrina ha invece sostenuto che sia necessario innanzitutto distinguere fra il lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e il lavoro alle dipendenze di terzi sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Infatti non sembra assolutamente ragionevole considerare il rapporto di lavoro alle dipendenze di un'impresa privata, svolto per esempio in regime di semilibertà, come prestazione di diritto pubblico, introducendo pertanto la possibilità di un'ingiusta differenziazione in punto di tutele fra i dipendenti della medesima impresa, solo sul presupposto che gli uni sono in esecuzione pena e gli altri sono invece 'onesti cittadini'. Una siffatta impostazione avrebbe il rischio di favorire in maniera distorta l'assunzione di detenuti ed internati in quanto meno rigorosi sarebbero nei loro confronti i doveri e gli oneri del datore di lavoro, a tutto discapito della finalità rieducativa della pena, che si è detto essere raggiungibile solo se il lavoro si configura come attività rispettosa della dignità della persona umana e che non dia al detenuto la sensazione di essere sfruttato. Quindi laddove si tratti di attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi, sia in carcere che extra moenia, è innegabile che si tratta di un comune rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ovvero di diritto privato, cui si applica pertanto integralmente la disciplina protettiva del lavoro (61), con l'unica differenza ammissibile di ritenere giustificati tutti quei limiti ai diritti dei lavoratori che siano inevitabilmente conseguenti allo stato detentivo.
Una volta escluso che il lavoro penitenziario svolto alle dipendenze di terzi sia differenziabile dal comune rapporto di lavoro, resta da risolvere la questione relativa alla configurazione giuridica del rapporto di lavoro che intercorre fra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria. Al riguardo, occorre fare innanzitutto accenno alla previsione della carta costituzionale secondo cui "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35), che già di per sé comporterebbe un'estensione della disciplina protettiva del lavoro anche a quello svolto in esecuzione pena, a meno di non voler ritenere che non si tratti di attività lavorativa vera e propria, conclusione che sarebbe a sua volta incostituzionale violando sia il divieto di "trattamenti contrari al senso di umanità", divenendo l'attività svolta in sostanza una forma di lavoro forzato, sia la previsione per cui "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27), non essendo il lavoro così configurato, come si è avuto più volte occasione di sottolineare, minimante rieducativo (62).
Ma al di là dell'appiglio alla carta costituzionale, le argomentazioni principali a sostegno della natura privatistica del lavoro penitenziario, sostenute dalla dottrina in esame sono state essenzialmente di due tipi, da una parte si è affermato che l'obbligo legale all'origine dello svolgimento dell'attività lavorativa non esclude che si tratti di comune rapporto di lavoro subordinato, sussistendo altre ipotesi nel nostro ordinamento giuridico in cui il rapporto di lavoro si instaura non a seguito di contratto, ma deriva direttamente dalla legge (63), e tuttavia non si dubita minimamente che si tratti di un comune rapporto di lavoro subordinato a cui si applica la disciplina protettiva del lavoro.
Altra argomentazione sostenuta di frequente è che la sussistenza di un obbligo legale all'origine del rapporto di lavoro non esclude di per sé l'espressione di volontà a contrarre da parte del detenuto. Il presupposto logico di tale conclusione è che nemo cogit facere potest, per cui nonostante le sanzioni disciplinari, se il detenuto non volesse adempiere l'obbligo, non vi sarebbe alcun strumento in grado di rendere tale prestazione coercibile (64). Quindi l'adempimento dell'obbligo di svolgere un'attività lavorativa dovrebbe essere considerato come espressione tacita della volontà di instaurare un rapporto di lavoro, ovvero di concludere un contratto di lavoro subordinato. A favore della tesi sostenitrice della genesi contrattuale del rapporto di lavoro subordinato si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che "al fine della qualificazione di un rapporto di lavoro occorre aver riguardo non solo al momento attuativo ma anche a quello negoziale costitutivo", dando rilevanza alla volontà delle parti, la quale ben può esprimersi in un "contratto di lavoro che si differenzi da quello tipico disciplinato dagli artt. 2094 e ss. c.c." (65).
Inoltre a sostegno di questa tesi, è stato evidenziato come lo stesso legislatore preveda la possibilità per gli imputati di chiedere di essere ammessi al lavoro; in tal caso nessuno dubiterebbe che si tratta di normale rapporto di lavoro subordinato, non sussistendo in capo a tali soggetti alcun obbligo. Partendo da questo dato, non si spiegherebbe la distinzione fra il lavoro degli imputati qualificato pacificamente come prestazione di diritto privato, e il lavoro dei condannati e degli internati, invece, qualificabile come prestazione di diritto pubblico, in niente differenziandosi queste due categorie di 'ristretti' se non nel sopraggiungere della condanna definitiva, che non dovrebbe modificare però in nulla il rapporto di lavoro in senso stretto (66).
Entrambe le argomentazioni a sostegno della natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sembrano plausibili, però come è stato osservato, delle due l'una: o si prescinde dalla necessità del contratto per l'instaurazione del rapporto di lavoro, oppure si amplia la nozione di volontà di concludere un contratto ricomprendendovi tutte le possibili forme di espressione del consenso. Quindi partendo dal presupposto che la dottrina maggioritaria sembra ormai sostenere che il lavoro penitenziario configuri un'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (67), occorre stabilire quale sia fra le due prospettate, l'argomentazione maggiormente conforme al dato normativo.
L'art. 2094 nel prevedere le caratteristiche salienti del rapporto di lavoro subordinato, fa solo riferimento al "prestatore di lavoro" il quale si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore", senza fare minimante cenno al contratto di lavoro (68). Altra disposizione risolutiva ai nostri fini è l'art. 2126 il quale prevede che "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. [.....] Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione". Tale disposizione dunque sancisce l'irrilevanza del contratto rispetto al rapporto in ipotesi in cui se si dovesse dare preminenza al contratto sarebbe pregiudicato il prestatore di lavoro, in punto di tutele e soprattutto di diritto alla retribuzione. Al riguardo è stato sostenuto che "questa norma riconosce nell'esecuzione del rapporto la fonte effettiva, e vera, dei diritti del lavoratore, in particolare dei diritti retributivi" (69). D'altra parte si deve rilevare come il contratto di lavoro, già nella Relazione al progetto preliminare del libro delle obbligazioni "considera la fonte contrattuale una delle fonti del rapporto e non la sola fonte. L'attuazione di fatto del rapporto stesso può quindi condurre il datore di lavoro agli stessi obblighi che egli avrebbe di fronte ad una prestazione che fosse adempimento di un contratto" (70).
Senza inoltrarsi ulteriormente in un dibattito ancora aperto fra i giuslavoristi, ai nostri fini, con riferimento al lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, si può concludere che nonostante il rapporto tragga origine da un obbligo legale e non da un contratto, vista la disciplina civilistica e vista la finalità di assimilare quanto più possibile il lavoro penitenziario al lavoro 'libero', si può sostenere che il lavoro penitenziario è una delle tante forme in cui può esplicarsi il lavoro subordinato (art. 35 Cost.), costituendo più esattamente uno dei cosiddetti "rapporti speciali" di lavoro che si caratterizzano per la loro collocazione in ordinamenti dotati di propria autonomia e per l'inserimento di elementi pubblicistici nella loro disciplina (71), dunque rapporti di lavoro cui si applica la disciplina protettiva generalmente prevista, fatte salve le deroghe introdotte dallo stesso legislatore penitenziario per le particolari finalità e il singolare contesto che caratterizzano tali attività lavorative. D'altra parte alla stessa conclusione è pervenuta la giurisprudenza più recente sostenendo che "l'attività di lavoro svolta dal condannato all'interno della struttura carceraria, parimenti alle altre che il detenuto svolge alle dipendenze di terzi od in regime di semilibertà, è da qualificarsi come inerente ad un rapporto di lavoro subordinato" (72).
6. I diritti del lavoratore detenuto e la loro tutela
Prima di addentrarsi nella disamina della normativa penitenziaria in materia di diritti dei lavoratori detenuti, è opportuno trarre le fila del discorso sin qui svolto. Si è detto che il lavoro penitenziario è elemento principale del trattamento rieducativo, a tal fine non può avere carattere affittivo, deve essere remunerato e deve essere organizzato in modo da riflettere il lavoro nella "società libera". Nonostante poi, il lavoro penitenziario costituisca un obbligo per il detenuto, si è concluso che il rapporto di lavoro penitenziario, sia alle dipendenze di terzi che alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, costituisca un'ipotesi di rapporto "speciale" di lavoro subordinato, al quale pertanto deve applicarsi la disciplina protettiva del lavoro.
Sul presupposto di tali conclusioni, si potrebbe sostenere che i lavoratori detenuti abbiano e possano vantare tout courtgli stessi diritti garantiti ai lavoratori liberi. Anche il dettato legislativo sembrerebbe del resto avallare tale determinazione laddove rimanda in punto di limiti massimi della giornata lavorativa, diritto al riposto festivo e tutela assicurativa e previdenziale, alle "leggi vigenti in materia di lavoro" (art. 20 diciassettesimo comma ord. pen.). Tuttavia si devono pur sempre tenere a mente le particolari condizioni in cui tale attività lavorativa si svolge, per cui prima di arrivare a conclusioni che in situazioni "normali" parrebbero ovvie, è bene valutare come possono o potrebbero atteggiarsi i diritti tipici e fondamentali dei lavoratori nel caso in cui il lavoro sia svolto in esecuzione pena, e dunque risenta indubbiamente delle restrizioni e dei limiti che la detenzione impone. D'altra parte lo stesso ordinamento penitenziario in altre disposizioni sembra smentire un'interpretazione favorevole al rinvio generalizzato alla disciplina protettiva del lavoro, si pensi per riportare soltanto un esempio, alle norme in materia di remunerazione che introducono, al contrario, una notevole differenziazione rispetto al lavoro libero. Sembra pertanto indispensabile procedere ad un'analisi particolareggiata almeno dei diritti salienti del lavoratore detenuto. Infatti fra la tesi restrittiva basata sulla considerazione che il legislatore ubi voluit dixit, che dunque esclude l'applicabilità della disciplina protettiva del lavoro se non per quanto espressamente previsto dall'ordinamento penitenziario, e l'opposta tesi caratterizzata da maggior apertura, che invece conclude per un'estensione de planodelle norme a tutela del lavoratore, sembra preferibile attestarsi su una posizione intermedia che fonda la soluzione di tale querellesu un giudizio di compatibilità della disciplina ordinaria con le peculiari modalità del lavoro carcerario (73). Al riguardo occorre tenere a mente quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26 del 1999: "l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità -nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina- non possono mai consistere in trattamenti penitenziari che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà" (74).
6.1 L'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali
Con riferimento ai diritti del lavoratore detenuto inerenti alla durata della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, della settimana e dell'anno, viene in aiuto la disposizione di cui all'art. 20 diciassettesimo comma per cui "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia e, alla stregua di tali leggi, è garantito il riposo festivo". Dunque rimandando il legislatore alla disciplina generale in materia di lavoro, si dovranno ritenere applicabili al lavoro carcerario le disposizioni che regolano il lavoro libero.
Innanzitutto si deve premettere come la stessa Carta Costituzionale imponga la determinazione ex legedi un limite massimo di ore giornaliere di lavoro, infatti l'art. 36 al secondo comma dispone che "la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge". Al riguardo rileva l'art. 2107 c.c. il quale rimanda alle leggi speciali per la fissazione dei limiti della durata giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa. La prima regolamentazione in materia si è avuta con il R.D.L. n. 692 del 1923 il quale ha fissato il limite della durata giornaliera del lavoro in otto ore e quello della durata settimanale in quarantotto ore. Questo ultimo limite massimo è stato poi ridotto dalla l. 196 del 1993 (cosiddetto "pacchetto Treu") a quaranta ore settimanali (75), oltre le quali si applica senza dubbio la disciplina relativa al lavoro straordinario.
Per quanto riguarda i riposi dall'attività lavorativa, l'art. 20 fa soltanto riferimento al riposo festivo, da intendersi come riposo settimanale, "di almeno ventiquattro ore consecutive" ogni sette giorni "di regola in coincidenza con la domenica" (art. 9 d. lgs. n. 66 del 2003). Tuttavia la Costituzione prevede all'art. 36 u. c., che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Stante il silenzio del legislatore in ordine alla previsione per i detenuti lavoratori delle ferie annuali, si è aperto un dibattito in dottrina, divisa fra coloro che si dimostravano propensi ad un'applicazione della disciplina generale anche al lavoro penitenziario (76), e coloro che hanno rilevato come la lacuna dovesse essere considerata contrastante con l'art. 36 della carta costituzionale, che per l'appunto prevede per tutti i lavoratori il diritto alle ferie annuali retribuite e l'irrinunciabilità di tale diritto (77). Sul punto è intervenuta nel 2001 la Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui "non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria" infatti argomentando sul presupposto che la stessa Costituzione si impegna a tutelare il "lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35) e a garantire il diritto alle ferie annuali retribuite, ha concluso che:
"il diritto al riposo annuale integra una di quelle posizioni soggettive che non possono in alcun modo essere negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione"."La garanzia del riposo annuale imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente non consente deroghe e va perciò assicurata "ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta" (sentenza n. 189 del 1980), dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità" (78).
Lo stato detentivo non impedisce, d'altra parte, la fruizione delle ferie in quanto nella migliore delle ipotesi si potrebbe immaginare che se ne sussistono i presupposti, i lavoratori detenuti potrebbero far coincidere il periodo di ferie alla fruizione di un permesso premio, che può essere concesso per un massimo di quindici giorni ogni volta ex art. 30 ter ord. pen., oppure di una licenza ex artt. 52-53. Invece i lavoratori detenuti che non siano nei termini per usufruire di tali benefici, potrebbero dedicare il periodo di ferie ad attività sportive o ricreative, essendo le ferie comunque finalizzate alla reintegrazione delle forze psico-fisiche del lavoratore. Se invece il detenuto optasse per la rinuncia al periodo di riposo, potrebbe ritenersi legittimo, in tal caso, il diritto all'indennità sostitutiva di ferie (79).
Infine, se è vero che nel più di tutele sta il meno, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, deve ritenersi applicabile al lavoratore detenuto anche la disciplina relativa alle pause giornaliere secondo cui qualora l'orario di lavoro eccedesse il limite di sei ore "il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa [...] ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo" (art. 8 d. lgs. n. 66 del 2003).
6.2 La remunerazione del lavoratore detenuto
L'art. 20 dell'ordinamento penitenziario prevede che "il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato", evidentemente accostando quelle che devono essere le caratteristiche salienti e necessarie, una imprescindibile dall'altra, di un'attività lavorativa che sia volta alla rieducazione del detenuto, infatti se il lavoro penitenziario non fosse remunerato sarebbe difficile smentire l'affermazione per cui si tratterebbe di una modalità di esecuzione della pena volta ad aggravarne il patimento, finendo così col configurarsi come "lavoro forzato". L'art. 22 della medesima legge dispone il criterio di determinazione della remunerazione stabilendo che "le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, all'organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti di lavoro". Innanzitutto è da rilevare come il legislatore non definisca il corrispettivo per la prestazione lavorativa "retribuzione", ma impieghi un termine diverso, "mercede", quasi a voler sottolineare che esiste una differenza fra le due. In secondo luogo prevede un aggancio al cosiddetto "minimo sindacale" ma consentendo un trattamento in peiusladdove ammette che quanto corrisposto al lavoratore detenuto possa essere anche inferiore a tale minimo. La giustificazione di tale disciplina almeno sino alla riforma del 1986 era solitamente rinvenuta nella convinzione che il lavoro penitenziario fosse inferiore per qualità e quantità al lavoro libero (80).
Con riferimento alla disposizione in esame sono stati sollevati più volte dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 36 della Costituzione, secondo cui "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (81). La disciplina dettata dall'art. 22 ord. pen. seppure potrebbe essere legittima sul versante della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, di certo pone dei problemi di compatibilità con il criterio della sufficienza, data la possibilità di ridurre notevolmente il corrispettivo fino ai due terzi del minimo sindacale. La Corte costituzionale si è pronunciata con la celebre sentenza n. 1087 del 1988, dichiarando infondata la questione di illegittimità costituzionale in quanto la disparità di trattamento fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi sarebbe giustificata dalla peculiare finalità del lavoro penitenziario. Tuttavia la stessa pronuncia ammette l'operatività dei criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. per il lavoro carcerario, in quanto la remunerazione per essere legittima deve risultare conforme a tali principi; in particolare la Corte sostiene che tenendo presente la finalità rieducativa del lavoro penitenziario, non si può fissare una remunerazione "di gran lunga inferiore alla normale retribuzione, in quanto sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo a lavorare e, se lavorasse ugualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale". Nel caso contrario, ovvero nell'ipotesi di previsione di un trattamento eccessivamente inferiore rispetto a quello riservato al prestatore di lavoro libero in punto di retribuzione, "non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei su richiamati precetti costituzionali" (82).
Con riferimento a tale sentenza, è da osservare che il giudice delle leggi per arrivare alla pronuncia di infondatezza dell'illegittimità costituzionale, fa come premessa una distinzione fra i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e coloro che siano invece alle dipendenze di terzi, occupati sia in attività all'interno del carcere che all'esterno. La differenza in punto di retribuzione di cui all'art. 22 è giustificabile soltanto se si tratta di lavoro svolto per l'amministrazione penitenziaria, in caso contrario infatti si creerebbe una discriminazione inaccettabile fra i dipendenti dello stesso datore di lavoro, a tutto discapito dei lavoratori detenuti, ai quali la domanda di lavoro si rivolgerebbe per reperire "mano d'opera a basso costo" (83).
La legittimità costituzionale del trattamento retributivo dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è fondata inoltre sulla constatazione che il legislatore penitenziario ha previsto un'apposita commissione per la determinazione delle mercedi dei detenuti, composta "dal direttore generale degli istituti di previdenza e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale degli istituti di previdenza e di pena (84), da un ispettore generale degli istituti di previdenza e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro (85), da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale" (art. 22). Si è notato che in seno a tale commissione mancano dei rappresentanti dei detenuti, tuttavia si è allo stesso tempo sostenuto che l'ingresso delle rappresentanze sindacali in carcere, assicurato proprio dalla loro previsione all'interno della commissione di cui si tratta, dovrebbe favorire una maggiore tutela dei lavoratori detenuti, consentendo allo stesso tempo una maggiore parificazione del trattamento e delle condizioni lavorative di tali soggetti ai lavoratori liberi, dovendo fungere i rappresentanti sindacali per l'appunto come collegamento e avvicinamento delle due categorie -ammessa la distinzione- di lavoratori (86). D'altra parte l'attenzione ai problemi carcerari posta da gruppi di interessi esterni al carcere è auspicata dallo stesso ordinamento penitenziario laddove prevede che "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati ed istituzioni e associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa" (art. 17).
Tornando alla disciplina in materia di remunerazione del lavoratore detenuto, l'art. 22 in esame prevede inoltre che la commissione per la determinazione delle mercedi, debba anche stabilire "il trattamento economico dei tirocinanti" (comma terzo) e "il numero delle ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e le modalità di fruizione delle stesse" da parte dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro che frequentino la scuola o i corsi di formazione professionale, qualora "tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario" (ultimo comma) (87). Al riguardo è intervenuta una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la quale ha stabilito che il "monte ore" di permesso retribuito sia pari a trecento ore di assenza dal lavoro per frequentare corsi professionali o di istruzione, qualora siano tenuti negli stessi orari in cui dovrebbe essere svolta l'attività lavorativa (88). Si tratta evidentemente di disposizioni in linea con la disciplina generale in materia di lavoro, che del pari prevede il tirocinio retribuito (art. 11 l. n. 25 del 1955) e permessi retribuiti per frequentare corsi di istruzione primaria, secondaria o universitaria oppure di qualificazione professionale (art. 10 l. n. 300 del 1970, cosiddetto "statuto dei lavoratori").
L'art. 23 ord. pen. introduceva la distinzione fra mercede e remunerazione, infatti prevedeva che dalla prima, corrispondente al corrispettivo per il lavoro prestato dal detenuto, fossero sottratti i cosiddetti "tre decimi" da versare alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, istituita dall'art. 73 dello stesso ordinamento penitenziario, cosicché quanto rimaneva a seguito di tale versamento, corrispondeva a quanto effettivamente percepito dal detenuto, ovvero la remunerazione (89). A seguito però dell'abolizione della cassa cui tali somme erano destinate, si è posta una questione di legittimità costituzionale, dal momento che i prelievi siffatti andavano a finire nelle casse delle regioni e degli enti locali per soddisfare finalità ulteriori rispetto a quelle che giustificavano tali prelievi. Il problema si era posto con riferimento alle detrazioni effettuate dopo l'abrogazione della Cassa e prima dell'abrogazione delle disposizioni sui prelievi di cui all'art. 23 ad opera della legge n. 663 del 1986 (cosiddetta "legge Gozzini"). La giurisprudenza di merito maggioritaria sosteneva la legittimità di tali prelievi per il fatto che la soppressione della Cassa non avrebbe comportato automaticamente l'abolizione dei "tre decimi", in quanto alla Cassa sono stati sostituiti "i comuni ai quali sono state attribuite, nell'ambito della beneficenza pubblica, le funzioni di assistenza economica alle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto" (90). La Corte costituzionale è intervenuta sul punto disponendo la restituzione di tutti i prelievi effettuati in quel lasso di tempo, sostenendo al contrario che:
"essendosi sostituiti alla Cassa enti portatori di interessi plurimi, sono venuti meno la specifica destinazione delle trattenute di cui trattasi al soddisfacimento dei bisogni delle vittime delle azioni delittuose e il vincolo di solidarietà tra detenuti e vittime dei delitti, sicché le trattenute sono dirette a soddisfare finalità di beneficenza pubblica. E siccome il relativo onere deve gravare sull'intera collettività e non solo sui detenuti che lavorano, sussiste violazione del richiamato art. 3 della Costituzione, ponendosi un'irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detti detenuti e gli altri cittadini" (91).
Oltre al prelievo dei cosiddetti "tre decimi" oramai abrogato, dalla remunerazione dei detenuti condannati, quindi non anche degli imputati, vengono sottratte altre somme ex art. 24 ord. pen., che riproduce in parte quanto già previsto dall'art. 145 c.p., in particolare quanto dovuto a titolo di risarcimento danno e di rimborso delle spese di procedimento, nonché le somme dovute per il rimborso delle spese di mantenimento (92). La medesima disposizione prevede però che debba comunque essere riservata ai condannati "una quota pari a tre quinti" della remunerazione e che tale quota non possa essere soggetta a pignoramento o sequestro "salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti" invece può essere soggetta a "prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione" (93). Parimenti è previsto che non possano essere pignorate o sequestrate le remunerazioni degli imputati e degli internati se non per adempiere all'obbligo degli alimenti e che possano essere suscettibili di prelievo per il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione penitenziaria.
È stato osservato come la disciplina penitenziaria relativa alla sequestrabilità e pignorabilità della remunerazione dei detenuti differisca sia da quella contenuta nel codice di procedura civile riguardante i rapporti di lavoro instaurati con privati (art. 545) che da quella prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal D.P.R. n. 180 del 1950. Le differenze principali consistono nel fatto che il sequestro o il pignoramento nelle normative da ultimo citate sono consentiti entro un certo limite e per crediti ulteriori rispetto alle obbligazioni alimentari. Invece la normativa penitenziaria consente il sequestro e il pignoramento solo per soddisfare i debiti alimentari e al contrario non prevede alcun limite, cosicché è possibile che l'intera remunerazione possa essere sequestrata o pignorata. Questo trattamento di maggiore sfavore per i detenuti lavoratori è stato giustificato sostenendo che anche se fosse ad essi sottratta l'intera remunerazione per soddisfare gli obblighi alimentari, verrebbero comunque soddisfatte nei loro confronti le esigenze alimentari, essendo questi mantenuti dallo Stato durante il periodo di detenzione, mentre gli alimenti servirebbero a garantire la sopravvivenza ai familiari del detenuto che dovrebbero invece guadagnarsi autonomamente di che vivere (94).
L'art. 56 del regolamento penitenziario stabilisce la frequenza con cui devono essere effettuati i prelievi di cui all'art. 24 ord. pen., prevedendo che questi debbano avvenire "in occasione di ogni liquidazione della remunerazione". Il medesimo articolo stabilisce la competenza del magistrato di sorveglianza per i reclami relativi all'ordine con cui vengono effettuati i prelievi per le spese di mantenimento, del procedimento penale e delle somme dovute all'amministrazione penitenziaria a titolo di risarcimento danni, nonostante la competenza in materia di attribuzione e di liquidazione delle spese di mantenimento spetti al giudice dell'esecuzione. Tale attribuzione è da considerare favorevole per il detenuto stante la maggiore facilità di stabilire contatti con il magistrato di sorveglianza (95).
L'ultimo profilo da trattare concernente la remunerazione dei detenuti riguarda il cosiddetto "peculio", istituto disciplinato dagli artt. 25 ord. pen. e 57 regol. penit., costituito dalla parte di remunerazione riservata ai detenuti, nonché dal "denaro posseduto all'atto di ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio" (96). "Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto" e produce a favore dei titolari interessi legali. Si tratta pertanto di una sorta di conto di ogni detenuto, la cui ratiosta nel divieto per i detenuti di tenere presso di sé denaro. Il peculio non può superare un certo ammontare ed è distinto in fondo vincolato e fondo disponibile, consistenti rispettivamente nelle somme che non possono essere utilizzate durante la detenzione, salvo "particolari motivi", alle quali deve essere destinata la quota di un quinto della mercede (97), e nella quota invece a disposizione del detenuto, per gli acquisti personali, o da inviare alla famiglia, o per le spese legali e così via. Questa disciplina è dettata dall'esigenza di evitare che in carcere sussistano eccessive differenze economiche, e quindi diverse condizioni di vita, fra i detenuti e consentire invece a ciascun detenuto di accantonare dei risparmi da utilizzare al momento della dimissione dall'istituto (98).
6.3 La tutela assicurativa e previdenziale
L'ordinamento penitenziario è piuttosto sbrigativo in punto di disciplina della tutela assicurativa e previdenziale da assicurare ai lavoratori detenuti, limitandosi ad enunciare nell'art. 20 diciassettesimo comma che alla stregua delle leggi vigenti in materia di lavoro debba essere "garantita la tutela assicurativa e previdenziale", precisando peraltro che questa debba del pari essere garantita ai detenuti e agli internati che frequentino corsi di formazione professionale. Vi è quindi un esplicito rimando alla disciplina generale. L'unico aspetto su cui il legislatore penitenziario si è soffermato è l'istituto degli assegni familiari, per il quale è stata introdotta un'apposita regolamentazione. Per ragioni di semplicità conviene pertanto iniziare l'esame della tutela previdenziale proprio dalla disciplina penitenziaria sugli assegni familiari.
6.3.1 Gli assegni familiari
L'art. 23 ord. pen. prevede la corresponsione ai detenuti e agli internati degli assegni familiari, ora assegno per il nucleo familiare (99), "nella misura e secondo le modalità di legge". L'assegno per il nucleo familiare assolve la duplice funzione di integrare il salario e fare fronte ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. Si tratta pertanto di una prestazione dovuta al nucleo familiare interamente considerato e commisurata al numero delle persone che ne fanno parte nonché al reddito complessivo del nucleo familiare stesso.
È assai significativo che il legislatore penitenziario abbia previsto il diritto per il lavoratore detenuto di percepire l'assegno per il nucleo familiare oltre che ai fini dell'equiparazione fra lavoro libero e lavoro penitenziario, anche e soprattutto come risorsa per la famiglia. La normativa al riguardo sembra pertanto conforme ai principi costituzionali, essendo in grado di soddisfare sia il criterio della retribuzione sufficiente per assicurare a sé e alla propria famiglia "un'esistenza libera e dignitosa" (art. 36), che la garanzia di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), sia la previsione secondo cui lo Stato si impegna in iniziative a tutela della famiglia (art. 31).
Per venire incontro alle esigenze dei familiari a carico del lavoratore detenuto, il legislatore ha previsto che gli assegni familiari siano versati "direttamente alle persone a carico", per evitare evidentemente che il detenuto o l'internato vivendo separato dalla famiglia si disinteressi trattenendo presso di sé quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare. Del pari per evitare che la non curanza del detenuto vada a discapito dei familiari, qualora questi non adempia all'onere di fornire alla direzione dell'istituto la documentazione necessaria ai fini della dimostrazione del diritto di percepire l'assegno per il nucleo familiare, "la direzione informa le persone a carico invitandole a provvedervi" (art. 55 regol. penit.). Se pure le persone a carico incontrano delle difficoltà nell'adempimento di tale onere, la stessa direzione dell'istituto provvede direttamente all'acquisizione della documentazione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.
Infine l'art. 55 regol. penit. nel ribadire che gli assegni familiari debbano essere versati direttamente alle persone a carico, prevede che qualora queste siano incapaci, l'assegno debba essere versato al legale rappresentante, applicando pertanto la disciplina civilistica in materia di incapacità. Nell'ipotesi in cui il rappresentante sia lo stesso detenuto o internato, gli assegni devono essere versati alla persona a cui l'incapace è affidato, disposizione questa che introduce una deroga necessaria per evitare l'inconveniente di cui si è detto.
Senza addentrarsi molto nella disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare (100), è sufficiente rilevare che tale prestazione è commisurata innanzitutto al numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal coniuge, che non sia legalmente separato, e dai figli ed equiparati minori di anni diciotto, ovvero senza limiti di età qualora sussista un'inabilità permanente ed assoluta che impedisca loro di provvedere a se stessi (101); secondariamente al reddito del nucleo familiare, ovvero a quanto percepito dal nucleo complessivamente, rapportato allo scaglione in cui il reddito stesso si insinua. Quindi l'importo dell'assegno è aumentato per i nuclei con figli minori in misura inversamente proporzionale al reddito familiare e direttamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo. La prestazione previdenziale per il carico di famiglia viene erogata tramite il datore di lavoro oppure direttamente dall'ente previdenziale.
6.3.2 L'indennità di disoccupazione
La disciplina relativa all'indennità di disoccupazione per detenuti ed internati è contenuta nell'art. 19 della l. n. 56 del 1987, intervenuto a porre fine ad un lungo dibattito dottrinale relativo all'interpretazione da dare all'art. 20 ord. pen. laddove prevede l'estensione della normativa generale in materia di tutela assicurativa e previdenziale anche ai lavoratori detenuti. Infatti una prima interpretazione tendeva ad escludere da tale estensione la disciplina relativa all'indennità di disoccupazione sostenendo che nel caso del detenuto, la disoccupazione è determinata da cause diverse da quelle prese in considerazione dal legislatore giuslavorista, dipendenti principalmente dallo stato di detenzione. L'art. 19 invece innovando radicalmente sul punto ha previsto che "lo stato di detenzione non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale" (terzo comma) (102). Inoltre il diritto all'indennità di disoccupazione deriva al detenuto semplicemente dal fatto di non essere occupato in alcuna attività lavorativa, indipendentemente dall'iscrizione nelle liste di collocamento, infatti sempre ai sensi dell'art. 19 i detenuti e gli internati hanno la mera facoltà, non l'obbligo di iscriversi in tali liste e comunque "finché permane lo stato di detenzione o di internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione" (secondo comma) (103).
La scarsissima giurisprudenza in materia ha escluso la possibilità che il magistrato di sorveglianza possa intervenire presso l'ufficio statale competente perché provveda alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione, "né l'amministrazione penitenziaria può essere chiamata a rispondere in caso di mancata corresponsione di detta indennità una volta che il nominativo del detenuto sia stato segnalato all'ufficio di collocamento e all'ente previdenziale" (104).
Con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina generale in materia di sicurezza sociale, per cui vale il principio della incompatibilità fra corresponsione dell'indennità di disoccupazione ed esplicazione di un'attività lavorativa, l'articolo in esame introduce la cumulabilità dell'indennità suddetta con la remunerazione fino a concorrenza della retribuzione stessa, ovvero la possibilità di sommare a quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione, un ulteriore introito a titolo di "remunerazione" per il lavoro penitenziario svolto, purché quanto "guadagnato" nel totale delle due voci non superi la somma prevista come retribuzione in astratto dal contratto collettivo nazionale di categoria. Questa eccezione si spiega tenendo presenti le particolari condizioni in cui il lavoratore detenuto svolge la propria attività lavorativa, infatti stante la carenza di opportunità lavorative fra cui scegliere, l'impossibilità pratica per il lavoratore di optare per l'indennità piuttosto che per lo svolgimento di un'attività lavorativa dal momento che è gravato da un obbligo in tal senso, e considerate, infine, le scarse remunerazioni dei lavoratori detenuti, la cumilabilità fra i due importi dovrebbe garantire al lavoratore detenuto di raggiungere un reddito superiore a quello che percepirebbe da disoccupato (105).
6.3.3 Il trattamento di fine rapporto
Il legislatore nel disciplinare il lavoro penitenziario non fa alcun cenno all'istituto del trattamento di fine rapporto. Parte della dottrina ha sostenuto che si tratta indubbiamente di una lacuna legislativa colmabile attraverso il richiamo alla disciplina generale in materia di retribuzione dei lavoratori subordinati, laddove l'indennità di anzianità, ora sostituita dal trattamento di fine rapporto, la cui disciplina è contenuta nell'art. 2120 c.c., è considerata pacificamente come corrispettivo dovuto dall'imprenditore per l'utilità e il profitto economico che gli deriva dalla stabilità del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa (106). Pertanto "la questione si potrebbe risolvere in sede di determinazione dei trattamenti da parte della commissione", infatti è previsto che la remunerazione dei lavoratori detenuti debba essere ragguagliata a quella dei lavoratori liberi, a tal fine non si può ignorare che "il trattamento complessivo dei lavoratori è in parte costituito da questa erogazione a fine rapporto, come una sorta di retribuzione differita" (107). Ne consegue che nonostante il silenzio legislativo, anche ai lavoratori penitenziari dovrebbe essere garantito il diritto al trattamento di fine rapporto (108).
6.3.4 Le pensioni di vecchiaia e di anzianità
Sempre partendo dal rinvio operato dal legislatore penitenziario alle leggi in materia di lavoro relative alla garanzia della tutela assicurativa e previdenziale, si deve concludere che anche i lavoratori detenuti abbiano diritto alla corresponsione delle pensioni di vecchiaia o di anzianità, laddove ne sussistano i presupposti (109). Pertanto si deve ritenere che il periodo di detenzione durante il quale il detenuto abbia svolto un'attività lavorativa possa essere pienamente computato ai fini del calcolo degli anni di contributi necessari per la fruizione della pensione. È stato rilevato al riguardo che le pratiche pensionistiche dei lavoratori reclusi sono soggette a vari inconvenienti a causa dei loro frequenti spostamenti nei vari istituti, perciò occorre rinvenire le posizioni assicurative sparse in varie sedi, con l'ulteriore difficoltà stante nel passaggio della competenza territoriale da una sede all'altra dell'INPS (110).
Del pari qualora il detenuto fruisse già prima dell'ingresso in istituto, di una pensione di anzianità o di vecchiaia, il sopraggiungere della detenzione non può essere causa di esclusione da tale corresponsione. Tale conclusione che allo stato legislativo attuale parrebbero ovvie, non lo erano prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, laddove i condannati alla pena dell'ergastolo erano privi del diritto alla pensione di vecchiaia, e i condannati alla pena della reclusione che già beneficiassero di una pensione perdevano il diritto a questa corresponsione. Solo con la legge n. 424 del 1966 sono state abrogate tutte quelle disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale, la sospensione del diritto al conseguimento e al godimento della pensione.
6.3.5 Le assicurazioni contro l'invalidità e l'inabilità, la malattia e gli infortuni sul lavoro
Con riferimento alle assicurazioni contro l'invalidità e l'inabilità non vi sono differenze peculiari fra la disciplina prevista per i lavoratori liberi e la disciplina per i lavoratori detenuti, essendo pienamente applicabile al riguardo quanto previsto in generale, visto il rinvio di cui all'art. 20 diciassettesimo comma e l'assenza di normativa speciale sul punto (111).
Invece con riferimento all'indennità di malattia e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esistono delle importanti circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che vanno ad integrare quanto già previsto dalla disciplina generalmente applicata in materia. Iniziando dall'esame della disciplina sull'indennità di malattia vengono in rilievo l'art. 2110 c.c., che prevede la corresponsione della retribuzione o di un'indennità al prestatore di lavoro in caso di malattia, e le circolari D.A.P. 2 ottobre 2000, n. 574810/10 e 15 gennaio 2001 n. 497135/10, entrambe rubricate "indennità di malattia ai detenuti lavoranti per i primi tre giorni" le quali prevedono la necessità di adeguarsi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ponendo l'obbligo all'amministrazione penitenziaria di corrispondere tale indennità per i primi tre giorni di malattia (cosiddetto "periodo di carenza") nella misura pari al 50% di "quella pagata dall'INPS a decorrere dal quarto giorno di assenza per malattia" (112).
Per quanto riguarda invece la tutela contro gli infortuni sul lavoro, si deve innanzitutto premettere che oltre a disciplinare il profilo delle indennità, e dunque le conseguenze economiche nei confronti del lavoratore che abbia subito un infortunio, il legislatore si è preoccupato di introdurre una normativa volta ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. L'art. 2087 c.c. obbliga l'imprenditore "ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori", mentre l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), prevede il diritto per i lavoratori di esercitare mediante proprie rappresentanze il controllo sull'applicazione in azienda delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Orbene considerando complessivamente l'assetto del lavoro carcerario, e in particolare l'ipotesi in cui entro l'istituto vengano impiantate delle lavorazioni su base industriale, non emerge alcuna ragione sulla cui base poter escludere l'obbligo per il datore di lavoro, sia esso un privato ovvero l'amministrazione penitenziaria, di osservare le norme suddette in materia di protezione della salute fisica e morale dei lavoratori detenuti. Più specificamente il datore di lavoro dovrà adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, recentemente modificato dalla legge delega n. 123 del 3 agosto 2007, consistenti essenzialmente nella valutazione dei rischi e nell'adozione di un piano di sicurezza ambientale per ridurli, se non sia possibile eliminarli del tutto, e soprattutto nel dovere di informazione e formazione dei prestatori di lavoro (113).
La normativa invece in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è contenuta nel d. lgs. n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il quale esplicitamente prevede che la disciplina da esso dettata si applichi ai detenuti che svolgano una delle attività "pericolose" nel decreto stesso elencate (artt. 1, 3 e 4), ma che siano alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (art. 4 n. 9). In questo caso i detenuti sono regolarmente assicurati presso l'INAIL per "tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni" (114) (art. 2). Invece sono esclusi dalla copertura assicurativa suddetta, ex art 127 n. 3 del testo unico in esame, i detenuti che siano impiegati in attività lavorative alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (115). Tuttavia la medesima copertura assicurativa è stata assicurata a tali detenuti lavoranti da una serie di convenzioni fra il Ministero della giustizia e l'INAIL, di cui la più importante è contenuta nella circolare INAIL n. 84 del 1964 e nella circolare del Ministero della Giustizia n. 1433/3891 del 26 giugno 1964, secondo le quali è la stessa amministrazione penitenziaria a provvedere alla tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, rimborsando trimestralmente l'INAIL che provvede immediatamente alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e alla rendita per l'invalidità permanente, derivanti per l'appunto dall'infortunio o dalla malattia professionale.
In dottrina si è avuta una lunga querelle relativa alla determinazione della base retributiva cui fare riferimento per la quantificazione dell'indennità o della rendita a seguito dell'infortunio o della malattia professionale. Infatti da una parte si sosteneva di dover prendere in considerazione la mercede, e dunque il corrispettivo dovuto al detenuto lavoratore al lordo di tutti i prelievi e le trattenute, dall'altra invece si propendeva per il fare riferimento alla remunerazione, ovvero al corrispettivo effettivamente percepito. Tuttavia se il criterio da applicare fosse stato questo ultimo, sarebbe stato chiaro che l'indennità e la rendita avrebbero avuto un importo piuttosto irrisorio, essendo fissate in percentuale rispetto alla base retributiva. Perciò sul punto sono intervenuti il Ministero della Giustizia e il Ministero del lavoro stipulando un'apposita convenzione contenuta nel D.M. del Ministero del lavoro del 30 agosto 1969, con la quale sono state fissate le cosiddette "retribuzioni convenzionali giornaliere", quali base al fine del calcolo dell'indennità (116).
6.4 I diritti sindacali
In dottrina sussistono molte perplessità sul riconoscimento generalizzato ai lavoratori detenuti dei diritti sindacali, infatti da una parte si sostiene che lo stato detentivo impedisce l'esercizio di tali diritti, dall'altra invece si afferma che anche sul versante dei diritti sindacali vi deve essere piena equiparazione fra lavoratori liberi e lavoratori detenuti. La disciplina penitenziaria in materia di lavoro non aiuta molto alla risoluzione di tale dibattito, alcuni spunti possono essere tratti dalla previsione della partecipazione di rappresentanti delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale nella commissione per la determinazione della mercede (art. 20 ottavo comma ord. pen.), e dalla previsione contenuta nell'art. 48 regol. penit., undicesimo comma, secondo cui "i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà personale". Dalle disposizioni richiamate si possono trarre rispettivamente le seguenti conclusioni: da una parte il legislatore ha voluto fare entrare le rappresentanze sindacali all'interno del carcere, in modo da favorire la rappresentanza dei detenuti seppure nel solo ambito delle rivendicazioni in materia di retribuzione; dall'altro lato ha voluto precisare che i detenuti che lavorano all'esterno non possono essere discriminati in punto di riconoscimento di diritti per il solo status detentivo, al contrario se devono sussistere delle differenze con i lavoratori liberi queste devono essere giustificate esclusivamente per ragioni attinenti strettamente agli obblighi derivanti dalla detenzione (117).
Quindi sembra opportuno distinguere le due differenti ipotesi dei detenuti che svolgono un'attività lavorativa all'esterno del carcere, per i quali può essere pacificamente sostenuto il pieno riconoscimento di tutti i diritti sindacali, sempre tenendo presenti le limitazioni che conseguono alla detenzione, e i detenuti che lavorano all'interno dell'istituto, siano essi alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria che di terzi. In questo ultimo caso la dottrina maggioritaria sembra orientata a riconoscere ai detenuti lavoranti i diritti sindacali proprio "per non provocare il taglio netto fra il carcere e la società" (118). In senso contrario è stato sostenuto che dentro il carcere non vi sarebbe spazio per le attività sindacali dal momento che la vita dell'istituto è cadenzata da uno schema organizzativo predeterminato che non lascerebbe spazio ad iniziative di tipo partecipativo, e inoltre queste sarebbero irrealizzabili se non a pena di recare pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'istituto penitenziario (119).
La dottrina maggioritaria invece, ritiene pienamente riconoscibili ai detenuti il diritto di associazione sindacale (art. 14 st. lav. (120)), di assemblea (art. 20 st. lav.) e il diritto di sciopero (art. 40 Cost.). Infatti per quanto riguarda il primo diritto citato, non sembra ravvisabile nella restrizione della libertà personale alcuna giustificazione che possa impedire al detenuto di iscriversi ad un'associazione sindacale. Il problema per lo più sorgerà per la stessa organizzazione sindacale cui il detenuto ha fatto richiesta, che dovrà valutare la condizione del lavoratore in questione e la conformità al proprio statuto o atto costitutivo, in quanto talvolta questi impongono vincoli all'accettazione della domanda quali l'incensuratezza o la generica buona condotta morale e civile.
Per quanto riguarda il diritto di assemblea non vi sono limiti insormontabili al suo riconoscimento ai detenuti, si tratta semplicemente di rendere compatibile il suo esercizio con le esigenze di sicurezza all'interno dell'istituto. Del resto spesso la contrattazione collettiva e quella a livello aziendale prevedono la possibilità di riunione durante l'orario di lavoro (121), il che significa che l'amministrazione penitenziaria non dovrà impiegare maggiori risorse per assicurare la sicurezza rispetto a quelle già impiegate per vigilare i detenuti lavoranti.
Infine, la dottrina maggioritaria sostiene che non sussiste alcuna incompatibilità fra il riconoscimento del diritto di sciopero e lo stato detentivo. Per di più il diritto in questione è costituzionalmente garantito pertanto non potrebbe essere negato neppure ai detenuti che lavorano all'interno dello stabilimento penitenziario (122). Questo è indubbiamente vero laddove il detenuto sia impiegato nelle lavorazioni istituite dall'amministrazione penitenziaria o da privati, mentre è più difficile da realizzarsi qualora il lavoratore fosse addetto alle attività domestiche, per evidenti ragioni attinenti alla sopravvivenza e al regolare andamento dell'istituto stesso, che potrebbero pertanto giustificare dei limiti all'applicabilità della normativa generalmente vigente in materia (123).
6.5 La tutela dei diritti
Il dato normativo da cui partire con riferimento al problema della tutela dei diritti dei detenuti ammessi a svolgere un'attività lavorativa, è costituito dall'art. 69 sesto comma ord. pen., che consente al soggetto interessato di proporre reclamo al magistrato di sorveglianza per le questioni concernenti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento di attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali" (124). Il magistrato di sorveglianza "decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14 ter". Tale disposizione è stata così modificata dalla l. 663 del 1986, cosiddetta "legge Gozzini", la quale ha innanzitutto sostituito il provvedimento di decisione consistente in un ordine di servizio, non suscettibile di impugnazione, con il provvedimento in forma di ordinanza. Secondariamente ha previsto che il magistrato di sorveglianza debba decidere secondo il procedimento camerale delineato dall'art. 14 ter, nel quale è assicurato l'intervento del difensore del detenuto e la partecipazione dell'amministrazione penitenziaria, come datore di lavoro, sebbene soltanto attraverso la presentazione di memorie.
Ma prima di procedere all'esame dettagliato del procedimento di cui trattasi, occorre fare un breve accenno alla disciplina vigente anteriormente alla riforma del 1986. Infatti la previsione dell'ordine di servizio con cui il magistrato decideva aveva dato spunto ad un acceso dibattito dottrinale concernente la natura del procedimento decisionale e del relativo provvedimento conclusivo. Partendo dal presupposto della tassatività delle forme dei provvedimenti giurisdizionali (125), e quindi dall'esclusione degli ordini di servizio da tali tipi, nonché dalla mancata previsione di mezzi di impugnazione, si concludeva per l'attribuzione al procedimento decisionale e al relativo atto finale, l'ordine di servizio per l'appunto, natura eminentemente amministrativa (126). A sostegno di tale tesi è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale la quale ha escluso la possibilità di considerare l'attività di cui all'art. 69 sesto comma del magistrato di sorveglianza, come attività giurisdizionale, non avendo il legislatore assicurato quel minimo di garanzia che caratterizza ogni procedimento giurisdizionale consistente nella predisposizione di mezzi di difesa per le parti. Ne consegue che "il procedimento instaurato dal reclamo del detenuto in materia di lavoro non sostituisce la tutela giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti, secondo le regole della competenza ordinaria, non essendovi motivo di distinzione, a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti o internati" (127).
Dunque se in un primo momento poteva ritenersi pacifica la competenza del giudice del lavoro, ovvero del Pretore in materia di controversie di lavoro fra detenuti e datori di lavoro privati, nonché del tribunale amministrativo per le controversie fra lavoratori detenuti e amministrazione penitenziaria, in alternativa alla possibilità per il detenuto stesso di proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 69 sesto comma, le stesse conclusioni non possono più essere tratte a seguito della riforma del 1986.
Il legislatore, infatti, riformando l'art. 69 sesto comma ha inteso porre rimedio alle lacune rilevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in punto di tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori detenuti, prevedendo che il magistrato debba decidere con ordinanza, provvedimento avente sicuramente natura giurisdizionale, e a seguito di un procedimento in cui dovrebbe essere assicurata la difesa delle parti. L'art. 14 ter, cui è fatto rimando per la disciplina procedimentale, prevede che il magistrato di sorveglianza debba decidere "con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo"; "il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione possono presentare memorie". La disciplina introdotta dalla riforma di cui si tratta trova la sua ratio nella soluzione posta dal legislatore penitenziario per cui il magistrato di sorveglianza dovrebbe essere "il giudice naturale dei diritti del detenuto coinvolti nel corso e a causa o in occasione del trattamento penitenziario" (128). Pertanto sia il procedimento camerale che il relativo provvedimento finale, impugnabile tramite ricorso per cassazione, hanno piena natura giurisdizionale. Quindi con un'inversione di tendenza, la giurisprudenza di legittimità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale citata da ultimo, ha rilevato che:
"benché il lavoro carcerario, prestato dal detenuto all'interno o all'esterno dello stabilimento detentivo a favore dell'amministrazione penitenziaria oppure all'esterno a favore alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia assimilabile all'ordinario lavoro subordinato, la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie deve ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, lo svolgimento delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali, nell'ambito di una competenza di tale giudice alla quale deve riconoscersi natura giurisdizionale nel quadro della disciplina introdotta dalla riforma penitenziaria di cui alla l. n. 663 del 1986, che prevede lo svolgimento di uno speciale procedimento nel quale sono garantiti i diritti di difesa la decisione con ordinanza impugnabile per cassazione" (129).
Pertanto secondo la giurisprudenza di legittimità il procedimento di reclamo al magistrato di sorveglianza sarebbe più che sufficiente a garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva dei diritti dei lavoratori detenuti. Il procedimento di reclamo in questione essendo esperibile per tutte le controversie di lavoro in cui sia coinvolto un detenuto farebbe venire meno anche la distinzione, solitamente precisata dalla dottrina, fra attività svolte alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e attività svolte alle dipendenze di terzi datori di lavoro. Anche se al riguardo occorre precisare che a seguito della riforma sul pubblico impiego e la conseguente privatizzazione, ad opera della legge delega n. 59 del 1997 attuata con il d. lgs. n. 80 del 1998, sarebbe stata comunque superfluo tale tipo di distinzione, secondo cui per le attività svolte alle dipendenze di un'amministrazione pubblica, nel caso di specie l'amministrazione penitenziaria, sarebbe stata sussistente la giurisdizione del TAR, mentre per quelle svolte alle dipendenze di un privato, la giurisdizione sarebbe stata del giudice del lavoro, in quanto salvo casi eccezionali e molto circoscritti, tutte le controversie in materia di pubblico impiego sono oggi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (130).
La Corte di cassazione del pari, attraverso una giurisprudenza costante basata sui principi fissati dal giudice costituzionale nella sentenza su riportata, ha sostenuto che il giudice naturale per la tutela dei diritti dei detenuti lavoranti è esclusivamente il magistrato di sorveglianza. Tuttavia, come è stato frequentemente osservato, il procedimento camerale di cui all'art. 14 ter, benché assicuri i poteri di difesa alle parti e una decisione giurisdizionale impugnabile, deroga notevolmente rispetto al procedimento dinanzi al giudice del lavoro. Infatti si tratta di una procedura camerale, svolta quindi in camera di consiglio, a cui partecipano il difensore del detenuto e il pubblico ministero, mentre il diretto interessato e l'amministrazione penitenziaria possono soltanto presentare memorie. È evidente in tal caso che è assicurato un contraddittorio meramente cartolare, mentre più grave è l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un privato, il quale non avrebbe neppure la possibilità di presentare memorie, con la conseguente palese violazione nei suoi confronti del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Inoltre i reclami proposti dai detenuti per la tutela dei propri diritti in quanto lavoratori "hanno sostanzialmente natura di atti di impugnazione e pertanto possono essere proposti soltanto avverso provvedimenti ai quali l'interessato non intenda prestare acquiescenza" (131), con evidente ulteriore differenza rispetto al procedimento dinanzi al giudice del lavoro, che non è caratterizzato da tale limite e dunque assicura maggiore tutela.
Con riferimento ai dubbi, appena avanzati, di legittimità costituzionale della normativa in esame, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha escluso ogni pretesa violazione dei principi costituzionali, quali il principio di uguaglianza (art. 3), il diritto di difesa (art. 24) e il principio del contraddittorio (art. 111 secondo comma). In una pronuncia del 2001, la Corte ha escluso ogni minimo dubbio di illegittimità costituzionale del procedimento camerale di cui all'art. 69 sesto comma, sostenendo che:
"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 ord. pen. in relazione all'art. 409 c. p. c. e con riferimento all'art. 3 Cost.; infatti le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune di entrambi, non escludono la ragionevolezza della previsione di una diversa competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario, date le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività, che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena, e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale" (132)
Dunque da una parte si afferma che la tutela assicurata dal magistrato di sorveglianza sia sufficiente a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori detenuti, in quanto tutela comunque giurisdizionale, dall'altra però si giustificano limiti nella tutela stessa partendo dal presupposto, ormai considerato desueto, che il lavoro penitenziario è comunque strettamente collegato alla pena. Tale impostazione rischia di riportare in vita la concezione del lavoro carcerario come pena accessoria alla reclusione, tesi da tempo abbandonata dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza, nonché dal legislatore penitenziario. Pertanto una simile soluzione interpretativa è in evidente disarmonia con la voluntas legis per cui il lavoro penitenziario debba essere assimilato quanto più possibile al lavoro "libero", risultato che non si può verosimilmente raggiungere se si legittima una differenza sostanziale in punto di tutele (133).
Di recente è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 27 ottobre 2006, rivoluzionando l'assetto della tutela giurisdizionale del lavoratore detenuto. Infatti richiamando il valore rieducativo del lavoro penitenziario, già affermato dalla stessa corte nella sentenza n. 158 del 2001 laddove veniva enunciato che "lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario" così come previsto dallo stesso legislatore penitenziario, ha affermato che sussistono per i lavoratori detenuti dei diritti fondamentali che non possono essere annullati per il fatto stesso di trovarsi nella condizione di ristretti nella propria libertà personale. Quindi "posta l'indispensabile connessione tra riconoscimento dei diritti e possibilità di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, deve essere sempre assicurato il rispetto delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione (sentenza n. 26 del 1999)".
Da tali premesse la Corte costituzionale trae alcune importanti conclusioni, definite dalla stessa "punti fermi": la prima è la necessaria tutela dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro instauratesi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria, e "tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della propria libertà personale". Il secondo punto fermo è la possibilità che il legislatore ponga dei limiti a tali diritti quando questo sia necessario per "mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena". Il terzo punto, derivante dai primi due, è costituito dalla "illegittimità di ogni irrazionale ingiustificata discriminazione, con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini (sentenza n. 49 del 1992)".
Tenendo a mente questi "punti fermi", la Corte rileva che il procedimento camerale di cui all'art. 14 ter richiamato dall'art. 69 sesto comma per la tutela dei lavoratori detenuti, non assicura il rispetto dei diritti processuali fondamentali, e conseguentemente non garantisce l'effettività di tutela dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro. Infatti da una parte è pregiudicato il diritto al contraddittorio per il detenuto e l'amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze è svolta l'attività lavorativa, dal momento che il contraddittorio, come si è già accennato, è meramente cartolare, quindi è esclusa la possibilità di intervento diretto dell'interessato e del datore di lavoro-amministrazione penitenziaria; dall'altro lato è escluso tout court il diritto di difesa del datore di lavoro privato il quale non ha neppure il mero potere processuale di presentare memorie. Dunque secondo la Corte la procedura in esame "comprime in modo notevole le garanzie giurisdizionali essenziali riconosciute a tutti i cittadini. L'irragionevolezza di tale compressione viene in rilievo anche per l'assenza di esigenze specifiche di limitazione legate alla corretta esecuzione della pena".
Né d'altro canto, è possibile un'interpretazione adeguatrice della normativa di cui si tratta ai principi costituzionali, stante "la perentoria chiarezza della formulazione" della disposizione di cui all'art. 69 sesto comma, avallata da un'interpretazione costante da parte della Corte di cassazione a partire dal 1999, secondo la quale la competenza del magistrato di sorveglianza deve ritenersi esclusiva. Infine "è stato escluso, in particolare, un anomalo diritto di scelta del detenuto, ammesso dalla giurisprudenza precedente, tra il rito camerale, previsto dalla norma impugnata come diretta conseguenza della competenza del magistrato di sorveglianza, e il rito ordinario previsto dall'ordinamento per le controversie individuali di lavoro". Nonostante possa essere pacificamente ammessa la discrezionalità legislativa nel prevedere diversi istituti processuali nonché nell'attribuzione della competenza, rimane innegabile che la disciplina in esame detta "regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Si deve rilevare pertanto una violazione - da parte dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge n. 354 del 1975 - degli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione" che assicurano rispettivamente il diritto di difesa, il principio del contraddittorio fra le parti processuali e il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
La Corte costituzionale ha così finalmente ammesso l'illegittimità costituzionale, da tempo rilevata in dottrina (134), della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 69 sesto comma e 14 ter ord. pen., in materia di tutela dei diritti dei lavoratori detenuti. Ciò significa che fino ad un'ulteriore riforma legislativa al riguardo, deve ritenersi sussistere per le controversie in materia di lavoro penitenziario, la competenza del giudice del lavoro ordinario, dinanzi al quale si applicherà la disciplina generalmente prevista per le controversie di lavoro, di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. (135). D'altra parte sembra parimenti verosimile che in punto di attribuzione della qualifica lavorativa, di determinazione della mercede, di svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro, e di garanzia delle assicurazioni sociali, rimanga in capo al magistrato di sorveglianza la funzione di monitoraggio, attribuita generalmente a tale organo giurisdizionale dallo stesso art. 69 primo comma laddove è previsto che debba "vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena [...] con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo" di cui il lavoro, si è detto già innumerevoli volte, costituisce lo strumento principale (136).
7. L'organizzazione del lavoro penitenziario
Il lavoro penitenziario si svolge prevalentemente in tre modalità, quali il lavoro "domestico", alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e finalizzato all'espletamento dei servizi d'istituto; il lavoro su base industriale, consistente nelle cosiddette "lavorazioni", organizzate e gestite dall'amministrazione penitenziaria o da imprenditori esterni; e il lavoro al di fuori dell'istituto penitenziario, attraverso l'ammissione al beneficio del lavoro all'esterno ex art. 21 ord. pen., o alle misure alternative della semilibertà (art. 48 ord. pen.) e dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.). Secondo quanto previsto dal legislatore penitenziario, il reperimento, la ripartizione e l'organizzazione delle occasioni di lavoro spettano all'amministrazione penitenziaria (137), alla quale si affiancano al fine di facilitare l'espletamento di tali compiti le Commissioni regionali per il lavoro penitenziario (art. 25 bis ord. pen.). Tali Commissioni sono composte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, da rappresentanti locali delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, da rappresentanti della regione che operano nel settore del lavoro e della formazione professionale, nonché da un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (ora Direzione regionale del lavoro), in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'introduzione della commissione di cui si tratta, ex art. 2 del D.L. n. 187 del 14 luglio 1993, convertito nella l. n. 296 del 12 agosto 1993, recante delle modifiche al trattamento penitenziario, è stata voluta dal legislatore al fine di facilitare l'incontro fra domanda di lavoro da parte della popolazione reclusa ed offerta di lavoro, anche e soprattutto dall'esterno dell'istituto, dunque da soggetti diversi dall'amministrazione penitenziaria. La ratio di tale innovazione si percepisce chiaramente dall'intento di modificare l'assetto in precedenza vigente. Infatti prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario del 1975, era diffusa la prassi per cui l'amministrazione penitenziaria poteva appaltare il lavoro dei detenuti ad imprese esterne, in deroga al divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, con notevoli vantaggi soprattutto economici per le imprese appaltatrici, che finivano col creare delle situazioni di vero e proprio sfruttamento della manodopera penitenziaria (138). L'ordinamento penitenziario del 1975 ha cosicché posto fine a tale prassi prevedendo in capo alla sola amministrazione penitenziaria di organizzare le attività lavorative in carcere inibendo l'intervento di imprenditori esterni. Evidentemente il legislatore penitenziario era troppo fiducioso nelle capacità di buon andamento dell'amministrazione penitenziaria che ben presto si è dimostrata incapace di provvedere da sola al reperimento e all'organizzazione di attività lavorative per i detenuti. Questo ha necessitato una revisione della posizione legislativa nei confronti della penetrazione dell'imprenditoria pubblica e privata in carcere, dando luogo alla riforma del 1993 che come si è detto ha istituito le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. La presenza in tali commissioni di rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative dovrebbe pertanto essere finalizzata a facilitare il reperimento di opportunità lavorative da un lato e manodopera economicamente conveniente dall'altro (139).
Al fine di facilitare un'organizzazione del lavoro da parte dell'amministrazione penitenziaria che corrisponda a criteri di efficienza ed imparzialità, il legislatore, come si è già avuto modo di evidenziare, ha introdotto la previsione secondo cui i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione, nella quale devono essere indicati separatamente i posti disponibili nelle "lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi d'istituto" nonché i posti disponibili per il lavoro a domicilio. Nella medesima tabella devono essere inoltre specificati "i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative e i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti". La tabella di cui si tratta, che può essere "modificata secondo il variare della situazione", e il piano di lavoro (140) sono approvati dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario. Il sistema di organizzazione del lavoro così delineato, tenuto conto anche della previsione di cosiddette "liste lavoranti", ovvero di graduatorie dei detenuti ammessi al lavoro stilate sulla base dei criteri oggettivi di cui all'art. 20 sesto comma, parrebbe rispondente alle esigenze di "imparzialità e trasparenza" che il legislatore penitenziario ha posto come cardini dell'attività dell'amministrazione penitenziaria di assegnazione al lavoro, se non fosse che si tratta di un sistema non funzionante per almeno due motivi. Il primo consiste nella totale inattuazione dell'ottavo comma dell'art. 20, laddove è prevista l'istituzione di un'apposita commissione per la formazione delle graduatorie dei detenuti ammessi al lavoro. L'inattuazione della previsione legislativa è determinata dal fatto che l'assegnazione dei posti di lavoro ai detenuti è ancora percepita dalle direzioni dei vari istituti penitenziari come affare strettamente attinente al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri, cosicché continua la prassi per cui l'amministrazione penitenziaria predispone ed utilizza tale graduatoria con criteri altamente discrezionali (141). Mentre il secondo motivo può essere rinvenuto nell'eccessiva macchinosità e complessità degli organi e delle procedure previste per l'ammissione e l'organizzazione del lavoro dall'attuale ordinamento penitenziario (142).
Come è stato rilevato in dottrina, esistono poi almeno due ostacoli per così dire "congeniti" alla vita carceraria che impediscono un'organizzazione pienamente razionale del lavoro penitenziario: l'eccessiva mobilità dei detenuti, sia a causa dei trasferimenti fra i vari istituti che per ragioni strettamente giuridiche, quali quelle connesse al decorso del periodo di detenzione o di custodia cautelare; e la molteplicità di variabili che incidono sull'assegnazione dei detenuti ai vari istituti. Infatti se il lavoro fosse l'unico elemento da considerare allora si potrebbe immaginare che ogni istituto si specializzi in un tipo di lavorazioni a cui verrebbero destinati i detenuti più adatti allo svolgimento di quelle determinate attività lavorative. Invece accanto al lavoro, devono essere tenuti presenti altri criteri per la destinazione dei detenuti agli istituti carcerari, quali innanzitutto la vicinanza con la famiglia ed eventuali esigenze sanitarie connesse a particolari condizioni di salute. Quindi di fatto accade molto spesso che un detenuto che potrebbe trovare in un dato istituto un'occasione di lavoro confacente alle proprie capacità, debba invece essere destinato ad un altro carcere per soddisfare altre esigenze (143).
7.1 Le lavorazioni penitenziarie e le commesse di lavoro
L'art. 47 regol. penit. prevede che le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto possano essere "organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati", i quali nello stabilire tali linee giuda devono anche sentire le stesse direzioni degli istituti nonché la commissione regionale per il lavoro penitenziario (art. 25 bis ord. pen.). A seguito della riforma del 1993, con la quale il legislatore ha voluto far fronte all'insufficienza dell'amministrazione penitenziaria in punto di organizzazione di occasioni di lavoro per i detenuti, è possibile che la direzione tecnica delle lavorazioni venga affidata a "persone estranee all'amministrazione penitenziaria", che hanno però l'obbligo di provvedere alla formazione e alla qualificazione professionale dei detenuti, ovvero che le lavorazioni siano addirittura organizzate e gestite "da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni" (144) (art. 47). Dunque il legislatore penitenziario ha previsto tre varianti: le lavorazioni organizzate e gestite direttamente dall'amministrazione penitenziaria, ipotesi nella pratica del tutto residua e marginale vista la difficoltà oggettiva per un'amministrazione pubblica di svolgere oltre ai compiti precipui ad essa assegnati, anche attività di imprenditoria. Le lavorazioni organizzate dall'amministrazione penitenziaria e gestite da imprenditori esterni alla stessa o infine, le lavorazioni organizzate da imprese pubbliche o private nonché e soprattutto dalle cooperative sociali, le quali hanno trovato particolare successo nel campo del lavoro penitenziario per le caratteristiche che le connotano, riassumibili nello scopo cosiddetto di "mutualità esterna", ovvero di perseguimento dell'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (145).
Le lavorazioni penitenziarie consistono in un'attività di lavoro organizzata su base industriale, e diretta in particolare alla produzione delle "forniture di vestiario e di corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti" (art. 47 quarto comma). Il legislatore penitenziario ha dunque ipotizzato che negli istituti penitenziari, nei quali le lavorazioni siano esigue, queste debbano essere innanzitutto indirizzate alla produzione di coperte, vestiario e biancheria per agenti di custodia e detenuti, oppure debbano consistere in attività di falegnameria, con destinazione dei prodotti evidentemente non al mercato ma alla stessa amministrazione penitenziaria. Il ricorso per tali forniture ad imprese esterne deve essere giustificato da una "significativa convenienza economica", tenendo conto però del fatto che il lavoro penitenziario oltre che a garantire una certa produzione, seppur minima, deve essere favorito per la peculiare finalità rieducativa che lo caratterizza, cosicché laddove sia possibile devono essere preferite le forniture provenienti dalle lavorazioni penitenziarie.
La produzione ottenuta dalle lavorazioni penitenziarie è rivolta al soddisfacimento innanzitutto delle commesse dell'amministrazione penitenziaria, poi delle altre amministrazioni statali, e soltanto da ultimo, delle commesse di enti pubblici e di privati (146). Le commesse di lavoro provenienti dai privati possono essere indirizzate e accolte direttamente dalle direzioni degli istituti penitenziari, mentre tutte le altre devono essere per così dire, filtrate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Qualora le commesse non fossero sufficienti ad assorbire l'intera domanda di lavoro, allora l'amministrazione penitenziaria potrebbe organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di beni da vendere sul libero mercato (comma ottavo). Per incentivare la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie, il legislatore ha introdotto tre correttivi al libero gioco della concorrenza, cui certo i prodotti in questione non potrebbero partecipare vista l'impossibilità oggettiva di competere con la sempre maggiore specializzazione e sofisticazione delle produzioni industriali. Il primo correttivo sta nell'aver introdotto la facoltà per le amministrazioni penitenziarie di vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie "ad un prezzo pari o inferiore al loro costo", stabilendo lo stesso a seguito dell'analisi della situazione del mercato e il raffronto con i prezzi usualmente praticati per prodotti corrispondenti (art. 20 comma quattordicesimo ord. pen.). Il secondo correttivo è dato dalla possibilità di promuovere la vendita dei prodotti "mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale" (art. 20 bis ord. pen.). Infine l'ultimo accorgimento per rendere appetibili i prodotti penitenziari sul mercato è stato consentire ai privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria "di effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti". Si tratta di elementi di flessibilità nella gestione della produzione penitenziaria resi necessari per renderla competitiva e dunque collocabile sul mercato, a prescindere dalle commesse ricevute dall'amministrazione penitenziaria (147).
Inoltre il legislatore ha previsto che quando le commesse provengono da imprese esterne, queste possano anche fornire materie prime ed accessorie, attrezzature e personale tecnico, al fine evidentemente di aggiornare la produzione penitenziaria agli standard produttivi vigenti nel mercato libero. In questo caso, ovvero qualora vi sia la collaborazione nella produzione dell'imprenditore committente, si dovrà tenerne conto "al fine di determinare l'incidenza sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti" (art. 47 comma settimo regol. penit.). Proprio sulla questione del rapporto costo-prezzo del prodotto delle lavorazioni penitenziarie, in dottrina sono state avanzate delle importanti intuizioni, in quanto se è vero che il legislatore ha previsto la possibilità di vendere il prodotto ad un prezzo inferiore rispetto al suo costo, è anche vero che in tal modo non verrà soddisfatto il criterio economico della remuneratività del lavoro svolto, consistente di fatto in un guadagno. Dal momento che non è verosimilmente raggiungibile nel breve periodo l'obiettivo di eguagliare l'organizzazione ed i metodi del lavoro carcerario a quelli della società libera, vista la permanente connotazione artigianale che ha caratterizzato il primo a fronte di una sempre maggiore industrializzazione che ha riguardato il secondo, sarebbe bene che l'amministrazione penitenziaria non ragionasse secondo criteri economici, dal momento che il suo fine ultimo nell'organizzare e gestire le lavorazioni penitenziarie non è il guadagno, bensì la rieducazione e il reinserimento sociale del detenuto. Dunque per rendere competitivi e commerciabili i prodotti delle lavorazioni, è stato suggerita l'esclusione dal computo delle voci dei costi di produzione che determinano poi il prezzo finale, degli oneri contributi e previdenziali, di cui dovrebbe pertanto farsi carico la stessa amministrazione penitenziaria, senza rivalersi sul prezzo finale del prodotto. In tal modo verrebbe considerata come "costo di manodopera" soltanto la remunerazione che corrisponde alla prestazione di lavoro del detenuto. L'intuizione che ne consegue sta nel considerare il costo del lavoro penitenziario come "costo sociale", sopportato dall'intera comunità al fine di "prevenire ed arginare la devianza criminale", cosicché "il prezzo del prodotto deve essere sottratto ad ogni logica di mercato ed essere determinato, invece, come prezzo politico" (148).
L'art. 20 dell'ordinamento penitenziario prevede infine che le amministrazioni penitenziarie possano stipulare "apposite convenzioni" con imprenditori pubblici o privati o cooperative sociali "interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro" (tredicesimo comma). Tali convenzioni, attraverso le quali dunque è consentito ai soggetti della produzione esterni al carcere di farvi ingresso, consentono l'organizzazione e la gestione delle lavorazioni penitenziarie da parte di imprenditori o cooperative, al di là dell'iniziativa al riguardo dell'amministrazione penitenziaria (149). Nel caso di specie, il legislatore si è preoccupato di fissare chiaramente alcuni punti fermi al riguardo, in modo da evitare qualsiasi speculazione sul lavoro dei detenuti. Innanzitutto le convenzioni devono disciplinare l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo (art. 20); in secondo luogo è stato precisato che "i detenuti e gli internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono" per cui i datori di lavoro sono obbligati a versare alla direzione dell'istituto la "retribuzione dovuta al lavoratore" al netto delle trattenute, nonché l'importo per l'eventuale assegno per il nucleo familiare, e infine deve poter "dimostrare l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale" (art. 47 comma primo regol. penit.) (150). In tal modo il legislatore ha escluso qualsiasi dubbio in punto di equiparabilità del lavoratore detenuto in punto di diritti e tutele garantiti ex lege a qualsiasi altro prestatore di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'amministrazione penitenziaria. Non è un caso che al riguardo il legislatore abbia utilizzato l'espressione "retribuzione" piuttosto che le correnti denominazioni di remunerazione o mercede per indicare il corrispettivo dovuto ai detenuti per il lavoro prestato (151). Prima della novella del 1993 e dell'entrata in vigore dell'attuale regolamento penitenziario, una conclusione siffatta non era poi così pacifica, dal momento che sussistevano dubbi sull'applicabilità anche al lavoro penitenziario svolto alle dipendenze di terzi della disciplina in punto di mercede del detenuto di cui all'art. 22 l. 354 del 1975. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1087 del 1988 ha escluso tale interpretazione, dal momento che la riduzione della retribuzione, al di sotto dei valori minimi previsti dalla contrattazione collettiva, risulterebbe ingiustificata in presenza di un rapporto di diritto privato, quale quello che verrebbe ad instaurarsi fra detenuto ed impresa esterna, disciplinato dal diritto comune nei suoi elementi essenziali, fra cui per l'appunto la retribuzione (152).
Infine, superando un pesante ostacolo all'ingresso della realtà dell'imprenditoria in forma di cooperativa in carcere, la l. 193 del 2000 (cosiddetta "legge Smuraglia") ha novellato l'art. 20 introducendo un penultimo comma nel quale è previsto che nell'ambito del lavoro penitenziario, "per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili". L'obiettivo in generale della legge Smuraglia è proprio quello di favorire ed incentivare il lavoro dei detenuti, anche e soprattutto attraverso l'intervento e l'interesse delle cooperative sociali, data la peculiare impronta solidaristica che le connota (153).
7.2 I servizi interni
Nella maggior parte dei casi le attività lavorative offerte dall'amministrazione penitenziaria, nonché alle dipendenze di tale peculiare datore di lavoro, si concretizzano nei "servizi d'istituto", definiti anche con terminologia corrente come "attività domestiche", volendo così indicare tutte quelle attività necessarie per l'ordinario andamento dell'istituto carcerario (154). Si tratta evidentemente della modalità di organizzazione del lavoro a cui si applica senza alcuna deroga, la disciplina penitenziaristica di cui agli artt. 20 e ss. ord. pen. e 47 e ss. regol. penit. che si è già a lungo esaminata, e a cui pertanto si fa rimando.
In genere i servizi d'istituto sono gestiti "in economia", ovvero direttamente dall'amministrazione penitenziaria, la quale assume alle proprie dipendenze i detenuti applicando nella stragrande maggioranza dei casi il criterio del part-time "verticale", in modo da impiegare il maggior numero possibile di reclusi. Tuttavia l'art. 47 comma terzo regol. penit. introduce la possibilità per l'amministrazione di stipulare delle convenzioni "particolarmente con cooperative sociali" aventi per oggetto "i servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati". Anche in tale ipotesi, come del resto è previsto per il caso di stipulazione di convenzioni aventi ad oggetto le lavorazioni penitenziarie, devono essere espressamente disciplinati l'oggetto, le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'eventuale formazione e il trattamento retributivo.
La particolarità con riguardo alla disposizione concernente i servizi interni, importante da sottolineare, consiste nel fatto che il comma terzo dell'art. 47 nel prevedere la possibilità di convenzioni aventi ad oggetto i servizi interni, rinvia al primo comma, nel quale il legislatore ha avuto premura di esplicitare che "i detenuti e gli internati che prestano la loro opera" nei servizi d'istituto, invece che nelle lavorazioni nel caso di specie, "dipendono quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che li gestiscono". Peraltro, si è già messo in luce come, a scanso di equivoci, il dettato normativo parli espressamente di "retribuzione" anziché di mercede o remunerazione, così facendo venire meno qualsiasi dubbio in ordine al fatto che si tratti di un comune rapporto di lavoro di diritto privato, regolamentato secondo la disciplina giuslavoristica generalmente applicata, soprattutto in punto di diritti e tutele, a garanzia del prestatore di lavoro. Tali convenzioni sembrano di primo acchito richiamare la fattispecie di "appalto di servizi" a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per addivenire al quale deve ritenersi doveroso per l'amministrazione penitenziaria applicare la disciplina di cui alla legge n. 157 del 1995 (155), secondo la quale i servizi in questione - ristorazione, pulizia e manutenzione dei fabbricati etc.- possono essere dati in appalto ad imprese private seguendo la procedura "ad evidenza pubblica" prevista dalla medesima legge, ovvero indicendo un'asta pubblica, o una licitazione privata oppure un appalto-concorso (156) e rimanendo comunque vincolata ai limiti stabiliti nelle relative voci di bilancio. Tuttavia la procedura ad evidenza pubblica può essere evitata nell'ipotesi in cui gli importi previsti per l'espletazione di tali servizi siano inferiori alla cosiddetta "soglia comunitaria", ipotesi nella quale si potrà derogare all'obbligo della gara pubblica, per stipulare invece un'apposita "convenzione", "particolarmente con cooperative sociali" avente "ad oggetto i servizi interni" (art. 47 comma terzo regol. penit.). Pertanto lo strumento convenzionale cui fa riferimento il legislatore penitenziario rimanda ad un istituto in parte diverso dal contratto di appalto stipulato a seguito di una gara pubblica, e al contrario molto più vicino ad un contratto stipulato fra privati (157).
7.3 Le attività artigianali, intellettuali e artistiche
L'art. 20 della legge sull'ordinamento penitenziario prevede che "i detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche, possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche" (quattordicesimo comma). Di questa forma di svolgimento del lavoro penitenziario si occupa anche l'art. 51 del regolamento di attuazione il quale pare distinguere due differenti ipotesi di impegno del detenuto in tal tipo di attività: la prima è sostanzialmente qualificabile come hobby, in quanto le attività artigianali, culturali o artistiche devono essere svolte "fuori dalle ore destinate al lavoro ordinario", dunque come attività integrative dell'occupazione ordinaria (158).
La seconda ipotesi invece, è quella in cui le attività di cui si tratta vengono svolte in sostituzione alle normali occupazioni lavorative e quindi "durante le ore di lavoro". In quest'ultimo caso i detenuti e gli internati possono essere autorizzati allo svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche, ed esonerati dal lavoro ordinario "quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma della legge [contenente l'ordinamento penitenziario, NdA] e si dedichino ad esse con impegno professionale". Al riguardo è stato dotato in dottrina come la riforma penitenziaria del 1975 abbia innovato sul punto, in quanto per evitare che i detenuti chiedessero di poter dedicarsi a tal tipo di attività per sottrarsi all'obbligo del lavoro, ha sostituito il riferimento a generici "interessi" del detenuto come presupposto per l'autorizzazione e l'esonero dal lavoro ordinario, con l'aggancio ad oggettive "attitudini artigianali, intellettuali o artistiche", con la precisazione contenuta nel regolamento di attuazione che la dedizione alle attività lavorative in questione deve raggiungere livelli professionali (159). L'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche e il conseguente provvedimento di esonero sono dati dal direttore dell'istituto, sentito anche il gruppo di osservazione e trattamento.
La Corte di cassazione ha precisato che al fine di considerare tali attività come vere e proprie occupazioni lavorative è necessario un espresso provvedimento di esonero, non essendo sufficiente la mera "tolleranza" da parte dell'amministrazione penitenziaria. Nel caso in cui mancasse tale provvedimento, la conseguenza sarebbe l'interdizione al detenuto della possibilità di usufruire dello strumento di tutela di cui all'art. 69 comma sesto, che attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza di decidere sui reclami concernenti l'osservanza delle norme che disciplinano il lavoro penitenziario (160).
L'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche deve contenere l'indicazione delle prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione penitenziaria, considerando che le attività in questione sono svolte in locali messi a disposizione dall'amministrazione stessa e soltanto in casi particolari nelle celle (161). Può inoltre essere consentito "l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto" evidentemente per incentivarne la vendita e dunque consentire una vera e propria fonte di guadagno per il detenuto che si dedica a questo tipo di attività (162). In ogni caso "sull'utile finanziario" derivante dal lavoro in questione "vengono effettuati i prelievi di cui all'art. 24, primo comma, della legge", ovvero quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di giustizia. Quest'ultima previsione è volta ad evitare differenze in punto di remunerazione del lavoro dei detenuti fra quanti si dedicano alle normali attività lavorative e quanti invece sono ammessi ad esercitare attività artigianali, intellettuali o artistiche.
Una disposizione specifica concerne gli imputati, i quali non essendo sottoposti all'obbligo del lavoro, possono essere ammessi a svolgere un'attività di tal tipo anche durante il normale orario di lavoro, a prescindere da un'autorizzazione espressa.
7.4 Il lavoro a domicilio
La disciplina legislativa in materia di lavoro a domicilio "penitenziario" è contenuta negli artt. 52 regol. penit. e 19 l. n. 56 del 1987, i quali prevedono rispettivamente che tale attività lavorativa possa essere svolta "anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'art. 51 [regol. penit., NdA]" e che il datore di lavoro debba versare alla direzione dell'istituto "le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica". Dunque sostanzialmente il legislatore ha operato un rinvio alla disciplina introdotto per le attività artigianali, intellettuali o artistiche relativa all'organizzazione del lavoro, alle modalità, ai luoghi di svolgimento, agli orari di lavoro nonché all'invio all'esterno dei beni prodotti, limitandosi a precisare l'obbligo per il datore di lavoro di far pervenire la retribuzione del lavoratore detenuto alla direzione dell'istituto.
Dal momento che il lavoratore impiegato nel lavoro a domicilio si trova alle dipendenze di un soggetto diverso dall'amministrazione penitenziaria, così come avviene nel caso di detenuti impiegati in lavorazioni organizzate e gestite da imprenditori o cooperative esterne al carcere, non si dovrebbe ritenere applicabile la disciplina prevista dall'art. 22 in punto di determinazione della remunerazione, rectius retribuzione, in particolare la previsione secondo cui questa possa essere fissata in misura non inferiore di un terzo rispetto al cosiddetto "minimo sindacale". Perciò stante il silenzio del legislatore al riguardo, la dottrina ha sempre ritenuto applicabile la disciplina prevista in generale per il lavoro a domicilio di cui alla legge n. 877 del 1973, la quale prevede in particolare che la retribuzione del lavoratore a domicilio debba essere fissata "sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria" ed in mancanza da un'apposita commissione regionale (art. 8). Per tutto il resto, del pari, sembra doversi ritenere applicabile la normativa sul lavoro a domicilio che comunemente consiste nell'attività svolta "con vincolo di subordinazione" nel luogo di domicilio del lavoratore o di cui abbia la disponibilità, "utilizzando materie prime o accessorie o attrezzature proprie o dello stesso imprenditore" (art. 1 l. n. 877). Ovviamente tale disciplina sarà applicabile in quanto compatibile con le disposizioni in materia di lavoro carcerario contenute nell'ordinamento penitenziario e con le particolari modalità di svolgimento in tal caso del lavoro a domicilio stesso, essendo il soggetto non solo svincolato dal controllo del datore di lavoro, come avviene peraltro nell'ipotesi di normale lavoro a domicilio, ma in una condizione particolare quale quella detentiva e per di più in luoghi di lavoro di cui il detenuto non ha neppure la disponibilità, a differenza di quanto previsto per l'appunto in generale per il lavoro a domicilio (163).
8. La cessazione del rapporto
Il profilo del lavoro penitenziario attinente alla cessazione del rapporto di lavoro assume connotati diversi a seconda che il detenuto lavori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o viceversa alle dipendenze di imprenditori esterni. Il dato comune da cui partire è la previsione legislativa di una peculiare modalità di cessazione del rapporto quale l'esclusione del detenuto dal lavoro "adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro" sul presupposto di "un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi" (art. 53 regol. penit.).
Il rifiuto nell'adempimento dei compiti e doveri lavorativi deve essere "sostanziale", ovvero deve essere attinente ai compiti fondamentali assegnati al detenuto nello svolgimento dell'attività, dunque al nucleo essenziale delle mansioni, non ad elementi di dettaglio. Inoltre il riferimento al rifiuto nell'adempimento parrebbe corrispondere sia all'inadempimento o all'inesatto adempimento come giusta causa di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, sia al concetto giuslavoristico dell'"insubordinazione", che costituisce giustificato motivo soggettivo di licenziamento (164).
Tuttavia con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria viene in rilievo anche l'art. 77 regol. penit. il quale prevede l'irrogazione di una sanzione disciplinare al detenuto che si sia reso responsabile di "volontario inadempimento di obblighi lavorativi", per cui sembra difficile in tale rapporto distinguere il profilo strettamente attinente al rapporto di lavoro, dal profilo attinente al rapporto punitivo, che si concretizza nel caso di specie nella sottoposizione del detenuto ad una sanzione disciplinare particolarmente grave in quanto è privato della possibilità di usufruire dello strumento per eccellenza del trattamento penitenziario e della libertà di movimento, seppur minima, che il lavoro all'interno del carcere consente. Pertanto non è chiaro quando il potere di esclusione dalle attività lavorative sia esercitato da parte dell'amministrazione penitenziaria come conseguenza della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di cessazione del rapporto, quindi di licenziamento, ovvero con finalità sanzionatoria. Lo strumento di tutela al riguardo parrebbe essere il reclamo ex art. 69 ord. pen. al magistrato di sorveglianza attraverso il quale il detenuto può far valere la violazione delle norme riguardanti l'esercizio del potere disciplinare (165). Tuttavia la Corte di cassazione ha ridotto la possibilità di tutela in tal senso sostenendo che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide in ordine all'esclusione dalle attività lavorative non è suscettibile di ricorso per cassazione, "sia perché il provvedimento di esclusione non ha natura disciplinare, sia perché in ogni caso il controllo del magistrato di sorveglianza in tema di potere disciplinare ha carattere meramente formale" (166). Siffatta giurisprudenza pertanto ha di molto attenuato le possibilità di tutela dinanzi al magistrato di sorveglianza per il detenuto che sia stato raggiunto da un provvedimento di esclusione dal lavoro, che formalmente non dovrebbe avere carattere di sanzione disciplinare, ma che di fatto viene frequentemente, se non sempre, utilizzato in tal senso.
Al contrario nell'ipotesi di rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria non dovrebbe sussistere alcuna sovrapposizione fra i rispettivi poteri di allontanamento dal posto di lavoro e di irrogazione di sanzioni disciplinari come conseguenza del rapporto punitivo. L'aspetto problematico nel caso di specie consiste dunque nel coordinare la normativa penitenziaria con l'autonomia negoziale delle parti nell'ambito del rapporto di lavoro e la conseguente applicazione in punto di licenziamento della disciplina generale contenuta nella l. 604 del 1966, sussistendo in tal caso un rapporto indubbiamente privatistico (167). Possono pertanto verificarsi due casi: nel primo il recesso da parte del datore di lavoro precede il provvedimento di esclusione dal lavoro, che avverrà dunque come "conseguenza necessitata e su di un piano estraneo alla previsione di cui all'art. 53" (168). La seconda ipotesi invece si verifica laddove il provvedimento di esclusione adottato dal direttore dell'istituto penitenziario preceda il licenziamento da parte del datore di lavoro, che conseguirà evidentemente per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In tal caso il direttore dell'istituto prima di adottare il provvedimento in questione potrà sentire il parere del datore di lavoro, ma essendo tale parere semplicemente un atto procedimentale, non è assolutamente considerabile come atto di recesso, il quale dovrà essere formalizzato espressamente. In quest'ultimo caso al detenuto sono concessi due strumenti paralleli di tutela: il reclamo al magistrato di sorveglianza avverso il provvedimento di esclusione dalle attività lavorative per violazione delle norme in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari; ed eventualmente il ricorso al giudice del lavoro avverso l'atto di licenziamento per farne valere l'illegittimità, ovvero la mancanza di una giusta causa o di un giustificato motivo a fondamento dell'atto di recesso del datore di lavoro (169).
9. Il lavoro penitenziario extramurario
Accanto al lavoro svolto all'interno dell'istituto carcerario, sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria che di terzi, ai detenuti è data la possibilità di intraprendere durante l'esecuzione della pena, un'attività lavorativa all'esterno del carcere, presso datori di lavoro pubblici o privati, purché questo risponda alla finalità trattamentale e rieducativa della pena, e dunque all'obiettivo del reinserimento del detenuto entro la società. Le concrete opportunità attraverso cui l'aspirante lavoratore ristretto nella libertà personale può accedere al lavoro extra moeniaconsistono essenzialmente in due tipologie di 'apertura' del carcere alla società libera: da un lato si rinviene una particolare modalità di organizzazione del lavoro penitenziario consistente nell'ammissione al lavoro all'esterno, e dall'altro lato l'accesso ad una misura alternativa che sia finalizzata al reinserimento del detenuto attraverso il lavoro, quale la semilibertà nonché l'affidamento in prova ai servizi sociali, che può essere concessa sul presupposto della sussistenza di un'opportunità di impiego lavorativo come occasione di reinserimento sociale.
In particolare l'ammissione al lavoro all'esterno e la semilibertà sono istituti per molti versi affini, sussistendo delle differenze non tanto in punto di applicazione della disciplina giuslavoristica, quanto con riferimento alla disciplina strettamente penitenziaristica, in particolare in relazione alle modalità di accesso e fruizione degli stessi istituti. Infatti l'istituto della semilibertà è annoverato fra le misure alternative alla detenzione, mentre l'ammissione al lavoro all'esterno è stata prevista e disciplinata dal legislatore come mera modalità di organizzazione del lavoro penitenziario, dunque come mera 'alternativa' al lavoro entro l'istituto, ma non certo come 'alternativa' alla detenzione. In realtà, soprattutto a seguito della riforma introdotta dalla legge Gozzini del 1986, la configurazione dell'ammissione al lavoro all'esterno è stata sempre più avvicinata a quella della semilibertà, cosicché è facilmente sostenibile che il lavoro all'esterno si sia spostato dall'ambito delle modalità trattamentali, diverse e variabili in quanto finalizzate ad adeguare il percorso trattamentale "ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" (art. 13 ord. pen.), a quello delle misure alternative alla detenzione (170).
Prima di passare all'analisi puntuale della disciplina degli istituti in questione, occorre premettere che da un punto di vista strettamente giuslavoristico, il rapporto di lavoro che si instaura fra il detenuto e il datore di lavoro è indubbiamente un rapporto di diritto privato a cui si applica la disciplina generale in materia di lavoro subordinato, indipendentemente dal fatto che si sia instaurato in occasione dell'ammissione al lavoro all'esterno, o della semilibertà ovvero dell'affidamento in prova.
9.1 Il lavoro all'esterno
La disciplina normativa in materia di lavoro all'esterno è dettata dall'art. 21 della legge contenente l'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975) e dall'art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, cosiddetto "regolamento penitenziario" il quale contiene le disposizioni di attuazione della legge testé citata. Per cogliere l'attuale configurazione dell'istituto del lavoro all'esterno e gli aspetti innovativi della disciplina al riguardo, in particolare a seguito della riforma del 1986, è opportuno un breve excursus storico. Infatti nell'originaria formulazione, prima della legge Gozzini, lo stesso art. 21 era rubricato "modalità di lavoro" e prevedeva la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di organizzare il lavoro all'interno o all'esterno del carcere purché fosse "rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti". Dunque il lavoro all'esterno era soltanto una variante organizzativa del lavoro penitenziario, caratterizzata dal fatto di svolgersi fuori dall'istituto, con l'obbligo però della scorta, presso imprese pubbliche o private che operassero esclusivamente nei settori dell'agricoltura e dell'industria, e che fossero state ritenute idonee ai fini dell'attuazione del trattamento dall'amministrazione penitenziaria, che si faceva pertanto carico del rinvenimento delle occasioni di lavoro. Inoltre il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno era sottoposto ad un mero controllo di legittimità da parte del magistrato di sorveglianza, e per il resto era demandato esclusivamente al direttore dell'istituto penitenziario, su cui pertanto gravava interamente l'onere della valutazione dell'opportunità di permettere al detenuto di lavorare all'esterno e la conseguente responsabilità.
La configurazione dell'istituto del lavoro all'esterno cambia notevolmente a seguito della riforma apportata all'ordinamento penitenziario dalla legge n. 663 del 1986, cosiddetta "legge Gozzini", la quale ha ampliato notevolmente le possibilità di accesso al lavoro all'esterno, attraverso due accorgimenti in particolare finalizzati al superamento degli ostacoli che, vigente la precedente disciplina, creavano maggiori difficoltà all'ammissione del detenuto a tale modalità di lavoro. Da un lato sono stati aboliti i pesanti limiti all'accesso al lavoro all'esterno consistenti nel divieto per l'amministrazione penitenziaria di reperire opportunità di lavoro presso imprese del settore terziario nonché nel divieto per i detenuti di ricercare autonomamente un'occasione di lavoro. Secondariamente, a seguito della riforma, è venuto meno l'obbligo della scorta, che creava problemi sia al datore di lavoro, il quale assumendo un detenuto avrebbe visto la propria impresa "piantonata", sia alla stessa amministrazione penitenziaria, vista la penuria di agenti di custodia da destinare all'attività di scorta dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno. Dall'altro lato è stato "giurisdizionalizzato" il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno, avendo la riforma introdotto un più penetrante controllo da parte del magistrato di sorveglianza sul provvedimento del direttore dell'istituto con il quale il detenuto è autorizzato al lavoro all'esterno, così da consentire una condivisione di responsabilità che permettesse di superare la resistenza a concedere questa misura che le direzioni dell'amministrazione penitenziaria avevano dimostrato e che ne aveva comportato una sostanziale inutilizzazione (171).
La finalità sottesa alla riforma del 1986 in punto di lavoro penitenziario in generale, è stata quella di avvicinare quanto più possibile la disciplina e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa dei detenuti a quelle proprie del lavoro libero, incentivando in particolare il lavoro all'esterno dal momento che indubbiamente si tratta della modalità in cui può esplicarsi il lavoro penitenziario che assicura il minor scarto possibile con il lavoro "libero". Non è irrilevante ai fini del riadattamento sociale del detenuto il fatto che l'ammissione al lavoro all'esterno consenta un reinserimento a pieno titolo del recluso nell'attività lavorativa della società libera. Inoltre l'attenzione destata dal lavoro all'esterno è determinata anche dalla consapevolezza, avvalorata dalla prova dei fatti, dell'impossibilità di realizzare una sorta di carcere-fabbrica, in cui ad ogni detenuto venga assicurato un lavoro confacente alla propria professionalità e alle prospettive future di impiego. Questo si verifica essenzialmente a causa di due fattori: innanzitutto le difficoltà oggettive ed insormontabili insite nella struttura carceraria che impediscono una piena equiparazione al lavoro "libero", soprattutto in punto di produttività ed efficienza. In secondo luogo un'ulteriore notevole difficoltà concernente il lavoro penitenziario risiede nell'onere posto in capo all'amministrazione penitenziaria di reperire adeguate occasioni di lavoro da offrire ai detenuti all'interno del carcere dovendo così questa preoccuparsi non solo di sovrintendere all'esecuzione della pena, ma anche di svolgere un'attività di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro.
9.1.1. I presupposti e i limiti normativi per l'ammissione al lavoro all'esterno
L'ammissione al lavoro all'esterno può essere concessa sia ai detenuti che agli internati purché sussistano determinati presupposti di carattere soggettivo afferenti alla condizione giuridica del recluso, nonché di carattere oggettivo, relativi al tipo di attività lavorativa che il soggetto ammesso al lavoro all'esterno andrà a svolgere. Per quanto riguarda i presupposti per così dire soggettivi, l'istituto di cui all'art. 21 ord. pen. è rivolto non solo a detenuti ed internati già condannati ma anche agli imputati in regime di custodia cautelare in carcere (secondo comma). In questo ultimo caso non è prevista l'approvazione del magistrato di sorveglianza, così come avviene per i detenuti condannati e gli internati, ma vi deve essere l'autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria (172). Inoltre la giurisprudenza di merito ha sostenuto che l'ammissione al lavoro all'esterno sia "fruibile anche dall'imputato agli arresti domiciliari, dato che questa è una forma attenuata di detenzione che non può essere più affittiva dell'altra". In tal caso la competenza a decidere non spetta né al direttore dell'istituto né al magistrato di sorveglianza, ma al magistrato procedente (173).
Per quanto concerne i detenuti e gli internati, questi possono essere ammessi al lavoro all'esterno senza alcun limite relativo al quantumdi pena da espiare, salvo che si tratti di persone condannate per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bisord. pen., il quale prevede il "divieto di concessione dei benefici" nel caso di commissione di taluni delitti considerati di un certo spessore criminale e dunque indice di una notevole pericolosità sociale del reo (174). In tale ipotesi "l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni" dall'inizio dell'esecuzione; se si tratta invece di detenuti condannati alla pena dell'ergastolo, l'ammissione al lavoro all'esterno può avvenire soltanto dopo l'espiazione di almeno dieci anni (art. 21 ord. pen.). Al contrario, stante l'esplicito riferimento degli artt. 4 bise 21 ord. pen. alle persone "condannate", si può fondatamente sostenere che il regime restrittivo all'accesso al lavoro all'esterno di cui al combinato disposto degli articoli testé citati - ovvero il divieto di ammissione al beneficio in esame se non dopo l'esecuzione di un certo quantumdi pena prefissato ex lege- non possa ritenersi applicabile nell'ipotesi di "imputati" che facciano istanza di ammissione al lavoro all'esterno. Tale conclusione si basa oltre che sul dato legislativo, anche sul presupposto per cui se l'imputato si vedesse applicato un regime penitenziario di maggior rigore previsto esplicitamente per ipotesi di condanna a determinati delitti, quale il regime ex art. 4 bis, si vedrebbe anticipati gli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato così che verrebbe violato il principio della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva costituzionalmente previsto e garantito (art. 27 secondo comma) (175).
Tuttavia esistono delle deroghe al divieto di cui all'art. 4 bis, infatti ai sensi dell'art. 58 terord. pen., i limiti di pena di cui all'art. 21 non si applicano qualora si tratti di persone condannate per taluno dei delitti elencati nel primo comma dell'art. 4 bis, e che si siano adoperate "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" ovvero abbiano utilmente collaborato con la giustizia.
Inoltre lo stesso art. 4 bis prevede alcune deroghe al divieto di concessione dell'ammissione al lavoro all'esterno - e in generale delle misure alternative alla detenzione - nell'ipotesi di condanna per taluno dei delitti specificatamente elencati dalla medesima disposizione qualora "siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata" ovvero nel caso in cui sia "comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia" e ancora - ipotesi del tutto analoga alla precedente - qualora "non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva" (176).
Quindi laddove non sussiste un'ipotesi di deroga al divieto di concessione del beneficio in esame, l'ammissione al lavoro all'esterno potrà avvenire soltanto nel rispetto dei limiti di pena di cui all'art. 21, da ritenersi vincolanti in ogni caso di condanna per uno dei delitti annoverati dall'art. 4 bis (177). Infine è previsto che l'assegnazione al lavoro all'esterno non possa essere concessa ai detenuti e agli internati che abbiano commesso un delitto doloso qualora il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunichi "l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata" (art. 4 bisu.c.).
Altri divieti di ammissione al lavoro all'esterno sono previsti dall'art. 58 quater secondo cui l'istituto di cui all'art. 21, così come del resto le misure alternative e i permessi premio, non possono essere concessi per un periodo di tre anni ai detenuti che si siano resi responsabili del reato di evasione ex art. 385 c.p. ovvero nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa a cui erano stati precedentemente ammessi (178). Inoltre il divieto di concessione dell'ammissione al lavoro all'esterno opera nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 c.p., concernenti due tipologie di sequestro di persona qualora abbiano causato la morte del sequestrato (comma quarto) (179). In quest'ultimo caso il divieto vige finché i detenuti in questione "non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni". Infine sempre l'art. 58 quater pone il divieto di concessione per un periodo di cinque anni di qualsiasi beneficio, dunque anche dell'ammissione al lavoro all'esterno, per i detenuti che abbiano in corso il procedimento ovvero siano già stati condannati per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso ponendo in essere "una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p. [reato di evasione, NdA] ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione".
È opportuno rilevare come sia l'art. 4 bische l'art. 58 quatersiano stati introdotti da un decreto legge (n. 152 del 1991, poi convertito nella l. n. 203 del 1991) volto a disporre provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, che indubbiamente ha come fine quello di aggravare l'accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione nelle ipotesi in cui sussista la prova di collegamenti del condannato con associazioni criminali. L'espediente utilizzato dalla normativa da ultimo citata, peraltro ripreso anche successivamente nonché recentemente dalla cosiddetta "legge ex Cirielli", è stato quello di avanzare la soglia di accessibilità a taluno di questi benefici subordinandola all'espiazione di un quantumdi pena tanto maggiore quanto più grave è lo spessore del detenuto in punto di pericolosità sociale.
Un ultimo aspetto da considerare riguarda l'ammissibilità al lavoro all'esterno di detenuti extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Al riguardo è intervenuta un'importante circolare della Direzione generale del Ministero del lavoro, la n. 27 del 15 marzo 1993, la quale dando fine all'annosa querellerelativa alla fruibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative da parte dei detenuti extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno, ha previsto "un'apposita procedura di avviamento al lavoro", qualora questo debba essere svolto necessariamente come presupposto per la concessione di una di tali misure premiali (180). La procedura introdotta vede coinvolti in particolare gli Uffici provinciali del lavoro [ora Direzioni provinciali del lavoro], i quali devono rilasciare un apposito atto di avviamento al lavoro avente validità limitata al tipo di lavoro che il detenuto andrà a svolgere, alla durata e presso il solo datore di lavoro indicati nel provvedimento con cui viene certificata l'effettuazione di un'attività lavorativa subordinata all'esterno dell'istituto penitenziario; tale atto non costituisce titolo idoneo all'iscrizione nelle liste di collocamento. Infine la circolare prevede che il libretto di lavoro [ora Scheda professionale] debba essere consegnato dall'Ufficio direttamente al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo della restituzione allo stesso ispettorato al momento della cessazione del rapporto (181).
A seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico sull'immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998) si è posto un problema di compatibilità fra la disciplina ivi contenuta in materia in particolare di permanenza sul territorio dello Stato degli stranieri privi del permesso di soggiorno e la circolare n. 27 del 1993 testé esaminata. Sul punto si sono avuti due importanti interventi: innanzitutto il Ministero di Grazia e Giustizia con una lettera circolare del 12 aprile 1999 stabiliva chiaramente che "il permesso di soggiorno, per i detenuti e per gli internati extracomunitari avviati al lavoro extramurario in misura alternativa o ammessi al lavoro all'esterno, non è necessario, attesa appunto la condizione di detenzione" (182); successivamente anche il Ministero del Lavoro in una nota dell'11 gennaio 2001 richiamando quanto previsto nella suddetta lettera circolare del Ministero della Giustizia, "non rilevava elementi ostativi al persistere dell'applicabilità dell'apposita procedura di avviamento al lavoro delineata nella circolare n. 27 del 1993". E ancora il Ministero dell'Interno con una circolare del 2 dicembre 2000 chiariva che con riferimento "alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere, la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale" (183).
Con la legge "Bossi-Fini" (l. n. 189 del 30 luglio 2002) viene modificato il Testo Unico sull'immigrazione in senso restrittivo e in particolare - per quel che concerne l'argomento di nostro interesse - viene riscritto l'art. 22 comma dodicesimo laddove è attualmente previsto che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un prestatore di lavoro "straniero", rectiusextracomunitario, privo del permesso di soggiorno commette un reato punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi. Questo significherebbe che il detenuto straniero non avrebbe alcuna chancedi accedere né al lavoro all'esterno né alle misure alternative alla detenzione in carcere, in quanto non può usufruire della possibilità di svolgere un'attività lavorativa extra moenia, con la conseguenza di vedere sostanzialmente pregiudicata per questi detenuti la finalità rieducativa del trattamento penitenziario.
Al fine di smentire tali conclusioni, tuttavia, si deve fare riferimento a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con due note del 1999, nelle quali veniva espressamente precisato che "il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno non riguarda i detenuti extracomunitari che vengono ammessi al lavoro all'interno del carcere. Ciò in considerazione del fatto che il lavoro penitenziario presenta natura e caratteristiche proprie rispetto a quello ordinario". E ancora veniva ribadito che "per quanto concerne invece, il collocamento dei detenuti extracomunitari all'esterno del carcere ed alle dipendenze di terzi, il problema della necessità del permesso di soggiorno è già stato affrontato nel 1993 (circolare Ministero Lavoro 27/93). Infatti la ratio di tale disposizione è da individuarsi nel fatto che i detenuti extracomunitari sono comunque obbligati a permanere sul territorio italiano in virtù di un provvedimento giurisdizionale. Così il problema relativo al possesso del permesso di soggiorno può considerarsi superato in quanto le disposizioni contenute nella circolare suddetta (circolare Ministero del Lavoro 27/93) appaiono tuttora applicabili" sul presupposto che il d. lgs. 286 del 1998 non introduce alcun divieto esplicito in punto di ammissibilità dei detenuti extracomunitari ai benefici penitenziari (184). La medesima conclusione peraltro può essere tratta con riguardo alla legge Bossi-Fini che del pari non innova sul punto non introducendo alcun divieto esplicito. Al contrario l'art. 22 del Testo Unico sull'immigrazione, così come modificato nel 2002, pone come elemento della fattispecie di reato ivi previsto la mancanza del permesso di soggiorno, condizione non sussistente nel caso di extracomunitari detenuti autorizzati a svolgere un'attività lavorativa in quanto beneficiari di una misura alternativa ovvero dell'ammissione al lavoro all'esterno, dal momento che in tali ipotesi il titolo di soggiorno è rappresentato dal provvedimento giurisdizionale.
In definitiva il procedimento di avviamento al lavoro previsto dalla circolare del 1993 propone in via risolutiva al problema dell'ammissibilità dei detenuti extracomunitari "irregolari" ai benefici penitenziari, la tesi per cui nelle more dell'esecuzione della pena detentiva lo straniero privo di un valido titolo di soggiorno deve considerarsi "regolare". Tale conclusione è stata ancor più avvalorata da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo la quale deve ritenersi che "è proprio l'esecuzione penale, anche nelle forme alternative al regime carcerario, a costituire il titolo che legittima la permanenza [dell'extracomunitario "irregolare", NdA] sul territorio dello Stato" (185). In occasione di tale sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo contrasto giurisprudenziale, hanno inoltre espressamente stabilito che "le misure alternative alla detenzione in carcere, sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno". Tale conclusione è motivata in virtù dei "preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2, 3 e 27, comma 3, Cost.), che costituiscono la chiave di lettura delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario sulle misure alternative e di cui sono lineare espressione anche gli artt. 1 e 13 del medesimo ordinamento sulle modalità del trattamento".
Questo in definitiva significa che non osta alla concedibilità delle misure alternative in favore del detenuto straniero irregolare, la sussistenza di un provvedimento di espulsione da eseguirsi al momento del fine pena, in quanto da un lato l'ordinamento penitenziario non distingue in ordine alla "nazionalità" o alla regolarità dell'ingresso o del soggiorno ai fini del trattamento rieducativo, e dall'altro lato deve ritenersi ormai pacifico il presupposto per cui "non esiste alcuna incompatibilità tra l'espulsione da eseguire a pena espiata e le varie opportunità trattamentali che l'ordinamento offre, dirette a favorire il reinserimento del condannato nella società, posto che, in un'ottica transnazionale, la risocializzazione non può assumere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale". Infine la Corte di cassazione, ancora nella sentenza del 2006 in esame, esclude che attraverso la concessione delle misure alternative ai detenuti stranieri irregolari possano essere eluse le norme in materia di ingresso e soggiorno regolari nonché di espulsione, in quanto per tutti quei detenuti stranieri irregolari nei cui confronti non può essere applicata la misura alternativa dell'espulsione di cui all'art. 16 comma quinto T.U. immig., non sussistendone i presupposti - in primis un fine pena non superiore a due anni -, è la stessa esecuzione della pena, anche se espiata attraverso le misure alternative alla detenzione, a giustificarne e legittimarne la permanenza sul territorio dello Stato.
Il presupposto basilare di carattere oggettivo, invece, perché un detenuto o internato possa essere ammesso al lavoro all'esterno consiste nell'idoneità delle condizioni delle attività lavorative che si andranno a svolgere "a garantire l'attuazione positiva degli scopi prevista dall'art. 15" (art. 21 ord. pen.), ovvero a consentire e facilitare un trattamento penitenziario che si concluda positivamente, in prospettiva del reinserimento del detenuto nella società libera. A tal fine è necessario che si tratti di un'attività lavorativa qualificante e gratificante per il detenuto, in cui questi sia impegnato effettivamente e in condizioni del tutto uguali alle medesime attività svolte da lavoratori liberi. In tal senso assume grande rilievo la previsione secondo cui "i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi" fatte salve "le limitazioni conseguenti agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà" (art. 48 comma undicesimo regol. penit.).
Con riferimento alle attività lavorative svolgibili all'esterno dai detenuti e dagli internati viene in rilievo una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria secondo cui è necessaria una valutazione da parte della direzione dell'istituto circa il tipo di lavoro al quale si dovrebbe ammettere il detenuto o l'internato, "non essendo accettabile che si tratti di lavori in qualche modo artificiosamente o fittiziamente creati al solo o prevalente scopo di consentirgli di lasciare temporaneamente il carcere" (186). Sempre la stessa circolare prevede poi che il lavoro che il detenuto può svolgere attraverso l'ammissione a lavorare all'esterno debba presentare i caratteri di "permanenza e stabilità"; qualora al contrario si trattasse di un'attività lavorativa "occasionale o limitata ad un breve periodo di tempo" non verrebbe in rilievo l'art. 21, "semmai l'art. 30 tertanto più che questo, tra i motivi che legittimano la concessione di un permesso premio, prevede il perseguimento di interessi di lavoro".
L'ammissione al lavoro all'esterno può essere concessa anche per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo purché si tratti di "attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti", dunque sono escluse attività del tutto improvvisate, e purché "il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale" (art. 48 comma dodicesimo). Si deve trattare pertanto di un'attività che il detenuto riesca a svolgere con una certa efficienza, tanto da configurarsi come vera e propria attività di lavoro, anche e soprattutto in punto di guadagno economico.
Secondo una prima formulazione della disciplina in materia di lavoro all'esterno, era esclusa la possibilità che l'ammissione a tale istituto potesse essere concessa per frequentare corsi di preparazione e qualificazione professionale. Tale ampliamento della sfera di operatività dell'art. 21 è stato introdotto dalla riforma apportata con il D.L. n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993 recanti nuove misure in materia di trattamento penitenziario. Attualmente infatti l'ultimo comma dell'art. 21 prevede che le disposizioni in materia di lavoro all'esterno si applichino anche ai detenuti e agli internati "ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari" (187).
In giurisprudenza si è poi arrivati a sostenere che "la frequenza giornaliera ed assidua di un istituto dove si svolgono attività specifiche per tossicodipendenti ha quel carattere occupazionale e rieducativo che la rende assimilabile al lavoro esterno", pertanto anche un tal tipo di impegno può essere considerato valido presupposto per l'ammissione all'istituto di cui all'art. 21 ord. pen. (188).
9.1.2. Il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno
L'accesso al lavoro all'esterno di detenuti ed internati è "disposto solo quando ne sia prevista la possibilità nel programma di trattamento" (art. 48 regol. penit.), dunque è subordinato alla previa menzione nel programma trattamentale individualizzato di cui all'art. 13 ord. pen. (189), e alla conseguente approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del programma stesso, in relazione al quale questi dovrà effettuare soltanto una valutazione di legittimità, per verificare che non vi siano in esso elementi che violano i diritti del condannato o dell'internato (art. 69 quinto comma) (190).
L'ammissione al lavoro all'esterno è ottenibile soltanto se la direzione dell'istituto è favorevole ad esperire tale strumento trattamentale e soprattutto se è disponibile ad impegnarsi nel reperimento di un'occasione di lavoro che consenta in concreto tale percorso rieducativo. Per incoraggiare le direzioni degli istituti penitenziari in tal senso, il legislatore ha previsto un duplice intervento, sia da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che dovrà ricercare "forme di collaborazione con le autorità competenti" per favorire l'ammissione al lavoro all'esterno, sia da parte del provveditore regionale "che impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno" (art. 48 commi ottavo e nono). Tali previsioni si sono rese necessarie dal momento che, come accennato, le direzioni dei vari istituti si sono tradizionalmente rivelate molto timide nel concedere a detenuti ed internati l'ammissione al lavoro all'esterno, sebbene questo istituto sia indubbiamente lo strumento trattamentale che meglio potrebbe facilitare il reinserimento sociale del recluso, creando un contatto duraturo e allo stesso tempo impegnativo con l'esterno e in particolare col mondo del lavoro libero.
La fase successiva alla previsione del lavoro all'esterno nel programma di trattamento e all'approvazione di questo da parte del magistrato di sorveglianza consiste nel reperimento effettivo di un'attività lavorativa. Stante l'obbligo del lavoro che grava su detenuti ed internati, cui corrisponde, come si è già avuto modo di approfondire ampiamente, il dovere per l'amministrazione penitenziaria di fornire un'attività lavorativa, di primo acchito sembrerebbe che sia compito dell'amministrazione stessa reperire le attività lavorative. Nella prassi tuttavia, vista la difficoltà e la titubanza con cui le direzioni degli istituti di pena hanno coinvolto la società civile ed incentivato la partecipazione del mondo esterno ai problemi penitenziari, il reperimento di un posto di lavoro risulta essere di fatto un problema del detenuto interessato e non dell'amministrazione (191). Cosicché l'ammissione al lavoro all'esterno diventa ancora più difficile viste le perplessità che potrebbero essere facilmente avanzate nei confronti di attività lavorative che non vengono preventivamente sottoposte al vaglio dell'amministrazione penitenziaria. A tale argomentazione si può però obiettare il fatto che rimane comunque il controllo da parte della direzione dell'istituto sull'idoneità dell'attività lavorativa all'attuazione positiva del trattamento rieducativo e risocializzativo.
Prima della novella del 1986, come accennato, l'ammissione al lavoro all'esterno era consentita soltanto presso imprese agricole o industriali, con l'esclusione delle imprese del settore terziario, fra le quali quelle commerciali, del settore dei servizi e delle libere professioni. Sin da subito è stata rilevata l'irrazionalità di tale limitazione, che da taluni veniva ancorata a retaggi storici quali l'idea che il lavoro dei detenuti dovesse essere particolarmente gravoso, quasi da recuperare i caratteri del lavoro forzato (192). Da altra parte della dottrina invece, tale limitazione veniva giustificata sulla base del carattere comunemente più strutturato delle imprese agricole ed industriali che assicuravano un lavoro "separato dal pubblico", non garantito al contrario da un'impresa commerciale (193). In realtà una siffatta restrizione delle categorie di imprese che possono offrire occasioni di lavoro ai detenuti, si è rivelata inopportuna vista la carenza di posti di lavoro all'interno del carcere, e dunque si era resa ormai necessaria una modifica nel senso dell'abolizione di qualsiasi limitazione al riguardo, così come è stato fatto dalla legge Gozzini (194).
Una volta reperita un'attività lavorativa cui il detenuto potrà dedicarsi, l'ammissione al lavoro all'esterno è disposta dal direttore dell'istituto (195). La direzione dell'istituto deve "motivare" sia la richiesta di approvazione del programma di trattamento, qualora questo preveda la possibilità dell'accesso all'istituto di cui si tratta, sia la richiesta di autorizzazione al lavoro all'esterno "anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione" nonché dei risultati delle indagini svolte nell'istruttoria del caso, fatta comunque salva la possibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre o richiedere, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori integrazioni istruttorie (196). L'esecutività del provvedimento di ammissione è infatti subordinata all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, il quale non dovrà limitarsi ad un mero esame di legittimità, ma dovrà compiere un esame di merito, relativo all'opportunità e alle modalità di ammissione, nonché alle modalità di svolgimento dell'attività prevista (197).
Il magistrato di sorveglianza, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione al lavoro all'esterno con la relativa documentazione deve decidere tenendo conto innanzitutto che non vi siano profili ostativi quali i divieti previsti dall'art. 4 bisovvero se si versa in tale ipotesi che il detenuto abbia espiato il quantumdi pena previsto, e conseguentemente "del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati" (art. 48 comma quarto). Proprio con riferimento a siffatta valutazione di merito del magistrato di sorveglianza, larga parte della dottrina ha sottolineato la vicinanza della disciplina dell'ammissione al lavoro all'esterno alla parallela disciplina del procedimento di accesso alle misure alternative, arrivando a sostenere, a seguito della novella in questione, lo spostamento dell'istituto del lavoro all'esterno dal novero delle modalità di organizzazione del lavoro penitenziario all'alveo delle misure alternative alla detenzione (198). Addirittura sia in dottrina che in una circolare dell'amministrazione penitenziaria, è stato rilevato il rischio che l'ammissione al lavoro all'esterno possa essere utilizzata come espediente per concedere un regime di misura alternativa alla detenzione a quei detenuti che non presentano i presupposti per accedervi, raggirando dunque le preclusioni o la mancata maturazione dei prescritti termini (199); questo sarebbe dovuto al fatto che la decisione in punto di scelta dei detenuti o internati da ammettere al lavoro all'esterno spetta esclusivamente al direttore dell'istituto, cosicché si potrebbe dare esecuzione a quei "sotterranei patteggiamenti" fra amministrazione e detenuti, più volte denunciati, ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina nelle carceri (200). Tuttavia tali osservazioni sono facilmente obiettabili sulla base della previsione di un duplice intervento del magistrato di sorveglianza - attraverso il quale si dovrebbe ovviare a tale pericolo - sia in sede di approvazione del programma di trattamento, sia in sede di autorizzazione all'ammissione all'istituto di cui all'art. 21 ord. pen., quest'ultimo finalizzato, come si è già avuto modo di sottolineare, anche ad un controllo di merito sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio.
Il legislatore ha comunque previsto una serie di comunicazioni del provvedimento di ammissione all'esterno che dovrebbero garantire una certa visibilità e conseguentemente una certa trasparenza del procedimento stesso. Infatti il provvedimento in questione deve essere trasmesso al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale. Ovviamente è necessario che tale comunicazione venga effettuata anche nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno (art. 48 comma quattordicesimo).
Un annoso dibattito in dottrina e giurisprudenza ha riguardato la natura del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e la conseguente impugnabilità dello stesso. Infatti prima della riforma del 1986 era pressoché pacifico che il provvedimento di autorizzazione del magistrato di sorveglianza fosse un mero "nulla osta" alla concessione del lavoro all'esterno, in quanto tale configurabile come atto endo-processuale, che si innescava dunque in un procedimento amministrativo avente come atto finale il provvedimento di ammissione del direttore dell'istituto. Era pertanto pacifica la configurazione del provvedimento di ammissione all'esterno come atto prettamente amministrativo, con la conseguenza che l'atto autorizzativo del magistrato di sorveglianza risultava non impugnabile, tanto più di fronte al giudice ordinario (201).
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge Gozzini, invece, il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno è stato giurisdizionalizzato, accentuando il ruolo del magistrato di sorveglianza, cosicché si pone il problema della natura giuridica del provvedimento di autorizzazione da questi emanato ai fini dell'esecutività dell'ammissione. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità e parte della dottrina hanno sostenuto la natura di atto meramente amministrativo del magistrato di sorveglianza e in quanto tale non impugnabile di fronte al giudice dei diritti né tanto meno ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Infatti secondo la Corte di Cassazione:
"il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno ha natura amministrativa. Identica natura hanno gli atti che, nel corso del procedimento, la legge riserva all'autorità giudiziaria. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 21 l. 354 del 1975: la natura amministrativa esclude, infatti, l'esperibilità di mezzi di impugnazione previsti dal c.p.p., che non prevede al riguardo rimedi di sorta, né è ipotizzabile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., non potendosi la materia, riservata all'autorità carceraria, farsi rientrare in quella relativa alla libertà personale" (202).
La Corte di cassazione adotta un concetto restrittivo di libertà personale, rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 111 Cost., nel senso che essa è da intendere come "disponibilità fisica della propria persona" e quindi "non tutte le limitazioni della sfera di autodeterminazione individuale sono sottoposte al controllo indicato nel citato disposto costituzionale [art. 111, NdA] ma soltanto quelle con cui vengono adottate misure restrittive dello status libertatis, nonché quelle che comunque incidono sulla cessazione o la modifica di tali misure con effetti potenzialmente definitivi sulla posizione giuridica del detenuto" (203). Secondo la Corte di cassazione, laddove il magistrato non volesse autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno e dunque fosse dissenziente, dovrebbe "limitarsi a restituire il provvedimento all'autorità carceraria con le osservazioni ritenute necessarie, ai fini di una nuova formulazione" (204), così come del resto avviene qualora non ritenesse rispettoso dei diritti dei detenuti il relativo programma trattamentale, che deve del pari essere sottoposto all'approvazione dell'autorità giudiziaria competente a garantire l'osservanza e il rispetto della legalità nei confronti di coloro che si trovano ristretti nella propria libertà personale.
La giurisprudenza di merito invece è piuttosto orientata a considerare il "decreto" ex art. 69 ord. pen. di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, come atto giurisdizionale - nonostante la forma dello stesso il quale avrebbe dovuto più opportunamente essere previsto come ordinanza - il quale "incidendo indubbiamente sulla libertà sia pure sotto il profilo di modalità di esecuzione della pena detentiva personale" ha come conseguenza "l'indubbia esperibilità del ricorso in Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 Cost." (205). La sentenza in questione prende atto del procedimento di giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della pena detentiva, e parte dal presupposto che in materia sussiste un diritto del detenuto e non viceversa un interesse legittimo, che giustificherebbe in particolare un ricorso al giudice amministrativo. La dottrina più attenta ha notato come nell'ipotesi di decisione in ordine all'ammissione al lavoro all'esterno sussistono due diritti fondamentali costituzionalmente garantiti: il diritto al lavoro, previsto e tutelato dagli artt. 4 e 35 Cost., e l'incomprimibile diritto alla libertà personale di cui all'art. 13 Cost. In particolare il diniego oppure la concessione dell'ammissione al lavoro all'esterno possono concretamente incidere sullo status libertatisdel detenuto nonché sulla funzione rieducativa della pena, cosicché il provvedimento del magistrato di sorveglianza deve ritenersi quantomeno ricorribile di fronte al giudice di legittimità ex art. 111 Cost. (206).
Probabilmente la soluzione interpretativa preferibile dovrebbe essere nel senso di ammettere il ricorso per cassazione per violazione di legge, incidendo indubbiamente la concessione o il diniego dell'ammissione al lavoro all'esterno, e dunque i relativi provvedimenti del magistrato di sorveglianza, sullo spazio di libertà lasciato al detenuto, considerando che il lavoro all'esterno consente un parziale reinserimento nel mondo libero, anche e soprattutto in funzione rieducativa, e che dunque certamente incide positivamente sullo statusdetentivo del reo, attenuandolo notevolmente. Inoltre sembra parimenti giusta l'interpretazione secondo cui il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno inciderebbe anche sul diritto al lavoro che ex art. 4 Cost. è riconosciuto a tutti i cittadini, compresi ovviamente i detenuti, forse a maggior ragione se si considerano le scarse opportunità lavorative all'interno degli istituti penitenziari, cosicché, un eventuale diniego di ammissione al lavoro all'esterno potrebbe violare anche il diritto-dovere al lavoro di cui all'art. 4 della Carta costituzionale. Pertanto anche tale profilo interpretativo induce a ritenere ammissibile la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui dispone in ordine alla autorizzazione al lavoro all'esterno, resta però da stabilire dinanzi quale giudice in tal caso far valere la violazione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito, dal momento che in siffatta ipotesi vi è una stretta sovrapposizione fra diritti del detenuto in quanto cittadino ed esecuzione della pena, che limita "necessariamente" l'esercizio di tali diritti.
9.1.3 L'esecuzione del lavoro all'esterno: disciplina penitenziaristica ...
A differenza di quanto previsto prima della riforma del 1986, attualmente "i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza" (art. 21 ord. pen.). Come ricordato, la disciplina precedente prevedeva che i detenuti e gli internati soltanto in via residuale, "potessero" essere ammessi al lavoro all'esterno senza scorta (207). Dunque l'ipotesi che prima costituiva un'eccezione, a seguito della riforma è diventata la regola generale. Tuttavia, come è stato rilevato in dottrina, sussiste ancora una clausola di salvataggio, consistente nei "motivi di sicurezza", che potrebbe costituire un valido pretesto per giustificare una sostanziale disapplicazione dell'istituto (208), dal momento che rimane insoluto il problema del reperimento della scorta, essendo ancora previsto che questa debba essere effettuata dal personale del corpo di polizia penitenziaria (art. 48 regol. penit.). Al riguardo è intervenuta una circolare del DAP, secondo la quale va valutata nella concretezza dei fatti la realizzabilità del servizio di scorta, senza gravare le forze dell'ordine di "oneri eccessivi ed insostenibili". Piuttosto laddove il servizio di scorta fosse inattuabile nonostante le ragioni di sicurezza, il provvedimento di ammissione "non può essere positivo", e conseguentemente al detenuto non potrà essere concesso di lavorare all'esterno (209). Tuttavia tale circolare proponendo una siffatta soluzione al problema della scorta sembra non prestare la dovuta attenzione alla configurazione del lavoro penitenziario come diritto per il detenuto e come obbligo per l'amministrazione penitenziaria, la quale se non riesce ad adempiervi attraverso le opportunità lavorative intra moeniadovrebbe quantomeno facilitare, rectius non ostruire l'ammissione al lavoro all'esterno. Pertanto la citata circolare dovrebbe ritenersi illegittima in quanto praeter legem, non essendo prevista tale ulteriore limitazione all'accesso al lavoro all'esterno né dalla legge sull'ordinamento penitenziario né dal relativo regolamento di esecuzione, e dunque in contrasto con gli artt. 15 e 21 della legge n. 354 del 1975.
In ogni caso il detenuto ammesso al lavoro all'esterno è sottoposto a frequenti controlli, volti ad accertare l'osservanza delle prescrizioni e che "il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità" (art. 48, comma sedicesimo). Al fine di effettuare gli opportuni controlli, la direzione dell'istituto si avvale del personale dipendente e del servizio sociale (art. 21 comma terzo). Una particolare sollecitudine nell'esecuzione dei controlli è richiesta dal legislatore qualora si tratti di lavoro svolto presso imprese private, nel qual caso "il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto" la quale potrà delegare il relativo compito al personale dipendente o ai servizi sociali, ma in entrambe le ipotesi dovrà verificare che il detenuto si attenga alle disposizioni impartitegli nel provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno (210). Inoltre il controllo dovrà essere finalizzato anche alla verifica del rispetto da parte del datore di lavoro dei diritti e della dignità del detenuto ammesso al lavoro all'esterno, diritti e dignità che devono essere riconosciuti ad ogni singolo lavoratore, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona ristretta nella propria libertà personale. Così, a titolo di esempio, il datore di lavoro non potrà esercitare forme di controllo sul prestatore di lavoro in articolo 21 ord. pen. attraverso guardie giurate o impianti audiovisivi in deroga ai divieti di cui agli artt. 2 e 4 dello "statuto dei lavoratori" (legge n. 300 del 1970). Tali eventuali deroghe infatti non sarebbero giustificabili neppure sul presupposto che si tratta di modalità di sorveglianza del soggetto in esecuzione pena, attuabile invece soltanto attraverso un apposito servizio di scorta predisposto dalla direzione del carcere (211).
Laddove invece si tratti di impresa pubblica, è previsto che il direttore dell'istituto di appartenenza del detenuto o internato ammesso al lavoro all'esterno curi "l'adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo" (art. 48 u.c.). Quindi in definitiva, a seconda che l'impresa presso cui il detenuto è ammesso a lavorare sia privata o pubblica, cambiano le modalità di svolgimento dei controlli, che nel primo caso gravano direttamente sulle direzioni degli istituti (212), mentre nel secondo caso sono svolti in prima battuta dal datore di lavoro stesso, che eventualmente richiede l'intervento della direzione penitenziaria.
La concessione del lavoro all'esterno comporta per il detenuto l'obbligo di ottemperare alle "prescrizioni" contenute nel provvedimento di ammissione, dovendo impegnarsi "per iscritto" a rispettarle durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto (art. 48, comma tredicesimo). Particolarmente importanti sono le prescrizioni relative agli orari di uscita e di rientro dall'istituto penitenziario, nel fissare le quali si dovrà tenere conto "dell'esigenza di consumazione dei pasti" e soprattutto "del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento" (art. 48 comma tredicesimo). Cosicché lo svolgimento di un lavoro all'esterno diviene anche l'occasione per garantire i contatti del detenuto con la famiglia e dunque coltivare gli interessi e gli affetti familiari. Invece non sembrano potersi ritenere ammissibili prescrizioni che permettano lo svolgimento di "attività comunque utili al reinserimento sociale" secondo quanto stabilito da una circolare DAP del 1990 (213), "a meno che queste non siano imprescindibilmente connesse all'attività lavorativa nonché alle modalità e ai tempi prefissati per questa, con carattere quindi di continuità". Inoltre se il detenuto viene ammesso a lavorare all'esterno in un comune limitrofo a quello in cui ha sede lo stabilimento penitenziario ovvero deve spostarsi saltuariamente dall'abituale luogo di lavoro, le prescrizioni devono prevedere tali ipotesi "in maniera dettagliata e circostanziata", in modo da calcolare i tempi necessari per il raggiungimento del luogo di lavoro e valutare che non sussistano ostacoli allo svolgimento delle attività di sostegno e controllo.
Il legislatore ha infine previsto che le prescrizioni relative all'orario di rientro in istituto devono anche prevedere l'ipotesi di ritardo per forza maggiore, per cui l'orario di rientro dovrà essere fissato in una fascia oraria scaduta la quale "viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385 del codice penale", ovvero il reato di evasione. La giurisprudenza ha esteso al caso di specie la disciplina applicabile in materia di permessi, laddove è previsto che si perfeziona il reato di evasione se il detenuto non fa ritorno in istituto entro dodici ore dalla scadenza dell'orario prefissato per il rientro (art. 30 comma terzo) (214).
Le prescrizioni possono essere modificate nel corso dell'esecuzione del lavoro all'esterno a seconda delle nuove esigenze che dovessero presentarsi. In tal caso le modifiche devono essere comunicate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale, dunque a tutti quei soggetti a cui deve essere comunicato preliminarmente l'ammissione al lavoro all'esterno.
È quasi superfluo evidenziare come le prescrizioni più importanti siano quelle relative ai tempi e alle modalità di svolgimento del lavoro all'esterno, dal momento che il detenuto ammesso a tale misura deve essere sempre "reperibile nei luoghi e nei tempi predeterminati" (215). Infatti secondo una costante giurisprudenza il detenuto ammesso al lavoro all'esterno è comunque in esecuzione pena detentiva, dunque recandosi sul posto di lavoro "non si sottrae alla restrizione personale legalmente imposta, poiché egli rimane anche fuori dall'istituto sotto il diretto controllo della direzione dello stesso, per cui commette il reato di evasione allorché si allontani volontariamente dal luogo di lavoro al quale è stato assegnato" (216). Il reato sussiste anche nel caso in cui a seguito dell'arbitrario allontanamento dal posto di lavoro, il detenuto faccia comunque rientro in carcere alla scadenza dell'orario fissato per il reingresso (217).
Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, o violazione delle stesse, ovvero nel caso di evasione, il provvedimento di ammissione all'esterno può essere revocato. La revoca diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza tuttavia in via provvisoria il direttore dell'istituto può sospenderne l'efficacia (art. 48 comma quindicesimo). È chiaro dunque che il detenuto o l'internato che nel corso dell'esecuzione del lavoro all'esterno non si appalesi idoneo al regime di maggiore libertà che gli è concesso, andrà incontro alla revoca dell'ammissione stessa, perdendo così la possibilità di fruire di quel valido strumento di reinserimento sociale costituito dal lavoro all'esterno (218).
9.1.4 ... e disciplina giuslavoristica
La normativa contenuta nella legge sull'ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento di attuazione è piuttosto lacunosa in punto di previsione della disciplina giuslavoristica concernente l'attività lavorativa svolta dal detenuto ammesso al lavoro all'esterno. Gli unici dati normativi che si possono trarre riguardano la materia del collocamento al lavoro (art. 20 comma undicesimo) e quella dei diritti esercitabili dai detenuti in quanto lavoratori (art. 48 comma undicesimo). In entrambi i casi vi è un rimando alla disciplina generale in materia di lavoro per cui si può concludere che l'orientamento legislativo è quello della piena parificazione o meglio estensione della disciplina giuslavoristica generalmente applicata, alle prestazioni di lavoro svolte da detenuti e internati ammessi a usufruire dell'istituto di cui all'art. 21 ord. pen. Le sole differenze giustificabili al riguardo sono quelle che conseguono necessariamente alla limitazione della libertà personale. Pertanto si tratta di esaminare quei tratti della disciplina giuslavoristica a cui sovrapponendosi la disciplina penitenziaristica, devono essere evidentemente apportati gli opportuni adattamenti.
Per quanto riguarda il collocamento al lavoro, si è detto, "si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della l. 28 febbraio 1987, n. 56" (art. 20 ord. pen.). Pertanto non sussiste alcuna differenza fra lavoratori liberi e lavoratori detenuti ammessi al lavoro all'esterno, per i quali non si applicherà la disciplina di cui all'art. 20 in materia di cosiddette "liste lavoranti", ma la disciplina in materia di assunzione diretta di cui alla legge n. 608 del 1996, che prevede la mera comunicazione successiva all'ufficio del collocamento [rectius centro per l'impiego] dell'avvenuta assunzione. Resta comunque salva l'applicabilità della disciplina derogatoria di cui all'art. 19 della legge n. 56 del 1987 in materia di iscrizione, facoltativa peraltro, nella liste di collocamento di detenuti ed internati ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione e dell'accesso alla relative tutele sociali.
Con riferimento al momento della costituzione del rapporto di lavoro sorge un primo problema di sovrapposizione fra disciplina lavoristica e disciplina penitenziaristica, in quanto è in dubbio se la stipulazione del contratto di lavoro debba precedere ovvero seguire il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. La dottrina propende per mantenere, in linea generale, separate le due vicende. In realtà non si avrebbe autorizzazione al lavoro all'esterno, qualora il detenuto o l'internato non dimostrasse di avere reperito una concreta opportunità di lavoro. Per cui sembra opportuno concludere sostenendo la necessità della preventiva stipulazione del contratto di lavoro, cui farà seguito l'autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, la cui eventualità peraltro deve essere già ex anteindicata nel programma di trattamento così approvato dal magistrato di sorveglianza. Tuttavia qualora l'ammissione all'esterno non dovesse essere autorizzata dal direttore dell'istituto ovvero dal magistrato di sorveglianza, il contratto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa o giustificato motivo (219).
La disciplina concernente lo svolgimento del rapporto trova il punto di partenza nella regola fondamentale sancita dall'art. 48 undicesimo comma regol. penit., secondo cui "i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà". La medesima conclusione deve trarsi con riferimento ai poteri del datore di lavoro. Viene comunemente preso in dottrina come esempio dei limiti inerenti all'esecuzione della pena, lo svolgimento di lavoro notturno, che dovrà sicuramente essere escluso per il lavoratore detenuto. O ancora in relazione al potere datoriale di trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra, sussiste un vincolo derivante dallo statusdetentivo del lavoratore, infatti la spendita di tale potere sarà possibile soltanto a seguito di una modifica delle prescrizioni inerenti allo svolgimento del lavoro all'esterno da parte di un detenuto o internato (220).
Viceversa non esiste alcuna differenza in punto di diritti del lavoratore, quali il diritto ai riposi settimanali e festivi nonché il diritto a ferie annuali retribuite, diritti peraltro irrinunciabili ex art. 36 u.c. Cost. eccettuato il solo diritto ai riposi festivi, i quali potranno essere concretamente usufruiti attraverso la richiesta di un permesso premio o se si tratta di internati, di una licenza, ovvero qualora questi benefici non fossero ottenibili, attraverso la permanenza in istituto partecipando alle attività ricreative, sportive o comunque di svago eventualmente organizzate. Del pari sembra pienamente applicabile la disciplina generale in materia di divieto di assegnazione a mansioni inferiori, nonché di promozione automatica in caso di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di cui all'art. 2103 c.c. Infine si applica senza alcun problema la normativa relativa all'indennità di anzianità e di disoccupazione (221).
Ancora non sembra potersi ritenere ammissibile alcuna differenza fra lavoratori liberi e lavoratori detenuti, ammessi al lavoro all'esterno, relativamente all'esercizio dei diritti sindacali. Non vi è infatti alcuna condizione ostativa all'iscrizione e alla partecipazione del detenuto ad un'organizzazione sindacale, fatte salve le limitazioni che eventualmente lo statuto della stessa organizzazione possa porre, quali ad esempio vincoli all'accettazione della domanda di iscrizione correlati, per esempio, all'incensuratezza o al generico concetto di buona condotta morale e civile dei richiedenti (222). In ogni caso non si può escludere la partecipazione del detenuto lavorante all'esterno alle riunioni sindacali nei luoghi di lavoro qualora queste si svolgano durante la fascia oraria in cui il detenuto è autorizzato a permanere all'esterno. La stessa conclusione si può sostenere con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, in quanto diritto costituzionalmente garantito e inerente ai rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, su cui pertanto non può avere alcuna incidenza lo status detentionis del prestatore di lavoro. Secondo parte della dottrina l'astensione dal lavoro si effettua tramite la permanenza in istituto, fatta salva la possibilità per il detenuto lavoratore di proporre istanza di permesso premio "per coltivare interessi di lavoro, quali ad esempio, la partecipazione a manifestazioni o ad assemblee indette in occasione dello sciopero" (223).
Per quanto riguarda poi la disciplina applicabile per determinare la retribuzione del detenuto ammesso al lavoro all'esterno, alcune importanti indicazioni provengono dal legislatore, infatti l'art. 48 al decimo comma prevede che "i datori di lavoro dei detenuti o internati, [siano] tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare". Come è stato rilevato in dottrina, e confermato dalla giurisprudenza di merito, il legislatore parla espressamente di "retribuzione", e non di "mercede" o "remunerazione", così come avviene per i detenuti collocati al lavoro all'interno dell'istituto penitenziario. Pertanto non si ritiene applicabile la disciplina propriamente penitenziaristica in materia di remunerazione, per cui il corrispettivo dovuto al lavoratore detenuto può essere inferiore fino ad un terzo rispetto al cosiddetto "minimo sindacale" di cui all'art. 22 ord. pen. (224). Ne consegue che la retribuzione del detenuto lavorante all'esterno sarà determinata sulla base del contratto collettivo che si applica in generale nel luogo di lavoro presso cui svolge la prestazione lavorativa (225).
Si è discusso in ordine alla previsione secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo di versare la retribuzione alla direzione dell'istituto nel quale il lavoratore è ristretto. Il dubbio concerne la possibilità che il rapporto punitivo fra Stato e detenuto possa determinare un obbligo a carico di un soggetto terzo, con il quale il detenuto intrattiene un rapporto di lavoro del tutto autonomo. La ratiodella disposizione in esame è stata rinvenuta nel divieto per detenuti ed internati di tenere presso di sé denaro e nell'obbligo gravante sugli stessi di risarcire il danno derivante dal reato e rimborsare lo Stato delle spese di mantenimento (art. 24). Pertanto dal momento che l'adempimento di tali obblighi e divieti è più facilmente realizzabile attraverso la collaborazione del datore di lavoro, è parso opportuno al legislatore gravare quest'ultimo dell'onere di versare la retribuzione alla direzione del carcere, così da garantire una piena attuazione della disciplina in materia di pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione nonché di peculio (226).
Con riferimento infine al profilo della cessazione del rapporto di lavoro, si può partire dal medesimo presupposto da cui si è partiti nell'esame della disciplina giuslavoristica concernente l'istituto del lavoro all'esterno, ovvero la piena applicabilità della normativa generale in materia di lavoro fatte salve le deroghe necessarie ai fini dell'esecuzione della pena. Pertanto anche in tal caso, applicando la disciplina generale, il rapporto di lavoro fra lavoratore detenuto e datore di lavoro potrà risolversi a seguito di licenziamento, individuale o collettivo, o a seguito delle dimissioni del prestatore di lavoro. In particolare il licenziamento individuale potrà avvenire ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, per giusta causa o giustificato motivo, mentre nel caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro dovrà seguire anche nei confronti del lavoratore detenuto la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 (227).
La cessazione del rapporto di lavoro interseca indubbiamente il rapporto punitivo, in quanto la conditio sine qua non di ammissione al lavoro all'esterno, consiste per l'appunto nella disponibilità di una concreta attività lavorativa, nella quale impegnarsi durante il tempo trascorso fuori dall'istituto. Al di là delle ragioni che possono aver portato alla cessazione del rapporto, le quali nel caso di licenziamento individuale soggettivo possono mettere in luce l'incapacità del detenuto di gestire l'attività lavorativa, e dunque l'inadeguatezza all'ammissione al lavoro all'esterno, rimane il fatto che venendo meno l'attività lavorativa, viene meno la ragione giustificatrice dell'uscita quotidiana dall'istituto prevista dal programma trattamentale. La conseguenza che sembra potersi trarre è la necessaria revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, almeno fintanto che il detenuto non abbia trovato un'altra occasione di lavoro. D'altra parte le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza confermano tale interpretazione, infatti il giudice di legittimità ha avuto modo di esprimersi in punto di licenziamento di detenuto lavorante al di fuori dell'istituto penitenziario in semilibertà, concludendo per la revoca della misura alternativa (228). Stante la vicinanza di ratio, finalità e caratteri fra ammissione al lavoro all'esterno e semilibertà, anche con riferimento al profilo della cessazione del rapporto, così come per la retribuzione, l'interpretazione giurisprudenziale sulla disciplina concernente la revoca della semilibertà nel caso in cui venga meno l'attività lavorativa, può essere analogicamente estesa anche alla parallela ipotesi nell'ambito dell'esecuzione dell'istituto dell'ammissione al lavoro all'esterno.
Per quanto riguarda infine il profilo della tutela giurisdizionale del prestatore di lavoro, detenuto ma ammesso al lavoro all'esterno, non sembra potersi avere alcuna differenza rispetto ai lavoratori liberi, dal momento che indubbiamente il rapporto di lavoro che si instaura nel caso di specie, è propriamente di carattere privatistico, per cui la tutela del lavoratore, già prima della recente sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2006, doveva essere pacificamente attribuita al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
9.2 La semilibertà
L'ammissione al lavoro all'esterno non esaurisce le modalità attraverso cui un detenuto o internato può essere autorizzato a svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere, dal momento che l'ordinamento penitenziario prevede anche le misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale, imperniate, nella maggior parte dei casi, per l'appunto sulla prospettiva dello svolgimento di un'attività produttiva all'esterno dell'istituto penitenziario, quale presupposto saliente ai fini della loro concessione.
La semilibertà, in particolare, consiste ex art. 48 ord. pen. "nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale". Dunque la ratiodella semilibertà è favorire un parziale reingresso nella vita sociale, attraverso l'uscita dal carcere per parte della giornata al fine di svolgere un'attività utile al reinserimento sociale. In tal senso, lo svolgimento di un'attività lavorativa costituisce indubbiamente lo strumento privilegiato da parte del legislatore per il raggiungimento dell'obiettivo della reintegrazione sociale.
Non è certamente questa la sede per una disamina dettagliata della disciplina in materia di semilibertà, tuttavia occorre brevemente accennare ai requisiti e alle modalità di accesso a tale misura alternativa in relazione all'opportunità, concessa dall'istituto di cui si tratta, di svolgere un'attività lavorativa al di fuori del carcere. In realtà la configurazione legislativa della semilibertà porterebbe ad escludere la ricomprensione della stessa nel novero delle misure alternative, o quantomeno a definirla come "misura alternativa impropria" (229) dal momento che non consente l'espiazione della pena in modalità propriamente alternativa al carcere, e quindi la cessazione dello stato detentivo, essendo previsto una parziale permanenza in libertà a cui fa seguito il reingresso in istituto al termine della giornata lavorativa o della partecipazione all'attività risocializzante (230).
Innanzitutto si deve precisare che possono accedere alla misura della semilibertà soltanto i detenuti condannati in via definitiva e gli internati, non anche gli imputati dal momento che nei loro confronti non può essere avviato alcun trattamento rieducativo. Al riguardo solitamente si distinguono sulla base del dettato legislativo di cui all'art. 50 ord. pen., tre "tipologie" di semilibertà a seconda della posizione giuridica del condannato: una semilibertà quale "sanzione alternativa" alle pene detentive inferiori a sei mesi (primo comma); una semilibertà quale modalità di esecuzione delle pene detentive medio-lunghe e dell'ergastolo (commi secondo, prima parte, e quinto); una semilibertà "surrogatoria" dell'affidamento in prova ai servizi sociali (secondo comma, seconda parte).
La prima tipologia di semilibertà è destinata dunque ai detenuti e agli internati con pene detentive di breve durata, ai quali la misura alternativa in questione viene concessa per attenuare gli effetti desocializzanti della detenzione in carcere, o addirittura per evitarli laddove la misura alternativa venga concessa abinitio, prima ancora dell'ingresso del soggetto condannato in carcere (art. 656 comma quinto c.p.p.) (231). La seconda tipologia invece è destinata ai detenuti ed internati con pene medio-lunghe, i quali abbiamo già scontato metà della pena, ovvero due terzi se si tratta di rei per uno dei reati di cui all'art. 4 bis (232), pertanto la semilibertà è sovente concessa nell'ultima fase di esecuzione della pena in prospettiva di un'eventuale liberazione condizionale, come vera e propria modalità trattamentale al fine di favorire il riadattamento sociale del detenuto tramite un graduale reinserimento nel mondo "libero". Infine la semilibertà "surrogatoria" dell'affidamento in prova, può essere concessa per pene non superiori a tre anni, qualora non vi siano tutte le condizioni per consentire l'accesso ad una misura alternativa che consenta l'esecuzione della pena in totale libertà, quale l'affidamento, e dunque sia necessaria mantenere ancora uno statusdetentivo, seppur parziale (233).
L'ammissione al regime della semilibertà "è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". Innanzitutto dunque è previsto come condizione fondamentale per l'accesso alla semilibertà che il soggetto nei cui confronti debba essere applicata tale misura alternativa, abbia conseguito dei concreti miglioramenti nel corso del trattamento inframurario. È evidente come tale disposizione non possa applicarsi nell'ipotesi in cui il condannato sia ammesso alla semilibertà prima dell'ingresso in istituto, nel qual caso si terrà presente come criterio di valutazione dell'idoneità della misura, la "volontà di reinserimento nella vita sociale" dimostrata dall'interessato (art. 50 comma sesto), pacificamente intesa dalla dottrina come "predisposizione di situazioni concrete ed obiettive che almeno prefigurino le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto" (234). Nell'ipotesi di soggetto già ristretto in istituto, invece, ai fini della concessione dovranno essere valutati i progressi compiuti nel corso del trattamento carcerario, attraverso l'osservazione scientifica della personalità, nonché la situazione giuridica complessiva del condannato, quale i precedenti penali, la gravità e le motivazioni del reato, ovvero tutti gli altri elementi che potrebbero essere significativi in punto di determinazione della pericolosità sociale (235).
Secondariamente altro presupposto essenziale per l'accesso alla semilibertà è la sussistenza di attività che contribuiscano al reinserimento sociale. Fra queste, notevole importanza è assegnata allo svolgimento di un'attività lavorativa, che addirittura da una giurisprudenza minoritaria veniva considerata come condizione essenziale ai fini dell'ammissione alla semilibertà (236). Tuttavia la lettera della legge suggerisce conclusioni diverse rispetto all'interpretazione tratta da tale giurisprudenza, dal momento che l'art. 48 ord. pen. fa riferimento ad attività lavorative, istruttive o "comunque utili al reinserimento sociale", dando pertanto la possibilità al condannato di scegliere l'attività cui dedicarsi in semilibertà, purché sia ritenuta utile al reinserimento sociale (237). La valutazione in ordine all'idoneità dell'attività a garantire lo sperato riadattamento sociale spetta al Tribunale di sorveglianza, competente sulla concessione della semilibertà ex art. 70 ord. pen. (238)
Qualora l'attività volta al reinserimento sociale fosse lo svolgimento di un lavoro, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non è sufficiente la mera indicazione della sussistenza di un'attività lavorativa, ma "è necessaria la prova dell'esistenza di un posto di lavoro, o comunque di un'attività lavorativa sicuramente riservati" al detenuto, così che è necessario che l'attività che si andrà a svolgere abbia il "requisito della concretezza" (239). In particolare non è consentito rimandare ad una fase successiva a quella della valutazione dei presupposti per l'ammissione alla semilibertà "l'accertamento del tipo di collocamento al lavoro", perché in tal modo "si sottrarrebbe ad ogni controllo l'attività lavorativa che deve essere rigorosamente accertata e vagliata al fine di valutare la serietà, l'attendibilità e l'idoneità a consentire il reinserimento sociale del reo" (240). Sempre con riferimento al problema dell'accertamento della sussistenza in concreto dell'attività lavorativa cui il detenuto andrà a dedicarsi in regime di semilibertà, è stato sostenuto in giurisprudenza che "la certezza di prospettive future di tale attività non può valutarsi in termini di assolutezza, ma di relatività, e pertanto, non può prescindersi dalla serietà di affidamento proveniente da una pubblica amministrazione" (241).
Di recente è stata ammessa la possibilità di accedere alla misura alternativa della semilibertà anche per dedicarsi ad un lavoro svolto a titolo gratuito, infatti secondo la Corte di Cassazione "non può essere ritenuto che un'attività lavorativa non sia affidabile per il solo fatto di non essere retribuita" (242). L'ordinamento penitenziario, infine, consente che il lavoro cui il detenuto potrebbe dedicarsi in regime di semilibertà, non debba consistere solo ed esclusivamente in un'attività lavorativa a titolo subordinato, ma possa anche concretizzarsi in un'attività di lavoro autonomo (art. 54 u.c. regol. penit.).
Una volta valutata la sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo per l'ammissione alla semilibertà, la decisione in ordine alla concessione spetta come si è già avuto modo di precisare, al Tribunale di sorveglianza. A seguito della concessione, deve essere redatta dall'équipedel carcere, il programma di trattamento, che il magistrato di sorveglianza dovrà approvare, nel quale devono essere determinate le "prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e il servizio sociale" (art. 101 comma secondo regol. penit.). Inoltre qualora la semilibertà fosse concessa per svolgere un'attività lavorativa, il programma di trattamento, secondo quanto stabilito da una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dovrà indicare in maniera precisa "la ditta, l'indirizzo del luogo di lavoro, le mansioni svolte dal semilibero, l'orario di lavoro. Quando, poi, l'attività lavorativa presuppone la mobilità in un vasto territorio, è necessario prevedere un programma dettagliato degli spostamenti, così da consentire ai centri di servizio sociale [rectiusuffici di esecuzione penale esterna] di svolgere i propri compiti di assistenza e vigilanza" (243). Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il posto di lavoro reperito dal detenuto ammesso alla semilibertà fosse troppo distante dall'istituto di reclusione per poter rispettare gli orari di reingresso in istituto al termine della giornata lavorativa, il magistrato di sorveglianza potrà anche stabilire il trasferimento del condannato in altro istituto (244).
Al pari di quanto avviene nel caso dell'ammissione al lavoro all'esterno di cui all'art. 21 ord. pen, anche il regime della semilibertà, e l'attività lavorativa svolta in pendenza di tale misura alternativa, sono sottoposte ad una rigida regolamentazione in modo da assicurare il controllo sul detenuto o internato beneficiario della misura. Tale controllo è svolto prevalentemente dai servizi sociali, cui spetta anche l'assistenza al detenuto in semilibertà (245). Inoltre le prescrizioni devono indicare gli orari di uscita e di reingresso in istituto nell'arco della giornata ai fini dello svolgimento dell'attività per cui è concessa la semilibertà. Peraltro tale disciplina è del tutto uguale a quella prevista per il caso di ammissione al lavoro all'esterno, e anche per quanto concerne la regolamentazione delle conseguenze della trasgressione di tali prescrizioni - sanzioni disciplinari ed eventuale contestazione del reato di evasione (art. 51 ord. pen.) - si applica all'istituto della semilibertà una disciplina del tutto analoga a quella già esaminata per il lavoro all'esterno a cui pertanto si fa rinvio (246).
Soffermandosi in particolare sull'ipotesi di concessione della semilibertà per lo svolgimento di un'attività lavorativa, viene in rilievo l'art. 54 regol. penit. il quale dispone che i condannati e gli internati che siano ammessi a tale misura alternativa "esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà". Anche in tal caso, si ha una disposizione identica a quella dettata per il lavoro all'esterno, dal comma undicesimo dell'art. 48 regol. penit.; pertanto possono esserne tratte le medesime conclusioni: vi è un rinvio alla disciplina generale in materia di lavoro, la quale sarà applicabile al lavoro svolto in regime di semilibertà ancor più pacificamente di quanto fosse possibile per l'ammissione al lavoro all'esterno. Tale conclusione è sostenibile dal momento che mentre in quest'ultimo caso l'attività lavorativa diviene modalità di esecuzione della pena, per cui vi è una stretta interrelazione fra disciplina penitenziaristica e disciplina giuslavoristica, nel caso della semilibertà, l'attività lavorativa è mero presupposto di ammissione alla misura alternativa, verificandosi pertanto una minima sovrapposizione fra il piano dell'esecuzione della pena e quello dello svolgimento di un lavoro. Infatti se la ratio della semilibertà è consentire il reinserimento sociale del detenuto o internato, non sarebbero giustificabili divergenze e disparità di disciplina fra il lavoro svolto da un prestatore "libero" e il lavoro svolto da un "semilibero". Le uniche interferenze ammissibili concernono le deroghe alla disciplina giuslavorista strettamente necessarie ai fini della corretta esecuzione della pena, si pensi, come si è detto in riferimento al lavoro all'esterno, all'ipotesi del lavoro notturno - nel caso in cui il provvedimento di ammissione alla semilibertà preveda l'uscita dall'istituto penitenziario nelle ore diurne - o del lavoro straordinario, i quali dovranno essere esclusi per il semilibero stante l'obbligo di reingresso in istituto ad un orario predeterminato. Pertanto, per evitare di ripetersi e considerate le molteplici analogie al riguardo fra semilibertà e lavoro all'esterno, si può senz'altro ritenere applicabile la disciplina in materia di lavoro così come prevista ed esaminata con riferimento all'istituto di cui all'art. 21 ord. pen.
Un aspetto però, su cui sembra doveroso soffermarsi concerne il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto dal semilibero. L'art. 54 del regolamento penitenziario, confermando l'analoga disposizione prevista dal previgente regolamento, dispone che "i datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà [siano] tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore", inoltre "i datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale". Innanzitutto è dato ricavare da tale disposizione che, al pari di quanto è previsto per il lavoro all'esterno, anche nel caso di lavoro svolto in regime di semilibertà, il legislatore parla pacificamente di retribuzione, e non di mercede o remunerazione, per indicare il corrispettivo dovuto come controprestazione per il lavoro svolto dal semilibero. Quindi per la determinazione della retribuzione dovuta a tale categoria di lavoratori detenuti o meglio "semiliberi", non si può considerare applicabile la deroga al divieto di trattamento in peiusrispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva attraverso la fissazione del cosiddetto "minimo sindacale", di cui all'art. 22 ord. pen. che prevede al contrario la possibilità che la "mercede" dei detenuti sia determinata in misura inferiore fino ad un terzo rispetto al suddetto parametro di riferimento.
La disposizione di cui all'art. 54 prevede poi l'obbligo per i datori di lavoro nonché per lo stesso semilibero qualora svolga un'attività di lavoro autonomo (ultimo comma), di "versare la retribuzione alla direzione dell'istituto". Il medesimo obbligo era previsto dall'art. 51 del precedente regolamento penitenziario (D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431), sull'interpretazione del quale si sono avuti orientamenti divergenti da parte della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità. Infatti i giudici di merito hanno concordemente sostenuto che la previsione in questione non avrebbe dovuto ritenersi applicabile, sia perché avrebbe dovuto considerarsi "illegittima in quanto praeter legem" dal momento che si trattava di una norma non introducibile attraverso disposizioni di attuazione (247), sia perché avrebbe leso il fondamentale diritto del semilibero a percepire la retribuzione direttamente dal datore di lavoro (248). La violazione di tale fondamentale diritto si sarebbe verificata per due motivi in particolare: da un lato perché l'intermediazione del carcere contrasterebbe con la ratiodella semilibertà, che è quella di reinserire il detenuto nella società libera, in tal caso attraverso l'attività lavorativa, e riabituarlo ad esercitare quei diritti che in carcere sono affievoliti se non del tutto annullati (249); dall'altro perché nell'ipotesi di lavoro svolto all'esterno del carcere, in regime di semilibertà, l'amministrazione penitenziaria è soggetto del tutto estraneo al rapporto di lavoro che intercorre esclusivamente inter alios, pertanto non potrebbe avanzare alcun obbligo nei confronti del datore di lavoro (250).
La Corte di cassazione ha invece rigettato siffatta interpretazione sostenendo che l'obbligo per il datore di lavoro di versare la retribuzione alla direzione dell'istituto presso cui è ristretto il semilibero, non contrasta con la ratio della semilibertà, consistente nella finalità di reinserimento sociale, e "non sulla libera disponibilità del reddito da lavoro", al contrario il semilibero non può essere esonerato dal divieto di disporre di denaro entro l'istituto carcerario (art. 25 ord. pen.) (251). Proprio sulla base di tale presupposto inoltre la disposizione contenuta nel regolamento di attuazione deve considerarsi secundum legeme quindi legittima, visto che contiene norme che completano o integrano la legge (252).
L'interpretazione data dal giudice di legittimità è stata peraltro confermata prima da una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 1996, la quale per fronteggiare la prassi affermatasi in alcuni casi di versamento della retribuzione da parte dei datori di lavoro direttamente ai lavoratori in semilibertà, ha ribadito "il preciso dovere delle direzioni degli istituti penitenziari di far sì che i datori di lavoro versino alle medesime la retribuzione spettante al lavoratore semilibero" (253). Secondariamente anche il nuovo regolamento penitenziario, introdotto dal D.P.R. 230 del 2000 ha ribadito tale regola per cui il lavoratore semilibero non può percepire direttamente dal datore di lavoro la retribuzione che gli spetta, ma deve riceverla per il tramite della direzione dell'istituto penitenziario in cui è ristretto (art. 54). Ciò significa che la violazione della disposizione in questione, essendo determinata dal datore di lavoro su cui grava l'obbligo, e non dal semilibero, non potrebbe essere sanzionata con la revoca della misura alternativa (254).
L'ultima questione da considerare, su cui del resto vi è un'intersecazione fra profili penitenziaristici e aspetti giuslavoristici, è quella relativa alle reciproche interferenze fra cessazione del rapporto di lavoro e revoca della misura alternativa e viceversa. In linea generale la misura alternativa della semilibertà può essere revocata qualora "il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento" (art. 51 ord. pen.). Così come disciplinato in generale per tutte le misure alternative alla detenzione in istituto dall'art. 51 terord. pen., in via cautelare il magistrato di sorveglianza può disporre la sospensione del regime di semilibertà e ordinare l'accompagnamento del soggetto destinatario del provvedimento in istituto. Entro trenta giorni, quindi, il Tribunale di sorveglianza dovrà decidere se confermare la decisione del magistrato e quindi disporre la revoca della semilibertà ovvero consentirne la prosecuzione.
La sussistenza della idoneità al trattamento volto al reinserimento sociale attraverso il regime della semilibertà può essere valutata, fra gli altri dati rilevanti al riguardo, anche tramite la capacità del detenuto di mantenere il posto di lavoro presso il quale è stato occupato, dunque nel momento in cui il semilibero dà causa al licenziamento da parte del datore di lavoro, è evidente che conseguirà la revoca della misura alternativa per inidoneità al trattamento in libertà, seppure limitata nell'arco della giornata (255). Tuttavia in giurisprudenza è stata ritenuta legittima la revoca della semilibertà anche nell'ipotesi di licenziamento per cause oggettive, non attinenti alla condotta del prestatore di lavoro semilibero (256). Ma in questo ultimo caso non si applicherà la disciplina restrittiva di cui all'art. 58 quater, secondo il quale non può essere disposta l'ammissione ad un'altra misura alternativa, se non siano trascorsi tre anni dalla revoca della precedente (257).
Del resto appare quasi superfluo precisare che nell'ipotesi inversa, qualora vi sia la revoca della semilibertà per motivi diversi dalla perdita del posto di lavoro, del pari il rapporto di lavoro andrà incontro all'estinzione per impossibilità sopravvenuta da parte del prestatore di lavoro di eseguire la prestazione con evidente sovrapposizione dei due differenti rapporti, quello esecutivo della sanzione penale e quello invece del tutto privatistico di lavoro (258). In quest'ultimo caso dunque il detenuto subirà una duplice sanzione, andando incontro da un lato alla revoca della misura alternativa e dall'altro alla perdita di un'occasione di lavoro preziosa vista la scarsità di posti di lavoro disponibili all'interno dell'istituto penitenziario.
9.3 L'affidamento in prova ai servizi sociali
Oltre che ai fini dell'ammissione alla semilibertà, il reperimento e la concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa all'esterno del carcere possono consentire l'accesso ad un'ulteriore misura alternativa alla detenzione in istituto, quale l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge n. 354 del 1975. In realtà l'ammissione a tale beneficio non dipende solo ed esclusivamente dalla prospettiva di impiego in un'attività lavorativa, ma piuttosto dalla sussistenza di una valida ed effettiva possibilità di reinserimento sociale, che se del caso può essere offerta dall'impegno profuso dal beneficiario nello svolgimento della stessa. Infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali viene concesso laddove il periodo trascorso in libertà sia idoneo a "contribuire alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati" (art. 47 comma secondo ord. pen.). Il fine ultimo pertanto, della misura alternativa dell'affidamento, così come del resto degli altri benefici penitenziari, è la risocializzazione del condannato, ma a differenza delle altre misure, la peculiarità dell'affidamento in prova consiste nella sua essenza di vera e propria alternativa al carcere, visto che il periodo di pena per il quale è concesso il beneficio viene scontato facendo venire meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria (259).
Prima di soffermarsi sui rapporti fra reperimento da parte del detenuto o dell'internato di un'attività lavorativa da svolgere all'esterno dell'istituto e ammissione al beneficio dell'affidamento in prova, conviene brevemente esaminare le caratteristiche salienti di tale misura alternativa. Innanzitutto è pacifico che si tratti non di un'alternativa alla pena, ma piuttosto di una misura alternativa alla detenzione in istituto o meglio "una modalità di esecuzione della pena", nel senso che "viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dall'istituto, perché ritenuto più idoneo sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità, di prevenzione e di emenda, proprie della pena" (260). Per quanto riguarda poi le condizioni di ammissibilità, queste consistono essenzialmente nel quantum di pena da scontare, che non può essere superiore a tre anni (261), e nell'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del rischio di commissione di altri reati (262). A tal fine particolarmente importante è la modulazione delle prescrizioni da imporre al beneficiario della misura, la cui osservanza dovrà essere riscontrata dal servizio sociale [oggi Uffici di esecuzione penale esterna, UEPE], il quale svolge nel caso di specie una notevole funzione di ausilio nonché di controllo (263). Le prescrizioni dovranno riguardare "i rapporti con il servizio sociale [rectius UEPE], la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di frequentare determinati locali ed il lavoro" (art. 47 comma quinto), e potranno essere eventualmente modificate nel corso dell'esecuzione dal magistrato di sorveglianza, qualora se ne presenti la necessità.
L'accesso al beneficio può avvenire dalla detenzione in istituto, nel qual caso dovrà essere disposto a seguito delle informazioni reperite attraverso la cosiddetta "osservazione scientifica della personalità" condotta per almeno un mese (264), oppure direttamente dalla libertà (art. 656 c.p.p.) (265), al fine di evitare qualsiasi contatto del condannato con l'ambiente carcerario, qualora il soggetto presenti le condizioni idonee a far presagire il reinserimento sociale e la prevenzione della recidiva. In ambo i casi la decisione è di competenza del Tribunale di sorveglianza.
La giurisprudenza nelle decisioni in ordine alla richiesta di concessione di tale misura alternativa, così come per gli altri benefici, ha costantemente applicato il criterio di gradualità, secondo il quale il detenuto può essere ammesso al beneficio qualora questo risponda alle specifiche esigenze rieducative richieste dal programma trattamentale, e dunque quanto più viene meno o si attenua nel corso del trattamento la pericolosità sociale del detenuto, tanto più questi potrà beneficiare di misure che consentono un maggior spazio di libertà personale, ed eventualmente un maggiore distacco dall'istituto di detenzione (266). Così laddove il detenuto o l'internato abbia la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno e sia nelle condizioni di beneficiare di una misura alternativa, l'ammissione alla semilibertà o piuttosto all'affidamento in prova dipenderà dalla valutazione delle concrete possibilità di reinserimento offerte dall'una o dall'altra misura in ordine alle peculiari esigenze del soggetto destinatario. In particolare in giurisprudenza si è sostenuto che "per la concessione della semilibertà occorre accertare che esista un andamento positivo in progresso del trattamento rieducativo in misura tale da aprire alla prospettiva di una prognosi che il lavoro esterno possa portare al reinserimento effettivo nel tessuto sociale", invece per l'affidamento in prova non è sufficiente tale previsione ma "occorre un quid pluris, rappresentato dalla prova che la partecipazione all'attività educativa in carcere abbia raggiunto una soglia di ripensamento tale da essere definitivamente cessato il collegamento con i modelli culturali che avevano determinato manifestazioni concrete di devianza" (267). Dunque per l'ammissione all'affidamento in prova non è sufficiente la prospettiva di un lavoro all'esterno, ma è necessario un accertamento più penetrante in ordine ai risultati e ai progressi conseguiti dal trattamento penitenziario e alle concrete possibilità di reinserimento sociale del richiedente.
Al contrario, dinanzi all'"ossessione lavoristica innescata da alcune prassi giurisprudenziali della Magistratura di sorveglianza" (268), che ha portato a ritenere necessario lo svolgimento di un'attività lavorativa a fini dell'ammissione all'affidamento in prova, la giurisprudenza di legittimità ha sovente e costantemente escluso che la possibilità di svolgere un lavoro costituisca elemento indispensabile per la concessione dell'affidamento in prova. In particolare:
"in tema di affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa può certamente costituire un mezzo di inserimento sociale valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa, ma la sua mancanza non è ostativa alla concessione del beneficio, trattandosi di un parametro apprezzabile in relazione a tutti gli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice, quali i precedenti penali, la condotta inframuraria e la partecipazione al trattamento rieducativo" (269).
Coerentemente con questa impostazione giurisprudenziale, è stata considerata illegittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova motivata sul presupposto che sarebbe mancata l'allegazione della documentazione volta a costituire prova dell'esistenza di un impiego lavorativo per l'interessato (270). Tuttavia il fatto che lo svolgimento di un lavoro non costituisca presupposto essenziale per l'ammissione all'affidamento in prova, non esclude che "l'idoneità di un'attività lavorativa al reinserimento del soggetto nella società e alla sua rieducazione sia momento importante nel valutare l'opportunità dell'affidamento in prova" (271). Sulla base di tale presupposto è stato ritenuto legittimo il rigetto di un'istanza di affidamento in prova a seguito della valutazione della inidoneità del lavoro, a cui il richiedente avrebbe dovuto dedicarsi, al perseguimento della finalità del reinserimento sociale (272).
L'attività lavorativa svolta dal detenuto affidato in prova è parificabile tout court alle prestazioni lavorative di qualsiasi altro soggetto libero, pertanto si applicherà senza alcuna eccezione la generale disciplina in materia di rapporti di lavoro di diritto privato, fatti salvi gli eventuali vincoli imposti dall'osservanza delle prescrizioni concernenti il lavoro. Conseguentemente spetteranno al prestatore di lavoro affidato in prova gli stessi diritti e le stesse tutele previste in via generale per i lavoratori liberi, del pari di quanto del resto avviene nel caso di lavoro svolto in regime di semilibertà, con la differenza che nel caso di specie non sussisterà neppure quella unica deroga alla generale disciplina giuslavoristica, per cui il datore di lavoro del semilibero è gravato dall'obbligo di versare la retribuzione alla direzione dell'istituto anziché direttamente al prestatore di lavoro, dal momento che il beneficiario dell'affidamento in prova è in completa libertà, non intrattenendo più alcun rapporto con l'istituto detentivo, a differenza del detenuto ammesso alla semilibertà, che ha invece l'obbligo del rientro serale in carcere.
Tornando alla disciplina penitenziaristica, il buon esito della misura alternativa dell'affidamento in prova, a cui può contribuire certamente l'impegno costante in un'attività lavorativa, comporta l'estinzione della pena e di qualsiasi effetto penale. Al contrario laddove il beneficiario abbia dato luogo alla revoca della misura, avendo tenuto un comportamento che sia apparso "incompatibile con la prosecuzione della prova" in quanto "contrario alla legge o alle prescrizioni dettate" (273), il periodo trascorso in affidamento secondo una giurisprudenza pacifica potrà essere considerato come periodo di esecuzione della pena, in tutto o in parte, a seconda della valutazione più o meno positiva del globale comportamento tenuto dal soggetto durante il tempo trascorso in affidamento, nonché delle limitazioni patite e delle restrizioni osservate (274).
Al pari di quanto avviene nel caso della semilibertà, anche nell'ipotesi di affidamento in prova ai servizi sociali concesso ai fini dello svolgimento da parte del detenuto di un'attività lavorativa extra moenia, si ha una parziale sovrapposizione fra disciplina penitenziaristica e disciplina giuslavoristica in merito al profilo della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti qualora tale evento si verificasse per cause dipendenti dalla condotta del prestatore di lavoro affidato, in particolare nell'ipotesi in cui tale comportamento fosse tenuto in violazione delle prescrizioni impartite, l'eventuale licenziamento avrebbe notevoli ripercussioni sul regime penitenziario, in quanto comporterebbe innanzitutto la revoca della misura e secondariamente potrebbe indurre ad una valutazione negativa del periodo trascorso in affidamento, così che lo stesso non verrebbe computato come periodo di pena espiata. Al contrario laddove l'affidato andasse incontro ad un licenziamento per cause oggettive, non dipendenti dunque dalla propria condotta, non potrà essere disposta la revoca della misura alternativa, ma dovrà essere decisa la mera "cessazione" della stessa (art. 70 comma primo ord. pen.), in modo che non sia conseguentemente applicabile il regime restrittivo di cui all'art. 58 quater, disposizione per cui a seguito della revoca di una misura alternativa alla detenzione devono trascorrere almeno tre anni prima che lo stesso detenuto possa essere ammesso ad un ulteriore beneficio penitenziario (275). Ma soprattutto occorre rilevare che la cessazione dell'affidamento in prova, nel caso in cui venga meno l'attività lavorativa, non comporta una valutazione del periodo trascorso in misura alternativa, che pertanto dovrà essere considerato tout court come quantum di pena espiata.
Al termine dell'analisi della normativa in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, si può fondatamente sostenere come tale misura alternativa sia stata pensata al fine di consentire al detenuto di avere un'effettiva chance di ripensamento del proprio trascorso delinquenziale e dunque di volere approfittare dell'aiuto fornitogli ai fini del reinserimento sociale (276), attraverso un percorso trattamentale che ha la peculiarità di svolgersi al di fuori dell'istituto penitenziario, in un regime di pressoché totale libertà. Quindi per quel che concerne l'argomento di nostro interesse, ovvero il problema del lavoro dei detenuti e degli internati, viene in rilievo che a differenza degli istituti del lavoro all'esterno e della semilibertà che hanno come presupposto, indispensabile nel primo caso o quantomeno saliente nel secondo, lo svolgimento di un'attività lavorativa, nell'ipotesi di ammissione all'affidamento in prova, il nucleo della misura alternativa sta nella possibilità di reinserimento sociale, indipendentemente dallo strumento utilizzato per conseguire tale obiettivo, che soltanto eventualmente può consistere nel lavoro. Concludendo si può pertanto affermare che solo in limine, la misura alternativa dell'affidamento in prova rileva come modalità attraverso la quale il detenuto può essere ammesso a svolgere un'attività lavorativa al di fuori dell'istituto penitenziario. E ciò nonostante qualora ciò avvenga, si tratta dell'unica ipotesi in cui il lavoro svolto del condannato in affidamento è del tutto parificabile in punto di diritti, tutele e obblighi al lavoro svolto da qualsiasi prestatore di lavoro libero.
Note
1. Sebbene l'art. 27 comma terzo faccia espressa menzione della sola funzione rieducativa della pena, la concezione dominante, fatta propria anche dalla Corte Costituzionale è quella cosiddetta "polifunzionale", secondo la quale il principio rieducativo "dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto" (sent. n. 12 del 1966); infatti secondo la Corte "non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda alla radice della pena" (sent. n. 264 del 1974). Dunque alla luce della giurisprudenza costituzionale la pena assolve attraverso il bilanciamento fra le stesse, una pluralità di funzioni: rieducativa, general-preventiva, special-preventiva, retributiva. Cfr. in tal senso F. Palazzo, Introduzione ai principi del diritto penale, Giappichelli editore, Torino, 1999, p. 87.
Senza addentrarsi nel dibattito filosofico che ha contrapposto la Scuola Classica alla Scuola Positiva, sinteticamente si può dire che la nostra Carta Costituzionale accoglie un'idea 'laica' di rieducazione: non come rigenerazione morale del reo il quale avendo commesso il reato avrebbe dimostrato disprezzo nei confronti di una presunta morale 'comune', ma semplicemente come riadattamento sociale del soggetto, il quale attraverso il trattamento rieducativo, basato sul presupposto della pericolosità, viene abituato all'osservanza delle regole sociali. In definitiva la rieducazione non ha come obiettivo l'interiorizzazione dei valori sociali dominanti, ma è sufficiente a tal scopo la mera obbedienza alle regole sociali, in genere resa maggiormente appetibile attraverso la prospettazione dei vantaggi che ne conseguono e dall'offerta di possibilità di affermazione della propria personalità; Ivi, p. 77.
Per trattamento penitenziario, che ai sensi dell'art. 13 ord. pen. deve essere individualizzato, si intende l'offerta di opportunità al detenuto volta a favorirne la reintegrazione sociale; cfr. art. 1 regolamento penitenziario (D.P.R. 230 del 2000); S. Bellomia, Ordinamento penitenziario, in "Enciclopedia Giuridica Treccani", Il Veltro, Roma, 1991.
2. Presunzione che si ricava dall'art. 27 comma secondo, Cost.: "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
3. Si tratta della Raccomandazione R (2006) 2, volta ad aggiornare il decalogo delle "regole minime europee" a seguito degli sviluppi e dei cambiamenti che dal 1987 ad oggi hanno interessato le politiche penali, la giurisprudenza in materia di diritto penitenziario e più in generale, la gestione delle carceri in Europa.
4. V. Grevi, Esecuzione penitenziaria e rieducazione del condannato nelle regole minime per il trattamento dei detenuti, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura penale" 1974, p. 540; cfr. C. Defilippi, D. Bosi, Il sistema europeo di tutela del detenuto, Giuffré, Milano, 2001, pp. 5 e ss.
5. V. Grevi, op. cit., pp. 537 e ss.
6. Cfr. sul punto A. Martelli, P. Zurla (a cura di), Il lavoro oltre il carcere, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 30 e ss.
7. Cfr. P. Troncone, Manuale di diritto penitenziario, Giappichelli editore, Torino, 2006, p. 169; M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli editore, Torino, 2002, p. 173.
8. Si fa riferimento ai detenuti che abbiano la cittadinanza italiana, in quanto solo nei loro confronti possono valere i doveri di solidarietà economica, sociale e politica menzionati nell'art. 2 della Costituzione italiana. Ciò non esclude che anche nei confronti dei detenuti 'stranieri' e in particolare extracomunitari debba essere attuato un trattamento penitenziario avente al pari il suo fulcro saliente nel lavoro. Vd. infra § 9.1.1.
9. Al 30 giugno 2007 risulta che il 29,1% dei reati ascritti ai detenuti presenti nei vari istituti penitenziari italiani, fossero reati contro il patrimonio, seguiti dai reati contro la persona (16,5%), dai reati attinenti alle armi (16%), dai reati attinenti alla droga (15,1%) e infine da una molteplicità di varie categorie di reati (contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, previsti dalla legge sull'immigrazione etc.). I dati riportati si rifanno alle statistiche condotte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.).
10. Cfr. A. Raciti, Le attività lavorative svolte durante l'esecuzione di pene privative della libertà personale, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" I-III, 2001, pp. 265 e ss.
11. Così F. Mantovani, Il problema della criminalità, Cedam, Padova, 1984, p. 438.
12. Cfr. G. Vidiri, Il lavoro carcerario: problemi e prospettive, in "Lavoro 80", 1986, p. 50. Gli effetti degradanti della detenzione possono essere brillantemente compendiati nella parola "prigionizzazione" coniata dal sociologo Clemmer negli anni Trenta dello scorso secolo per indicare quel processo di progressivo adattamento e acquisizione della subcultura carceraria, che è tanto più intenso e veloce quanto più fievoli e sporadici sono i legami e i contatti con il mondo esterno. Il pericolo del processo di prigionizzazione è che potrebbe portare ad esiti irreversibili, "è sufficiente per rendere un uomo un membro caratteristico della comunità penale e probabilmente per distruggere la sua personalità in modo tale da rendere impossibile un suo successivo felice adattamento ad ogni altra comunità". Il rischio maggiore comunque deriva dal contatto e dalla conoscenza di soggetti dal passato criminale maggiormente marcato, i quali potrebbero divenire modelli per i detenuti caratterialmente più deboli, così da innescare un meccanismo di fomentazione e riproduzione degli impulsi criminali, proprio nel luogo teoricamente deputato ad eliminare o quantomeno attenuare tale fenomeno. Cfr. D. Clemmer, The prison community, The Christopher Publishing House, Boston, 1941, trad. it. parziale in E. Santoro, Carcere e società liberale, Giappichelli editore, Torino, 2004, pp. 210 e ss.
13. I lavori forzati sono storicamente consistiti in attività lavorative minimamente utili o produttive o in alcuni casi, in attività svolte con mezzi e modi totalmente inadeguati al solo scopo di rendere maggiormente doloroso il periodo di privazione della libertà personale, accompagnando alla sofferenza psichica anche la fatica fisica. Sono per esempio rimasti famosi alcuni dei lavori forzati previsti dalle leggi inglesi del diciottesimo secolo, quali il tread mill (ruota da muoversi con i piedi), lo shot drill (trasporto di palle di cannone da destra a sinistra e viceversa), il crank (girare per ore una manovella) e lo stone breaking (spaccare pietre); cfr. R. Rustia, Il lavoro dei detenuti, in "Giurisprudenza di merito", 1973, p. 73. In Italia, i lavori forzati sono stati aboliti dal Codice penale Zanardelli del 1889.
14. Cfr. G. Vidiri, op. cit., p. 51.
15. Per un maggiore approfondimento sull'argomento si rimanda oltre, vd. infra, § 6. Perché il lavoro penitenziario possa essere disciplinato in maniera conforme al principio di uguaglianza, oltre che in punto di retribuzione, l'art. 36 Cost. di cui si tratta dovrebbe essere attuato anche in punto di altri salienti diritti del lavoratore, quali la durata massima della giornata lavorativa, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite ed irrinunciabili (secondo e terzo comma).
16. Si è già accennato alla previsione contenuta nell'art. 15 terzo comma ord. pen. secondo la quale gli imputati non devono né possono essere sottoposti all'obbligo del lavoro.
17. Naturalmente sarebbe auspicabile che ogni detenuto prenda coscienza della propria situazione e alimenti la volontà di approfittare del periodo di detenzione per rivedere la propria condotta sociale, trovando gli strumenti e gli agganci, per quanto sia possibile, affinché una volta tornati al mondo libero, si abbia una concreta prospettiva di vita alternativa all'attività criminale. Questo dovrebbe essere il senso di ogni percorso trattamentale, il quale ovviamente non può che fallire se non accompagnato da serie e fondate intenzioni del diretto interessato. Tuttavia laddove il detenuto dimostri di non voler partecipare al trattamento, e nel caso di specie, di non voler svolgere alcuna attività lavorativa, saranno possibili sanzioni disciplinari nonché ripercussioni negative in punto di valutazione del comportamento in istituto ai fini dell'accesso ai benefici e alle misure premiali, quali in primo luogo la liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen.
18. Cfr. F. Fiorentin, A. Marcheselli, L'ordinamento penitenziario, UTET, Milano, 2005, pp. 14 e ss.
19. Per l'esame della disciplina in materia di redazione delle liste lavoranti e assegnazione dei posti di lavoro si rimanda infra al paragrafo 4.
20. Il codice penale del 1930 prevedeva e tuttora prevede che le pene dell'ergastolo (art. 22), della reclusione (art. 23) e dell'arresto (art. 25), debbano essere scontate "con l'obbligo del lavoro".
21. A proposito del regolamento penitenziario del 1931 è stato osservato come l'obbligo del lavoro in esso previsto lasciasse trapelare "i principi della locatio hominis dell'età precapitalistica per cui se non la stessa persona umana, almeno il corpo del lavoratore è oggetto del rapporto di lavoro. L'amministrazione penitenziaria, infatti, esercita un potere, di disporre dell'attività lavorativa dei reclusi, pressoché illimitato", così testualmente U. Romagnoli, Il lavoro nella riforma carceraria, in M. Cappelletto, A. Lombroso, Carcere e società, Marsilio, Venezia, 1976, p. 93. Pur non volendo arrivare a considerazioni tanto estreme, non si può negare che l'impostazione del regolamento del 1931 così come del codice Rocco fosse quella di considerare il lavoro come obbligo gravante sul detenuto in quanto pena accessoria alla detenzione. La concezione prettamente affittiva del lavoro penitenziario emergeva più che mai chiaramente nel dibattito relativo all'introduzione di un qualche corrispettivo per l'attività prestata: il ministro Alfredo Rocco, come risulta dalla Relazione al progetto definitivo di nuovo codice penale, affermò che: "se il lavoro costituisce parte integrante della pena, esso manifestamente non può fondare un diritto a retribuzione o salario"; cfr. R. Ciccotti, F. Pittau, Il lavoro in carcere. Aspetti giuridici e operativi, Franco Angeli, Milano, 1987, pp. 30 e ss.
22. In tal senso G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 140 e ss; M. Vitali, Il lavoro penitenziario, Giuffrè, Milano, 2001, p. 21; G. Ichino, Sindacato e questione carceraria, in M. Cappelletto, A. Lombroso, op. cit., p. 131.
23. R. Pessi, Il rapporto di lavoro del detenuto: a proposito della concessione in uso della manodopera dei detenuti ad imprese private appaltatrici, in "Diritto del lavoro", 1978, p. 104.
24. G. Pera, Aspetti giuridici del lavoro carcerario, in "Il foro italiano", 1971, p. 65.
25. Infatti per integrare la clausola del caso di impossibilità basta all'amministrazione penitenziaria addurre la scarsità di posti di lavoro reperibili oppure la carenza di personale da impiegare nella vigilanza sui detenuti lavoranti.
26. Più esplicita è la disposizione di cui all'art. 10 terzo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966: "il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale".
27. Secondo l'allora sottosegretario on. Pellicani "il punto più qualificante della riforma è il lavoro che viene a perdere il carattere affittivo e di obbligo penale"; tanto si evince dal verbale di seduta del Senato nel giorno 10 marzo 1971, Ivi, p. 64.
28. Tale interpretazione può essere ulteriormente sostenuta citando l'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, che proibisce qualsiasi forma di schiavitù e lavoro forzato, prevedendo che nessuno possa essere obbligato a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. Tuttavia al paragrafo 2 stabilisce che "non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione [ovvero a seguito di un legittimo procedimento penale, NdA] o durante il periodo di libertà condizionale".
Sul punto si è espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 giugno 1982, che ha sostenuto la legittimità e la conformità alla Convenzione europea di cui sopra, delle disposizioni degli ordinamenti interni che prevedano come obbligatorio il lavoro penitenziario purché sussistano due condizioni: l'obbligo del lavoro può essere imposto solamente alle persone detenute regolarmente e legittimamente, a seguito di una condanna loro inflitta da un tribunale competente. La seconda condizione è che il lavoro penitenziario non deve presentare alcuna similitudine con le passate e disumanizzanti forme di lavori forzati, pertanto deve perseguire come unico fin, quello della rieducazione e della risocializzazione del detenuto. Cfr. T. Orsi Vergati, Note in tema di lavoro obbligatorio per i detenuti, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", II, 1983, pp. 842 e ss
E ancora si possono citare l'art. 71 delle Regole minime per il trattamento dei detenuti (Ris. O.N.U. del 1955): "tutti i detenuti sono sottoposti all'obbligo di lavoro, tenuto conto della loro idoneità fisica e mentale", e il parallelo art. 71 delle Regole penitenziarie europee secondo cui "i condannati possono essere soggetti all'obbligo di lavoro".
29. In tal senso A. Raciti, op. cit., p. 274; G. Pera, op. cit., p. 65; R. Pessi, op. cit., p. 104.
30. Al riguardo è stato sottolineato come il legislatore abbia erroneamente inteso l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro come due differenti misure di sicurezza, in realtà dal combinato disposto degli articoli 215 e 218 c.p., si ricaverebbe che si tratta di un'unica misura di sicurezza eseguibile in due modalità differenti a seconda delle capacità e attitudini del soggetto che vi è sottoposto; così G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 140.
31. L'art. 77 regol. penit. prevede fra altre due fattispecie di infrazioni disciplinari attinenti allo svolgimento di un'attività lavorativa, quali l'"abbandono ingiustificato del posto di lavoro" e la "simulazione di malattia".
32. L'applicazione di una sanzione disciplinare avviene sulla base di un preciso procedimento, disciplinato dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dal successivo regolamento per fugare qualsiasi possibilità di arbitrio al riguardo da parte dell'amministrazione penitenziaria. Innanzitutto è previsto che "i detenuti e gli internati non possano essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento" (art. 38 ord. pen.). Il procedimento è avviato sulla base di un "rapporto" redatto dall'operatore penitenziario che ha conoscenza dell'infrazione disciplinare; il rapporto è poi trasmesso al direttore dell'istituto, il quale "contesta l'addebito all'accusato sollecitamente e non oltre dieci giorni, informandolo del diritto ad esporre le proprie discolpe" (art. 81 regol. penit.). A questo punto se si tratta delle sanzioni che possono essere applicate direttamente dal direttore, ovvero il richiamo e l'ammonizione (art. 39 ord. pen.), questi convoca l'accusato dinanzi a sé per la "decisione disciplinare". Al contrario per gli altri tipi di sanzione, quali l'esclusione dalle attività ricreative e sportive, l'isolamento e l'esclusione dalle attività in comune, la decisione deve essere presa dal consiglio di disciplina, composto dal direttore, dal sanitario e dall'educatore (art. 40 ord. pen.). In entrambe le ipotesi "l'accusato ha facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe" (art. 81, quinto comma, regol. penit.); la sanzione infine è applicata con provvedimento motivato che deve essere "tempestivamente" portato a conoscenza del detenuto e del magistrato di sorveglianza.
33. Ivi, p. 142.
34. Ibidem.
35. Cfr. A. Raciti, op. cit., pp. 272-273.
36. Tale disposizione è stata confermata anche dalla successiva Risoluzione R (2006) 2 laddove al paragrafo 26.3 è stabilito che: "as far as possible, the work provided shall be such as will mantaine or increase prisoners' ability to earn a living after release".
37. Così G. Pera, op. cit., p. 60.
38. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 145. Una siffatta impostazione rischierebbe inoltre di celare un'ideologia tale per cui il lavoro viene considerato come bene in sé, attribuendogli una "funzione medicinale-rieducativa", a prescindere alle modalità con cui l'attività è svolta, così da legittimare in sostanza, nuove forme di lavori forzati, minimamente utili e produttivi.
39. Si tratta delle attività tipiche di ogni carcere, le quali danno vita alle figure degli 'scrivani', 'cucinieri', 'scopini', 'barbieri', 'magazzinieri', ecc.
40. Le lavorazioni più frequenti sono volte alla produzione di coperte, alla confezione di vestiario e di biancheria per agenti di custodia e per detenuti, e ad attività di falegnameria. Il legislatore, come verrà approfondito nel prosieguo, aveva in mente l'idea di trasformare il carcere in fabbrica, introducendo per l'appunto le cosiddette "lavorazioni"; nella realtà dei fatti, invece, stante l'inadeguatezza e l'arretratezza tecnologica della produzione nonché l'antieconomicità, queste hanno finito con l'essere rivolte non al mercato esterno, ma alla sola amministrazione penitenziaria, divenendo pertanto in tutto autoreferenziali.
41. Per gli approfondimenti relativi alle modalità di organizzazione del lavoro penitenziario e all'istituto del lavoro all'esterno, si rinvia oltre rispettivamente ai paragrafi 7 e 9.
42. Il previdente regolamento penitenziario (R.D. n. 787 del 1931) prevedeva un tirocinio "gratuito" per tutti i detenuti che successivamente sarebbero stati ammessi a qualsiasi lavoro retribuito (art. 124).
43. In definitiva l'apprendistato e il tirocinio avrebbero la stessa disciplina, essendo termini utilizzati dal codice civile come sinonimi. La disciplina dell'apprendistato è infatti contenuta negli artt. 2130 e ss. c.c., laddove si fa indifferentemente riferimento al tirocinio e all'apprendistato, e negli artt. 47 e ss. del d.lgs. 276 del 2003 (cosiddetta "riforma Biagi"). In particolare fra le tre tipologie di apprendistato introdotte dalla riforma, quella che viene in rilievo nel caso di specie è l'"apprendistato professionalizzante" (art. 49), finalizzato al "conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali". L'ostacolo principale ad un'estensione de plano della disciplina in materia di apprendistato al tirocinio penitenziario sta per l'appunto nei limiti di età previsti per il primo che di certo non possono essere applicati in carcere dal momento che la maggior parte della popolazione detenuta ha un'età notevolmente superiore ai ventinove anni. Al 30 giugno 2007, i detenuti con età inferiore ai trenta anni risultavano essere pari al 18,2 % del totale dei presenti; il dato è ripreso dalle statistiche del D.A.P. di cui sopra.
44. Cfr. G. Pera, op. cit., p. 65; G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 150. In particolare questi ultimi autori hanno sostenuto la necessità di fare riferimento alla disciplina sull'apprendistato per evitare che "con il pretesto del tirocinio si crei negli istituti penitenziari una sottocategoria di lavoratori", ibidem.
45. In tal senso F. Gianfrotta, Gli obiettivi dell'amministrazione penitenziaria, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", I, 1999, pp. 37 e ss.
46. Cfr. M. Castaldo, La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative, Jovene editore, Napoli, 2001, pp. 112 e ss.
In realtà lo stesso tipo di suggerimenti hanno portato alla stesura e conseguente approvazione della legge n. 193 del 22 giugno 2000 (cosiddetta "legge Smuraglia"), la quale si è proposta l'obiettivo di incentivare l'offerta di lavoro a detenuti ed internati da parte di cooperative sociali ed imprenditori pubblici e privati. Gli accorgimenti previsti dalla legge Smuraglia sono stati essenzialmente di due tipi: da un lato è stata modificata la legge sulle cooperative sociali (n. 381 del 1991) ampliando la categoria dei "soggetti svantaggiati" in modo da ricomprendervi anche i detenuti e gli internati rietretti negli istituti penitenziari, nonché i condannati ammessi alle misure alternative e al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. pen.. Dall'altro lato si è cercato di sollecitare l'interesse e l'attenzione delle cooperative sociali in particolare, al problema del lavoro penitenziario, attraverso la previsione di sgravi fiscali ed agevolazioni previdenziali nel caso di assunzione di detenuti od internati, incentivi già peraltro previsti per il caso di assunzione di soggetti rientranti nell'ambito della variegata categoria di "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 l. 381 del 1991. Cfr. infra cap. 2.
47. In tal senso M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2006, p. 130.
48. Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto per periodi determinati, ma rinnovabili, nei confronti di soggetti che "con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti", che "con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti e internati", che "nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti". Inoltre tale regime può essere disposto anche in via preventiva "fin dal momento dell'ingresso in istituto" sulla base dei comportamenti tenuti dai soggetti che vi sono sottoposti, in precedenti carcerazioni o in altri istituti di provenienza nonché perfino durante lo stato di libertà. Il regime di sorveglianza paricolare è adottato con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria che a sua volta è comunicato al magistrato di sorveglianza affinché eserciti il suo potere di vigilanza.
Il regime di sorveglianza particolare comporta "le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole del trattamento previste dell'ordinamento penitenziario" (art. 14 quater ord. pen.). Affinché sia possibile un minimo controllo sulla notevole discrezionalità così lasciata all'amministrazione penitenziaria, il legislatore ha previsto che avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, possa essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero (art. 14 ter). Per ulteriori approfondimenti cfr. T. Padovani, Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità, in V. Grevi (a cura di), L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986 n. 663), Cedam, Padova, 1988, pp. 51 e ss.
49. Cfr. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 148.
50. Ivi, p. 147.
51. Il cosiddetto "part-time verticale" è previsto dall'art. 1 del d. lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 laddove è definito come quel "rapporto di lavoro in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno".
52. Cfr. supra § 2. L'utilizzo del lavoro part-time comporta due conseguenze: un abbassamento del livello economico-monetario delle mercedi che, come vedremo meglio nel prosieguo, vengono determinate in maniera proporzionale alle ore effettive di lavoro svolto (art. 20 ord. pen.), e una "mistificazione" dei dati aggregati sui detenuti lavoranti, i quali sono sempre inficiati dal fatto di annoverare anche i prestatori di lavoro part-time che sebbene siano effettivamente lavoranti, comunque svolgono la propria attività lavorativa per periodi di tempo limitati.
53. Lettera del DAP, prot. n. 445476 del 14 novembre 2003. Peraltro tali dati possono essere riscontrati con quelli ufficialmente pubblicati dal Ministero della Giustizia, pienamente corrispondenti.
54. Il gruppo di osservazione e trattamento (in acronimo GOT) è previsto esplicitamente nell'art. 29 secondo comma del regolamento, in cui è stabilito che debba essere "presieduto dal direttore dell'istituto" e composto "dal personale e dagli esperti" che svolgono l'attività di osservazione scientifica della personalità "diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione" (art. 27 regol. penit.) e finalizzata alla formulazione del programma individualizzato di trattamento ex art. 13 ord. pen. Dunque fanno parte del GOT oltre al direttore, anche gli educatori e gli assistenti sociali dipendenti dagli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), nonché "professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica" (art. 80 quarto comma ord. pen.) di cui l'amministrazione penitenziaria può avvalersi tramite incarichi giornalieri.
La circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 e la successiva nota integrativa n. 0217584 del 2005, definiscono il GOT come quel "gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso", aprendo il penitenziario alla collaborazione di soggetti esterni, anche e soprattutto del privato sociale. La medesima circolare prevede che nel GOT avvenga"lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell'osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili se non contraddittori, e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell'educatore penitenziario". Questo ultimo ha infatti il ruolo di segretario tecnico del gruppo di osservazione (art. 29 u.c. regol. penit.), con la funzione principale di assicurarne il coordinamento. Inoltre l'educatore "quale segretario tecnico è l'elemento di continuità tra il GOT edil gruppo interprofessionale che convenzionalmente è stato definito dalla circolare del 2003 come équipe" (nota DAP del 2003). L'équipeè invece il "gruppo ristretto avente rilevanza esterna, presieduto dal direttore dell'istituto, e di cui fanno parte l'educatore, l'assistente sociale incaricato del caso, l'esperto [di cui all'art. 80 quarto comma ord. pen., NdA] e l'ispettore comandante", quindi soltanto i soggetti istituzionalmente competenti alla gestione dell'esecuzione della pena e "che hanno pertanto competenza a definire formalmente la sintesi/aggiornamento dell'osservazione, ed un'ipotesi di trattamento intra o extra murario, che certamente - se ben funziona il coordinamento di cui sopra - trarrà origine dal lavoro di tutti gli operatori del GOT" (nota del 2003).
55. L'art. 20 ottavo comma fa ancora riferimento alle commissioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti, le quali sono state sostituite dai Centri per l'impiego, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 469 del 1993, di attuazione della legge delega n. 59 del 1997, volta al decentramento delle funzioni e delle competenze delle amministrazioni pubbliche, e nel caso di specie all'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di governo del mercato del lavoro; cfr. E. Ghera, Diritto del lavoro, Cacucci editore, Bari, 2004, pp. 238 e ss.
56. Saranno esaminati nel prosieguo le conseguenze e i vantaggi, soprattutto in punto di tutele previdenziali, che derivano ai detenuti e agli internati dall'iscrizione nelle liste di collocamento, vd. § 6.3.2.
57. Ciò non significa però escludere la tutela 'giurisdizionale' dei diritti dei detenuti, sent. Corte Cost. n. 26 dell'8 febbraio 1999, in "Il foro italiano", I, 1999, pp. 1118 e ss. In questa sede non si intende affrontare compiutamente il tema della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, che sarà oggetto di specifica trattazione in seguito, vd. oltre § 6.5.
58. Così M. Signorini, Lavorare in carcere e accesso al lavoro esterno, lezione tenuta al corso Law in action. Corso di formazione per il volontariato penitenziario, Firenze, 9 giugno 2007, non pubblicata.
59. Cfr. A. Raciti, op. cit., p. 282.
60. Cfr. quanto riportato con riferimento al dibattito da G. Pera, op. cit., p. 59, e R. Pessi, op. cit., p. 103-104.
61. Cfr. A. Raciti, op. cit., p. 277.
62. Cfr. E. Goffman, Asylums, Anchor Books, New York, 1961, trad. it. Einaudi, Torino, 1968, pp. 39 e ss.
63. Il riferimento più frequente è stato alle assunzioni obbligatorie previste per particolari categorie di lavoratori, la cui disciplina è oggi contenuta nella legge n. 68 del 1999, e all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che pone il divieto di appalto di manodopera e come conseguenza della violazione di tale divieto, la presunzione legale secondo cui il rapporto di lavoro intercorre fra il prestatore di lavoro e l'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato la loro prestazione.
64. In tal senso R. Pessi, op. cit., p. 107; R. Rustia, op. cit., p. 78; A. Raciti, op. cit., p. 276.
65. Cfr. Corte Cass., sez. lav., 25 gennaio 1992, n. 824, generoso c. Edizioni Meridionali s.p.a., in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 1993.
66. Certamente sussiste la fondamentale differenza per cui l'imputato fin quando non sia condannato con sentenza definitiva non possa essere considerato colpevole e sottoposto al trattamento rieducativo. Ma al di là di tale aspetto che attiene all'esecuzione della pena, in niente cambia il rapporto di lavoro in senso stretto, in quanto anche se effettuato in funzione trattamentale, deve pur sempre e a maggior ragione, trattarsi di rapporto sinallagmatico consistente nell'obbligazione di svolgere un'attività lavorativa che trova come controprestazione una remunerazione da parte di colui che beneficia del lavoro svolto, altrimenti, come si è più volte avvertito, si rischierebbe di ripristinare di fatto i cosiddetti "lavori forzati". Cfr. R. Rustia, op. cit., p. 78; R. Pessi, op. cit., p. 104.
67. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 150; G. Vidiri, op. cit., p. 52; G. Pera, Diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2003, p. 439; F. Mazziotti, Diritto del lavoro, Jovene editore, Napoli, 1976, p. 130. In senso contrario G. Catelani, Il codice penitenziario, Laurus Robuffo, Roma, 2003, p. 83.
68. In tal senso A. Margara, Il lavoro del detenuto, in "Quale giustizia" 1971, pp. 332. In particolare nel saggio testé menzionato, si annoverano i caratteri tipici di un rapporto di lavoro subordinato, rispecchiati puntualmente dal lavoro penitenziario alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria: la faciendi necessitas, ovvero l'obbligo di una prestazione di fare; la subordinazione, intesa come esecuzione della prestazione alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro; la collaborazione, come obbligo di eseguire la prestazione lavorativa mostrando obbedienza e diligenza nei confronti del datore di lavoro e al fine di realizzare gli scopi e gli interessi dell'impresa; e infine l'onerosità.
69. R. Scognamiglio, Rapporto di lavoro e contratto, in M. Persiani, Diritto del lavoro. I nuovi problemi: omaggio dell'accademia a Mattia Persiani, Cedam, Padova, 2005, p. 774.
70. U. Romagnoli, op. cit., p. 98.
71. M. Pavarini, Codice commentato dell'esecuzione penale, Utet, Torino, 2002, p. 45; G. Pera, Diritto del lavoro, cit., p. 439; F. Mazziotti, op. cit., p. 131.
72. Corte Cass. 19 luglio 1991, n. 8055, Valente, in "Foro italiano", 1991, I, pp. 2354 e ss. In senso contrario Pret. Padova, 17 marzo 1983, Fagan c. Soc. Valle Sport, in "Foro italiano", 1986, I, pp. 1430 e ss.; in tale sentenza il pretore in funzione di giudice del lavoro addirittura esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dell'attività di un detenuto svolta in favore di un'impresa privata all'interno dell'istituto per il fatto che "all'amministrazione penitenziaria sono riservati il potere di disciplina e la determinazione dell'orario di lavoro" e dunque a maggior ragione un rapporto di lavoro subordinato si dovrebbe escludere se il detenuto lavorasse alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.
73. Cfr. G. Vidiri, op. cit., pp. 55-56.
74. Corte Cost., 11 febbraio 1999, n. 26, cit.
75. Limite massimo confermato anche dall'art. 3 del D. Lgs. n. 66 del 2003 di attuazione delle direttive comunitarie 93/104/Ce e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
76. In tal senso R. Pessi, op. cit., p. 112.
77. Cfr. G. Pera, op. cit., p. 66; G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 150.
78. Corte Cost., 10-22 maggio 2001, n. 158, in "Diritto penale e processo", n. 10, 2001, pp. 244 e ss.
79. Così R. Pessi, op. cit., p. 113; F. Della Casa, Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che lavora. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 2001, n. 158, in "Diritto penale e processo", N. 10, 2001, pp. 246 e ss.
80. Cfr. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 158.
81. Pret. Roma, 5 marzo 1986, Buzzi ed altri c. Min. grazia e giustizia, in "Foro italiano" I, p. 1430.
82. Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1087, in "Cassazione penale", 1989, pp. 852 e ss. Prima di tale pronuncia, la Corte costituzionale è stata adita più volte sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 ord. pen., ed ogni occasione di approfondimento al riguardo è stata fugata sostenendo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione; così Corte cost., 11 aprile 1984 n. 103 e 23 dicembre 1986, n. 291, rispettivamente in "Foro italiano", 1984, I, pp. 1182 e ss. e in "Giurisprudenza costituzionale", 1986, I, pp. 2322 e ss.
83. Così R. Pessi, op. cit., p. 115; P. Corso, Manuale dell'esecuzione penitenziaria, Monduzzi editore, Bologna, 2002, p. 90.
84. A seguito della riforma dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, la direzionale generale degli istituti di previdenza e di pena è stata sostituita dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.).
85. Attualmente Ministero dell'economia e delle finanze.
86. Cfr. F. Pochini Frediani, Il lavoro subordinato nel vecchio e nel nuovo ordinamento penitenziario, in M. Cappelletto, A. Lombroso, op. cit., pp. 114-117. L'ingresso delle rappresentanze sindacali in carcere è stato notevolmente apprezzato da quella parte della dottrina più attenta al problema del riavvicinamento della disciplina del lavoro carcerario a quella del lavoro 'libero'. Infatti storicamente i sindacati si sono mostrati piuttosto restii ad occuparsi del problema del lavoro penitenziario, in quanto era diffusa la convinzione, peraltro rafforzata dalla normativa penitenziaria in punto di remunerazione, che i lavoratori detenuti potessero giocare una concorrenza sleale ai lavoratori liberi dal momento che i datori di lavoro assumendoli, avrebbero avuto mano d'opera ad un costo inferiore rispetto a quello del mercato 'libero'. Il superamento di tale pregiudizio e l'ampliamento della tutela sindacale dei lavoratori anche a quelli detenuti, invece, può favorire un più veloce ed efficace processo di parificazione di diritti e garanzie fra le due categorie di lavoratori. Cfr. G. Muci, Le organizzazioni sindacali di fronte alla riforma penitenziaria, in M. Cappelletto, A. Lombroso, op. cit., pp. 119 e ss.
87. L'art. 45 del regolamento penitenziario (D.P.R. 230 del 2000) prevede che per la frequenza ai corsi di formazione professionale sia corrisposto un sussidio orario, che si aggiunge pertanto alla mercede dovuta ai detenuti e agli internati che si assentano dal lavoro ordinario per frequentare tali corsi.
88. Circ. DAP., 5 maggio 1988, n. 611065/2/1; inoltre si è previsto che debbano essere favoriti nell'iscrizione ai corsi in questione "quei reclusi le cui prospettive di detenzione rendano probabile il completamento del corso stesso", visto che potrebbe succedere che vi siano detenuti con fine pena anteriore alla data prevista per il termine del corso.
89. Secondo i primi tre commi dell'art. 23, poi abrogati dalla l. n. 663 del 1986, la remunerazione era determinata "nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati. La differenza fra mercede e remunerazione è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna". In definitiva solo gli internati avevano diritto a percepire l'intera mercede, mentre i condannati e gli imputati subivano il prelievo di tre decimi da destinare ad un ente di solidarietà sociale. Solo nel caso in cui gli imputati venissero prosciolti, avrebbero percepito l'intera mercede.
Si è detto che la disciplina penitenziaria in materia di lavoro si applica ai soli detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, per cui la normativa contenuta nell'art. 23 in materia di prelievi era del pari non applicabile ai detenuti che lavoravano alle dipendenze di terzi. Inoltre è stato calcolato che i prelievi di cui si tratta, in aggiunta agli oneri contributivi e tributari, facevano scendere la remunerazione del lavoratore detenuto intorno al 20% della normale retribuzione del lavoratore libero. Cfr. G. Vidiri, op. cit., p. 57.
90. Trib. Padova, 19 giugno 1984 in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", 1985, pp. 485 e ss.; Trib. Roma, 20 maggio 1985, Maj, in "Foro italiano", 1986, III, pp. 238 e ss. In senso contrario Trib. Torino, 15 giugno 1984, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", 1985, pp. 481 e ss.
91. Corte cost., 18 febbraio 1992, n. 49, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 1993, II, p. 16. A seguito di tale sentenza è intervenuta una circolare DAP. la quale ha stabilito le modalità e la procedura da seguire da parte dei detenuti e delle direzioni degli istituti per adempiere all'obbligo di restituzione delle somme illegittimamente trattenute, specificando in particolare che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione in questione è quello ordinario decennale, e dunque ponendo un primo limite alle possibili richieste al riguardo; cfr. Circ. DAP. 20 agosto 1993, n. 488366/10.
La Corte di cassazione è intervenuta in punto di restituzione dei prelievi illegittimi a seguito dell'abrogazione dell'art. 23 ord. pen. affermando che "è competente il magistrato di sorveglianza a decidere sull'istanza del detenuto intesa ad ottenere la restituzione dei tre decimi della merce trattenutagli, trattandosi di questione attinente alla remunerazione"; Cass. pen., sez. I, 21 luglio 1992, n. 2323, Pepe, in "Cassazione penale", 1993, p. 18.
92. Le spese del processo e quelle di mantenimento possono essere oggetto di remissione del debito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 115 del 2002, se sussistono due condizioni ovvero qualora l'interessato detenuto o internato si trovi in "disagiate condizioni economiche" e purché abbia tenuto "in istituto una regolare condotta" che ai sensi dell'art. 30 ter ottavo comma ord. pen., è tale "quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". La domanda di remissione del debito può essere presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, ovvero può essere proposta dal consiglio di disciplina, in entrambi i casi deve essere destinata al magistrato di sorveglianza competente ex art. 69 ottavo comma ord. pen.
93. L'art. 24 ord. pen. innova rispetto a quanto previsto dall'art. 145 c.p. infatti secondo quest'ultima disposizione la quota riservata ai detenuti avrebbe dovuto essere pari ad un terzo, tuttavia con un trattamento di maggior favore per il condannato era previsto che tale quota non fosse passibile né di pignoramento né di sequestro, mentre l'attuale disciplina permette il sequestro o il pignoramento nei due casi su riportati.
94. Così G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 163.
95. Ibidem.
96. L'art. 76 del regolamento penitenziario prevede che possano essere concesse ai detenuti e agli internati delle ricompense, fra le altre ipotesi, qualora questi si fossero distinti "per particolare impegno nello svolgimento del lavoro" e "per particolare impegno e profitto nei corsi di addestramento professionale".
97. La parte vincolata del peculio dei detenuti può essere dunque svincolata nell'ipotesi in cui sussistono particolari motivi così gravi da giustificare un'anticipazione delle somme spettanti al detenuto al momento della propria dimissione. La competenza al riguardo è posta in capo alle direzioni degli istituti penitenziari. Vd. circ. DAP. 10 ottobre 1997, n. 142653/4-1-32.
98. La suddivisione del peculio in fondo vincolato e fondo disponibile non sussiste per gli imputati, essendo interamente disponibile, tuttavia anche per costoro resta fermo l'ammontare massimo delle somme possedute in carcere a titolo di peculio (art. 57 quinto comma regol. penit.).
Per i condannati è previsto che il fondo disponibile non possa superare il limite di 1.032 euro, mentre per gli imputati il limite massimo è pari a 2.065 euro. Le eccedenze devono essere depositate presso un conto esterno oppure inviate ai familiari.
99. Gli assegni familiari e le aggiunte di famiglia sono stati sostituiti da un'unica prestazione consistente per l'appunto nell'assegno per il nucleo familiare dalla riforma in materia intervenuta con la l. n. 153 del 1988, che ha innovato sul punto rapportando quanto dovuto a tutela della famiglia, al nucleo familiare stesso. Pertanto il titolare di tale prestazione non è più il "capo famiglia" ma l'intero nucleo familiare. La disciplina previgente sugli assegni familiari è rimasta in vigore per categorie particolari di lavoratori.
100. Per maggiori approfondimenti si rimanda a R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Cedam, Milano, 2001, pp. 502 e ss.
101. Possono fare parte del nucleo familiare anche sorelle, fratelli e nipoti di età inferiore a diciotto anni, oppure senza limiti di età qualora siano orfani, privi di pensione per i superstiti oppure si trovino a causa di infermità nell'impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo.
Per i cittadini stranieri vale la regola per cui non sono considerati a carico degli stessi, il coniuge, i figli e i soggetti a questi equiparati, qualora lo straniero non abbia la residenza in Italia, salvo eventuali accordi internazionali che dispongano diversamente. Invece per i lavoratori migranti nell'ambito comunitario, il trattamento in questione spetta secondo la legge del luogo dove è svolta l'attività lavorativa, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art. 73 reg. CE n. 1048 del 1971).
102. Brevemente si deve precisare che l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria. I requisiti che il lavoratore deve fare valere ai fini dell'indennità ordinaria sono essenzialmente due: almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria ed almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto. L'indennità è corrisposta per un periodo di sei mesi, prorogabile a nove se si tratta di lavoratore ultracinquantenne, ed è di importo pari al 40% della retribuzione media dei tre mesi precedenti la cessazione del lavoro.
Esiste anche un'altra ipotesi di indennità ordinaria, cosiddetta "a requisiti ridotti", per coloro che non abbiano maturato i 52 contributi settimanali, i quali devono però aver lavorato almeno 78 giorni nell'anno precedente. In questo caso l'importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. L'indennità speciale è invece prevista per gli operai agricoli e per i lavoratori del settore dell'edilizia. Vd. la legge n. 388 del 2000, l'art. 13 l. n. 80 del 2005 e la circolare INPS n. 100 del 10 agosto 2005.
103. Al riguardo il medesimo articolo prevede che su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento all'ufficio di collocamento.
104. Cass. pen., sez. I., 28 gennaio 1991, Trombin, in "Foro italiano", 1992, p. 2816.
105. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 89 e ss.
106. Il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) consiste in una somma di denaro dovuta dal datore di lavoro al prestatore di lavoro in ogni caso di cessazione del rapporto, "la sua corresponsione pur trovando causa nella prestazione di lavoro, e in particolare nell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore, è oggetto di un'obbligazione che sorge per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, confermandosi così la sua natura di retribuzione differita". Il t.f.r. ha funzione retributivo-previdenziale e consiste nella somma di quote di retribuzione accantonate annualmente. Cfr. E. Ghera, op. cit., pp. 168-169.
107. Così G. Pera, Il lavoro dei detenuti nel progetto di riforma, in M. Cappelletto, A. Lombroso, op. cit., p. 109. Cfr. U. Romagnoli, op. cit., p. 101.
108. Nonostante la linearità del ragionamento adottato dalla dottrina in questione per addivenire a tale soluzione interpretativa, rimane il problema dell'attuazione in concreto dell'obbligo per il datore di lavoro - in tal caso l'amministrazione penitenziaria - di corrispondere il trattamento di fine rapporto. In realtà considerata la rotazione nel posto di lavoro da parte di più detenuti e dunque la limitatezza della durata dell'attività lavorativa stessa, la somma dovuta a titolo di t.f.r. risulterebbe del tutto esigua dal momento che tale trattamento si calcola "sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5" (art. 2120 c.c.).
109. Attualmente i requisiti per la pensione di vecchiaia per i lavoratori subordinati sono aver conseguito 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, e 20 anni di contributi. Invece per la pensione di anzianità, conseguibile prima del raggiungimento dell'età pensionabile di cui sopra, i presupposti sono l'aver raggiunto i 35 anni di contributi ed un'età di 59 anni, ovvero 39 anni di contributi e qualunque età.
110. Cfr. R. Ciccotti, F. Pittau, Problemi del lavoro e della previdenza in carcere, in "Lavoro e previdenza oggi", 1984, pp. 2010 e ss.
111. L'invalidità consiste in una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, la quale dà diritto alla corresponsione di un assegno che può concorrere in maniera inversamente proporzionale nel suo ammontare con un eventuale reddito prodotto dal beneficiario. Invece l'inabilità consiste in un'infermità fisica o mentale tale da provocare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Per maggiori approfondimenti si rimanda a R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, cit., pp. 517 e ss.
112. Chiarendo meglio la disciplina, si deve partire dal presupposto che le leggi in materia (l. n. 138 del 1943 e l. n. 833 del 1978), prevedono che l'indennità di malattia debba essere corrisposta soltanto a partire dal quarto giorno di assenza dal lavoro per tale causa, con evidente finalità dissuasiva. I primi tre giorni sono pertanto detti "periodo di carenza" proprio perché non è corrisposta alcuna indennità, salvo l'eventuale trattamento più favorevole previsto dal C.C.N.L. di categoria. L'indennità in esame è corrisposta dall'INPS ma anticipata dal datore di lavoro, per un massimo di 180 giorni nell'arco di un anno solare e i beneficiari sono soltanto gli operai e i lavoratori del commercio e dell'agricoltura (salvo altre categorie meno rilevanti ai nostri fini). Ivi, pp. 497 e ss.
113. Non è possibile soffermarsi in questa sede sul commento puntuale della disciplina contenuta dal d. lgs. n. 626 del 1994, pertanto per maggiori approfondimenti si rimanda a E. Ghera, op. cit., pp. 96 e ss.
114. Il rapporto previdenziale in questione è obbligatorio e sorge esclusivamente nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorative pericolose, elencate dallo stesso testo unico. L'evento protetto è l'infortunio che si è verificato "in occasione del lavoro", dunque anche se non vi è nesso di causalità diretto fra infortunio e lavoro, per una "causa violenta", ovvero caratterizzata da abnorme intensità concentrata nel tempo e che abbia dato luogo ad un'inabilità temporanea o permanente. In tali casi è dovuta al prestatore di lavoro la corresponsione da parte dell'ente previdenziale, l'INAIL, rispettivamente di un'indennità o di una rendita. La malattia professionale, invece, tutela l'inabilità che discende da una malattia, e quindi diversamente dalla causa violenta, da un agente patogeno che agisce lentamente nel tempo. Cfr. R. Pessi, Lezioni di diritto della previdenza sociale, cit., pp. 527 e ss.
115. Cfr. Corte Cass., sez. lav., 10 maggio 1997, n. 4097, in "Rivista giuridica del lavoro", 1998, II, pp. 187 e ss.
116. Cfr. G. Galli, Assicurazione contro gli infortuni e responsabilità dell'amministrazione penitenziaria nel lavoro carcerario, in "Rivista giuridica del lavoro", 1998, II, pp. 189 e ss.
117. Si pensi per esempio alla partecipazione ad una manifestazione sindacale, preclusa al detenuto in virtù dello stato detentivo.
118. Così testualmente F. Mazziotti, op. cit., p. 134; cfr. anche G. Ichino, op. cit., p. 132; U. Romagnoli, op. cit., p. 102; R. Pessi, Il rapporto di lavoro del detenuto cit., p. 118.
119. Cfr. G. Vidiri, op. cit., p. 58; M. Canepa, S. Merlo, op. cit., p. 128.
120. L'art. 14 della l. 300 del 1970 prevede che "il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro".
121. L'art. 20 st. lav. riconosce infatti il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea fuori dall'orario di lavoro ovvero "durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione".
122. Cfr. M. Pavarini, op. cit., p. 46.
123. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 27 e ss. e 54 e ss.; R. Pessi, Il rapporto di lavoro del detenuto cit., p. 116-117. Contrario al riconoscimento del diritto di sciopero ai lavoratori detenuti, ritenuto incompatibile con lo stato detentivo è G. Pera, Aspetti giuridici del lavoro carcerario, cit. p. 64.
124. La ratio della disposizione finalizzata a garantire la conformità alla legge dell'operato dell'amministrazione penitenziaria, induce a non ritenere tassative l'enunciazione delle materie oggetto di reclamo, consentendo dunque un'interpretazione per cui il procedimento di reclamo indicato dall'art. 69 sarebbe utilizzabile anche per questioni giuslavortistiche non espressamente previste dalla stessa disposizione; così G. Vidiri, op. cit., p. 60.
125. I provvedimenti giurisdizionali sono soltanto tre: la sentenza, l'ordinanza e il decreto.
126. Trib. Roma, 20 maggio 1985, Maj; così G. Vidiri, op. cit., p. 59.
127. Corte cost., 11 aprile 1984, n. 103, in tale sentenza la corte richiama quanto già aveva avuto modo di enunciare nell'ordinanza n. 87 del 21 dicembre 1978, in "Cassazione penale", 1979, pp. 8 e ss.; cfr. anche mag. sorv. Pescara, 28 novembre 1978, in "Cassazione penale" 1979, pp. 1034 e ss. In senso contrario Mag. sorv. Roma, 20 giugno 1978, in "Diritto del lavoro", II, 1979, pp. 271 e ss.
128. Corte Cost., 8 febbraio 1999, n. 26.
129. Corte Cass. SS. UU., 21 luglio 1999, n. 490, Min. Giust. c. Saporito, in "Giurisprudenza italiana", 2000, pp. 251 e ss.; Corte Cass. SS. UU., 14 dicembre 1999, n. 899, Min. Giust. c. Umbertino, in "Rivista italiana di diritto del lavoro", 2000, II, pp. 394 e ss.
130. Cfr. A. Raciti, op. cit., p. 279. In senso contrario M. Vitali, op. cit., pp. 110 e ss., secondo la cui tesi per le controversie attinenti ai rapporti di lavoro fra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria, in particolare nell'ipotesi in cui si tratti dello svolgimento dei cosiddetti "lavori domestici", la competenza spetterebbe al magistrato di sorveglianza; invece nell'ipotesi di rapporti di lavoro fra detenuti e privati datori di lavoro, la competenza sarebbe del giudice del lavoro.
131. Corte Cass., 1 marzo 2001, Gallino, in "Cassazione penale" 2002, p. 1799.
132. Corte Cass., SS. UU., 26 gennaio 2001, Min. Giust. c. Stojakovic, in "Il foro italiano" 2001, I, p. 2890.
133. Al riguardo occorre rilevare che si è avuta un'involuzione da parte della giurisprudenza della corte di cassazione, la quale in una celebre sentenza del 1991, a ridosso della riforma penitenziaria del 1986, aveva ammesso la competenza del giudice ordinario in materia di controversie di lavoro in cui una parte sia un prestatore di lavoro detenuto, sostenendo che "il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve tuttavia ritenersi a questo assimilabile, anche sotto il profilo della responsabilità gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., con la conseguenza che appartengono alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, le controversie promosse dal detenuto al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a cagione della mancata adozione delle cautele antinfortunistiche imposte dal citato art. 2087 c.c.", Corte Cass., 19 luglio 1991, n. 8055, Valente c. Min. Giust., cit.
134. M. Pavarini, op. cit., p. 48; M. Vitali, op. cit., pp. 113 e ss.
135. Non essendo questa la sede in cui potersi soffermare sull'esame della disciplina processuale per le controversie di lavoro, si può brevemente accennare al fatto che le peculiarità del processo del lavoro trovano ragion d'essere nell'esigenza di garantire una tutela immediata e ed effettiva del lavoratore, il quale si trova di partenza in posizione di subordine rispetto al datore di lavoro. Il procedimento si svolge non più dinanzi al Pretore, il cui ufficio è stato soppresso nel 1998, ma dinanzi al Tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro. Le caratteristiche principali del processo del lavoro sono l'immediatezza, l'oralità e la concentrazione, infatti i termini processuali sono abbreviati rispetto a quelli del processo ordinario, sono stabilite rigide preclusioni per costringere le parti ad enunciare le proprie difese e indicare i mezzi di prova sin dagli atti introduttivi del processo. È previsto poi che il processo si esaurisca in una sola udienza, infatti il giudice deve acquisire attraverso l'interrogatorio delle parti, l'istruzione probatoria e la discussione orale della causa, la conoscenza dei fatti e pronunciare la sentenza nel corso della stessa udienza dando lettura del dispositivo in aula. Altra importante peculiarità consiste nella sussistenza della clausola di provvisoria esecutorietà delle sentenze di condanna per i crediti di lavoro. Cfr. E. Ghera, op. cit., pp. 196 e ss.
136. Così M. Signorini, cit. Si deve ulteriormente rilevare che il magistrato di sorveglianza è l'organo designato alla tutela dei diritti dei detenuti i quali in ogni tempo possono a questi proporre reclamo ex art. 35 ord. pen.
137. La circolare DAP. del 23 marzo 2001, n. 627698-2/11, contenente un modello di regolamento di riferimento per l'adozione dei regolamenti interni da parte dei vari istituti penitenziari, dispone fra le altre indicazioni, che le direzioni degli istituti debbano individuare le imprese pubbliche o private idonee a collaborare al trattamento penitenziario e debbano attivarsi per garantire nei limiti del possibile, il lavoro a tutti i detenuti e gli internati, adottando ogni utile iniziativa al riguardo.
138. Cfr. A. Raciti, op. cit., p. 280; R. Pessi, Il rapporto di lavoro del detenuto cit., pp. 108 e ss.
139. I detenuti costituiscono occasione di manodopera conveniente per le imprese sia per la remunerazione dovuta, normalmente più bassa rispetto alla normale retribuzione spettante ai lavoratori 'liberi' di pari livello, sia per una serie di incentivi, consistenti essenzialmente in sgravi fiscali (l. 193 del 2000 cosiddetta "legge Smuraglia"), introdotti proprio al fine di favorire l'assunzione di lavoratori detenuti; cfr. infra cap. II § 2.
140. Il piano di lavoro deve essere elaborato annualmentedalla direzione dell'istituto "in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive" (art. 25 bisord. pen.).
141. Cfr. F. Fiorentin, A. Marcheselli, op. cit., p. 16.
142. Così G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 166.
143. Ivi, p. 146.
144. Al riguardo, sia nell'ipotesi di lavorazioni gestite dall'amministrazione penitenziaria che in quella di lavorazioni gestite da terzi, è previsto che le attività in questione siano "organizzate in locali esterni alle sezioni detentive, con spazi attrezzati per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro" (art. 47). Inoltre il regolamento di ogni istituto dovrebbe indicare le attività lavorative che possono essere svolte in luoghi a sicurezza attenuata (art. 25 bis).
145. Vd. oltre cap. II § 1.
146. Un recente protocollo d'intesa fra il Ministero della Giustizia e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel prevedere degli obiettivi specifici di promozione del lavoro penitenziario, fra i vari strumenti, quali ad esempio la facilitazione dello scambio fra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso società di mediazione, la realizzazione di una banca dati sulle caratteristiche professionali dei detenuti, la sollecitazione di una programmazione regionale al riguardo, hanno anche convenuto di "promuovere e stimolare commesse di lavoro per i detenuti da parte di enti pubblici, cooperative sociali e imprese" nel quadro di un più ampio raggio di intervento finalizzato a sostenere quanto più possibile la produzione penitenziaria rivolta al mercato esterno; vd. circ. DAP. 19 febbraio 2001, n. 498605-10.
147. Cfr. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 152.
148. Così testualmente M. P. Frangeamore, Lo sviluppo del lavoro penitenziario: prodotto e prezzo, in "Diritto penale e processo" 1999, p. 783.
149. L'art. 47 prevede anche che le convenzioni in esame "particolarmente con cooperative sociali" possano avere ad oggetto servizi interni, "come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati"; vd. infra § 7.2.
150. Con riferimento al problema della tutela della salute del lavoratore nel luogo di lavoro e la garanzia della sicurezza dello stesso ambiente di lavoro, si pongono tutta una serie di dubbi in ordine alla concreta applicabilità negli istituti penitenziari della disciplina di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 volto per l'appunto a prevedere delle cautele e degli obblighi per assicurare la salvaguardia e l'indennità dei prestatori di lavoro. Dubbi determinati anche dalla difficoltà di bilanciamento fra l'esigenza di spazi di movimento ed autonomia del lavoratore con l'opposta esigenza di estremo controllo e sorveglianza dei detenuti al fine di assicurare la sicurezza e la disciplina nelle carceri.
151. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 37 e ss.
152. Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1087, cit.
153. Vd. oltre cap. 2 § 1.
154. Si è già messo in evidenza come tali servizi consistano nelle attività, tipiche di ogni istituto penitenziario, di "scrivano", "cuciniere", "scopino", "barbiere", "magazziniere", ecc.
155. Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
156. Solo in casi del tutto particolari ed eccezionali è ammessa la possibilità di appaltare un servizio tramite la procedura della trattativa privata.
157. Per approfondimenti si rimanda infra cap. II, § 1.4.
158. In tal senso G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 149.
159. Ibidem; cfr. anche G. Pera, Il lavoro dei detenuti nel progetto di riforma, cit., p. 103.
160. Corte Cass., 14 aprile 1992, Leggio, in "Cassazione penale", 1993, p. 1549.
161. Purché in quest'ultimo caso non sia necessario l'utilizzo di macchinari ingombranti o pericolosi ovvero non si arrechi molestia ai compagni di cella (art. 51 regol. penit.).
162. Del pari una circolare DAP si è preoccupata di disciplinare l'ipotesi inversa, ovvero la ricezione di pacchi da parte del detenuto, contenenti le materie prime o accessorie nonché gli attrezzi di lavoro, consentendo da un lato una deroga ai limiti annuali massimi di spesa da parte del detenuto e dall'altro gli acquisti tramite corrispondenza postale, laddove non sia possibile la ricezione dei pacchi tramite lo strumento tradizionale dei colloqui; vd. circ. DAP. 16 dicembre 1988, n. 590899/12.
163. Cfr. E. Ghera, op. cit., pp. 214 e ss.; M. Vitali, op. cit., pp. 11 e ss.
164. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 29 e ss.
165. Cfr. Mag. Sorv. Sassari, 26 gennaio 1980, in "Lavoro 80", 1982, p. 279. Il caso affrontato dal magistrato di sorveglianza di Sassari concerne un reclamo del detenuto in punto di legittimo esercizio del potere disciplinare da parte dell'amministrazione penitenziaria, in quanto il detenuto reclamante sosteneva di essere stato illegittimamente rimosso dal posto di lavoro assegnatogli a causa di un rapporto disciplinare conseguito per oltraggio nei confronti di un agente di custodia commesso durante la permanenza all'aperto, quindi non durante l'orario di lavoro. Nel caso di specie vi è dunque una chiara sovrapposizione fra rapporto di lavoro e rapporto punitivo, concretizzatosi nell'uso del potere disciplinare. A seguito del reclamo il magistrato di sorveglianza in questione ha ordinato all'amministrazione penitenziaria la reintegrazione nel precedente posto di lavoro del detenuto rimosso illegittimamente.
166. Corte Cass., 2 giugno 1992, Baldi, in "Cassazione penale", 1993, p. 19.
167. La legge 15 luglio 1966 n. 604 prevede alcune norme fondamentali in materia di licenziamenti individuali, le quali sono volte a garantire la massima tutela possibile per il lavoratore destinatario del provvedimento di licenziamento. Innanzitutto è previsto che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto e il lavoratore possa chiedere i motivi del licenziamento. In secondo luogo la legge in esame precisa le nozioni di giusta causa e giustificato motivo, sussistenti rispettivamente per motivi attinenti alla colpa del prestatore di lavoro e ad un suo grave inadempimento dei doveri e dei compiti lavorativi. Infine è disciplinato il procedimento di impugnazione del licenziamento, in costanza del quale l'onere della prova è invertito in capo al datore di lavoro, il quale laddove venisse accertato che il licenziamento è ingiustificato o illegittimo, deve o reintegrare il lavoratore nel posto d lavoro o provvedere al risarcimento danni (art. 8 l. n. 604 e 18 St. Lav.). Cfr. E. Ghera, op. cit., pp. 151 e ss.
168. Così testualmente M. Vitali, op. cit., p. 59.
169. Ivi, p. 60. Un'altra questione, del pari interessante, affrontata in dottrina e giurisprudenza, è quella attinente al caso di licenziamento del prestatore di lavoro a seguito dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Prima della l. n. 604 del 1966, era quasi automatico che all'arresto del lavoratore seguisse immediatamente il licenziamento a causa della custodia cautelare; a seguito della legge suddetta invece il licenziamento è legittimo soltanto se fondato su una giusta causa o un giustificato motivo. Pertanto la mera custodia cautelare non è stata considerata più motivo sufficiente di per sé solo a legittimare il licenziamento. Occorre che sussistano altre condizioni: la durata dell'assenza dal lavoro deve essere protratta per un lungo periodo di tempo e il lavoratore deve essere adibito a mansioni particolarmente importanti, tali che nell'ipotesi di impossibilità parziale della prestazione, quale quella integrata dalla custodia cautelare, per il datore di lavoro non sia possibile sospendere il rapporto e sostituire temporaneamente il prestatore di lavoro senza grave nocumento per l'impresa. Così Corte Cass., sez. lav., 28 giugno 1976, n. 2469, Busardo e 9 novembre 1978, Pederzin, rispettivamente in "Foro Italiano", 1976, I, p. 1804 e in "Foro italiano", 1979, I, p. 368; cfr. anche R. Ciccotti, F. Pittau, Aspetti del lavoro carcerario nell'evoluzione giurisprudenziale, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" I-II, 1982, pp. 125 e ss.
170. In tal senso M. Pavarini, op. cit., p. 54; M. Vitali, op. cit., p. 65.
171. Così M. Pavarini, op. cit., p. 50; cfr. M. Pavarini, La nuova disciplina del lavoro dei detenuti nella logica del trattamento differenziato, in V. Grevi (a cura di), L'ordinamento penitenziari cit., pp. 110 e ss; A. Bernardi, Il lavoro carcerario, in G. Flora (a cura di), Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario (l. 10 ottobre 1986 n. 663), Giuffrè, Milano, 1987, pp. 115 e ss.
172. Al riguardo viene in aiuto, essendo ritenuto applicabile per analogia, l'art. 11 comma secondo ord. pen. laddove elenca l'autorità giudiziaria di volta in volta ritenuta competente a seconda della fase e del grado del procedimento: il magistrato di sorveglianza dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; invece prima della sentenza di primo grado, il pubblico ministero durante le indagini preliminari e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; il presidente del tribunale durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio. Cfr. M. Pavarini, La nuova disciplina del lavoro dei detenuti, cit., p. 112.
173. Mag. Sorv. Roma, 20 luglio 1983, Andolino, in "CED. Cass.", n. 850092; Trib. Pisa, 11 agosto 1983, Lorenzini, in "Cassazione penale", 1984, p. 1830.
174. Sintetizzando si può sostenere che i reati elencati nell'art. 4 bis sono generalmente considerati particolarmente gravi in quanto direttamente o indirettamente connessi alla criminalità organizzata (art. 416 bis c.p.; art. 74 D.P.R. 309/1990 cosiddetto "Testo Unico stupefacenti"), ovvero caratterizzati da una condotta di notevole disvalore sociale (artt. 600, 601, 602, 630 c.p.).
175. Nel silenzio della giurisprudenza di merito e di legittimità sul problema dell'applicabilità agli imputati del regime restrittivo ex art. 4 bis in materia di accesso al lavoro all'esterno di cui all'art. 21, sembra sufficiente ad avvalorare la tesi proposta il solo dato legislativo, che è univocamente orientato a limitare il proprio ambito applicativo alle ipotesi di detenuti ed internati "definitivi".
176. L'art. 4 bisdistingue a seconda che si tratti di taluno dei delitti indicati "nel primo periodo del primo comma" -delitti caratterizzati dall'elemento dell'associazione ovvero in materia di tratta di persone- e delitti previsti dal secondo periodo dello stesso primo comma - delitti di cui agli artt. 575, 600 bise ss., 609 bise ss., 416 c.p. e 73 T.U. stup. (D.P.R. 309/1990). In ambo le ipotesi, comunque, ciò che rileva ai fini della deroga all'applicazione del divieto è la prova dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
177. In tal senso M. Pavarini, op. cit., p. 51.
178. L'art. 58 quater fa esplicito riferimento alle ipotesi di "revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47 comma undicesimo, dell'art. 47 ter comma sesto o dell'art. 51 primo comma", richiamando pertanto rispettivamente la disciplina relativa all'affidamento in prova ai servizi sociali, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà. Dunque se ne dovrebbe concludere che il divieto previsto dall'art. 58 quater si applichi solo nelle ipotesi di revoca delle misure alternative ivi elencate.
179. Rispettivamente sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione e sequestro a scopo di estorsione.
180. La circolare in questione è frutto di vari accordi fra gli allora vigenti Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Mistero degli interni, Ministero degli esteri e Ministero dell'immigrazione. Inoltre è stata pienamente recepita dalla circolare del DAP del 23 marzo 1993 n. 691858-1/12.1.
181. Quest'ultima disposizione deve essere, tuttavia, ritenuta implicitamente abrogata sulla base del presupposto che nel 2000 sono stati aboliti sia il libretto di lavoro, sostituito dalla "scheda professionale" del prestatore di lavoro, sia l'obbligo per il lavoratore di consegnare, al momento dell'assunzione, il libretto di lavoro al proprio datore di lavoro (artt. 5 e 6 del D.P.R. 442/2000).
182. Lettera circolare del Ministero di Grazia e Giustizia prot. 547671/10 del 12 aprile 1999.
183. Circolare del Ministero dell'Interno del 2 dicembre 2000 nº 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV.
184. Circolare del Ministero della Giustizia diramata dal DAP con due note del 15 febbraio 1999 prot. n. 545497 e del 16 marzo 1999 prot. n. 547899.
185. Corte Cass., SS.UU., 27 aprile 2006, n. 7458.
186. Circ. D.A.P., 30 maggio 1988, n. 3246/5696. Del resto non si tratta di un'ipotesi solamente teorica costituendo un famoso "precedente" giurisprudenziale il caso del tutto simile a quanto menzionato nella suddetta circolare, di un detenuto ammesso al lavoro all'esterno presso un datore di lavoro che si è offerto di assumerlo alle proprie dipendenze ma al senza avere il proposito d occuparlo e lasciandolo dunque libero di impiegare diversamente il tempo che avrebbe dovuto dedicare al lavoro. Il datore di lavoro simulato è stato perciò condannato per il delitto di procurata inosservanza di pena ex art. 390 c.p.; Trib. Firenze, 3 novembre 1981, Opellizzi, in "Foro italiano" 1982, pp. 501 e ss.
187. La medesima disposizione non fa invece riferimento alla frequenza di corsi scolastici, per consentire la quale deve pertanto ritenersi esclusa l'applicabilità della disciplina in materia di ammissione al lavoro all'esterno.
188. Corte Cass., 28 ottobre 1991, Nateri, in "CED. Cass.", n. 188978.
189. Il programma di trattamento deve essere individualizzato in quanto "deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto". Ai fini della redazione dello stesso, è effettuata dal gruppo di osservazione e trattamento (GOT) la cosiddetta "osservazione scientifica della personalità diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione" (art. 27 regol. penit.). All'inizio dell'esecuzione l'osservazione della personalità è specificamente finalizzata alla redazione del programma di trattamento, il quale deve essere redatto nel termine di nove mesi, e successivamente è invece finalizzata ad accertare "attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze" che richiedono una variazione del programma stesso, il quale può essere dunque integrato o modificato per rispondere ai progressi ovvero a nuovi bisogni del soggetto che si prospettano nel corso dell'esecuzione della pena.
190. Se dovesse accertare una violazione dei diritti del detenuto o internato, il magistrato di sorveglianza deve limitarsi a restituire gli atti al gruppo di osservazione e trattamento, eventualmente allegando alcune osservazioni, al fine di una riformulazione.
191. Così testualmente A. Benedetti, Sul lavoro all'esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", 1983, fasc. 1, p. 341.
192. Cfr. N. Cesari, Il lavoro all'esterno. Un'intuizione o una svista del legislatore?, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", 1984, p. 267.
193. In tal senso G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 154.
194. Cfr. A. Bernardi, op. cit., p. 118; M. Pavarini, La nuova disciplina del lavoro dei detenuti, cit., p. 110.
195. Salvo il caso degli imputati per i quali si è detto provvede l'autorità giudiziaria competente, in questo caso peraltro è previsto che l'ammissione al lavoro all'esterno debba essere soltanto "comunicata" al magistrato di sorveglianza (art. 48 comma secondo regol. penit.).
196. Ibidem.
197. Così secondo la circolare DAP. del 29 dicembre 1986, n. 3191/5641.
198. Cfr. F. Fiorentin, A. Marcheselli, op. cit., p. 27; in particolare taluno ha rilevato come sussistano nel procedimento di ammissione al lavoro all'esterno e nella successiva esecuzione tutti gi elementi propri del procedimento di concessione e quindi dell'esecuzione delle misure alternative, quali l'osservazione scientifica della personalità, la redazione del programma di trattamento, l'approvazione del programma da parte del magistrato di sorveglianza, la possibilità di sospensione e revoca del beneficio, la commissione del reato di evasione nel caso di allontanamento dal posto di lavoro o mancato rientro in istituto - disciplina che si applica per tutte le misure alternative alla detenzione che mantengano lo status detentionis, dunque esclusa le sole ipotesi di affidamento in prova ex artt. 47 ord. pen. e 94 T.U. 309/1990- oltre che la finalità di ridurre al minimo le conseguenze deterioranti della detenzione; così V. Quintiliani, Osservazioni sull'ammissione al lavoro all'esterno, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", 1980, pp. 613 e ss.
199. Cfr. P. Troncone, op. cit., p. 179; G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 156; P. Comucci, Nuovi profili del trattamento penitenziario, Giuffrè, Milano, 1988, p. 109, il quale sostiene che l'istituto di cui all'art. 21 possa essere utilizzato, sul presupposto però che non vi siano particolari esigenze custodiali, nei casi in cui non sia possibile accedere alle misure alternative in senso stretto, quali l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la detenzione domiciliare, dal momento che non vengono soddisfatte le condizioni - in particolare i limiti di pena da espiare - previsti per l'ammissione alle stesse. La circolare DAP. del 30 maggio 1988, cit., sottolinea particolarmente la necessità che il direttore dell'istituto nell'ammettere al lavoro all'esterno rispetti puntualmente la disciplina in materia, "verificando con il massimo scrupolo la sussistenza di tutti i requisiti di legge", per non distorcere la natura del lavoro all'esterno, e soprattutto per non vanificare gli sforzi rieducativi compiuti nei confronti del detenuto ed evitare l'allarme sociale e il senso di frustrazione che deriverebbero certamente dal fallimento delle aspettative e della fiducia risposte sul soggetto ammesso al beneficio.
200. Così A. Bernardi, op. cit., p. 122.
201. Così A. Benedetti, op. cit., p. 338; N. Cesari, op. cit., p. 266.
202. Cass. pen., sez. I, 23 giugno 1993, Falcetta, in "Cassazione penale", 1985, pp. 177 e ss; nello stesso senso anche Cass. pen., sez. I, 2 maggio 1989, Moscatelli, in "Giustizia penale", 1990, II, p. 84; Cass. pen., sez. I, 19 maggio 1995, Nistri, in "Cassazione penale", 1996, p. 2375.
In dottrina sostengono la natura di atto amministrativo del provvedimento di autorizzazione al lavoro all'esterno del magistrato di sorveglianza: P. Comucci, op. cit., p. 113; P. Corso, op. cit., p. 85; P. Troncone, op. cit., pp. 179-180.
In senso critico, sostenendo che si tratta di "un'incongruenza rispetto all'impianto del sistema e all'equilibrio con cui esso regola i meccanismi che incidono sullo status di libertà del detenuto", è ammessa la natura di atto amministrativo del provvedimento in questione, in G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, op. cit., p. 156.
203. Corte Cass., 1 luglio 1987, Calzolaio, in "giustizia penale" 1988, II, pp. 298 e ss.; Corte Cass., 2 novembre 1980, Miniero, in "Cassazione penale", 1982, p. 799.
204. Cfr. Cass. pen., sez. I, 30 marzo 1993, Nanu, in "Cassazione penale", 1994, p. 1358.
205. TAR Piemonte, 16 marzo 1990, n. 115, Segio c. Min. Grazie e Giustizia, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1991, pp. 1047 e ss.; non essendo previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario alcuno specifico mezzo di impugnazione del decreto di ammissione al lavoro all'esterno, e stante il principio di tassatività ex art. 568 c.p.p. che regola la materia delle impugnazioni, il TAR ammette la ricorribilità al giudice di legittimità ai sensi dell'art. 111 in quanto si tratta di provvedimento sulla libertà personale nei confronti del quale "è sempre ammesso il ricorso per Cassazione". Cfr. S. Tassone, Decreto di ammissione al lavoro all'esterno e difetto di giurisdizione amministrativa: verso una rivalutazione delle funzioni del magistrato di sorveglianza?, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1991, pp. 1050 e ss.
206. Ibidem; F. Fiorentin, A. Marcheselli, op. cit., p. 28.
207. Secondo parte della dottrina l'obbligo della scorta per il detenuto lavorante all'esterno era giustifica sul presupposto del rispetto del principio della parità di condizione fra detenuti condannati, per assicurare che anche il lavoro all'sterno rispecchiasse i criteri di modalità di esecuzione della detenzione; cfr. A. Bendetti, op. cit., p. 339.
208. Così M. Pavarini, La nuova disciplina del lavoro dei detenuti, cit., p. 111.
209. Circ. DAP. 30 maggio 1988, cit.
210. In dottrina è stato rilevato come il controllo in questione debba svolgersi anche se l'attività lavorativa si effettua in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituto medesimo, in modo da evitare che se il detenuto venga avviato al lavoro all'esterno in un comune diverso da quello in cui ha sede lo stabilimento penitenziario, si verifichi un sostanziale distacco fra il lavoratore stesso e l'amministrazione penitenziaria che dovrebbe controllarlo; così G. Catelani, op. cit., p. 87.
211. Infatti ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dei lavoratori le guardie giurate possono essere impiegate soltanto "per scopi di tutela del patrimonio", mentre l'art. 4 consente l'utilizzo di impianti audiovisivi solo qualora fossero necessari per esigenze organizzative o produttive ovvero per ragioni di sicurezza sul lavoro. In ambo le previsioni è fatto espresso divieto di strumentalizzazione di tali deroghe per finalità di controllo sull'attività dei lavoratori.
212. La disciplina prevista in materia di controlli sul detenuto o internato ammesso al lavoro all'esterno presso un'impresa privata si applica anche nel caso di svolgimento da parte degli stessi detenuti o internati di lavoro autonomo (art. 48, comma diciassettesimo).
213. Circ. DAP, 28 novembre 1990, n. 605156-13, cit.
214. Corte cass., sez. VI, 12 aprile 1994, Forti, in "Cassazione penale", 1995, p. 2547.
215. Circ. DAP cit.
216. Corte Cass., 14 dicembre 1984, De Biase, in "Cassazione penale", 1986, pp. 1078 e ss.; Corte Cass., 8 giugno 1983, Adani, in "Cassazione penale", 1984, p. 2181.
217. Ibidem.
218. Avverso il provvedimento di revoca, il detenuto potrà proporre reclamo al magistrato di sorveglianza, il quale decide con ordinanza impugnabile attraverso il ricorso per cassazione, (artt. 69 comma sesto e 14 ter ord. pen.); cfr. Cass., sez. I, 19 settembre 2007, n. 35844, reperibile su Juris Data.
219. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 73 e ss.
220. Ivi, p. 76; P. Corso, op. cit., p. 88.
221. Ibidem.
222. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 77 e ss.
223. Ibidem.
224. Vd. supra, § 6.2.
225. Mag. Sorv. Varese, varie date, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici", 1984, pp. 491 e ss.; in senso conforme M. Vitali, op. cit., pp. 81 e ss.
226. Cfr. Corte Cass., sez. lav., 3 febbraio 1989, n. 685, in "Giustizia civile", 1989, I, pp. 1093 e ss., in cui il giudice di legittimità arriva alle medesime conclusioni tratte sopra con riferimento alla retribuzione dei semiliberi. Stante la somiglianza della disciplina applicabile, è plausibile un'estensione analogica della giurisprudenza in materia anche all'istituto del lavoro all'esterno.
227. Ovvero la disciplina in materia di procedura di mobilità e cassa integrazione guadagni.
228. Corte Cass., 27 settembre 1983, n. 623, in "Cassazione penale", 1985, pp. 995 e ss.
229. L. Degl'Innocenti, F. Faldi, Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza, Giuffrè, Milano, 2006, p. 143.
230. Cfr. M. Pavarini, op. cit., p. 149; M. Canepa, S. Merlo, op. cit., p. 335. Per evitare la commistione fra detenuti semiliberi e soggetti detenuti tout court, e dunque eventuali problemi che potrebbero crearsi per la continua alternanza fra detenzione e libertà, soprattutto nei riguardi dei detenuti che non sono ammessi alla misura alternativa in questione, il legislatore penitenziario ha giustamente previsto che i condannati e gli internati ammessi al regime della semilibertà siano "assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari" (art. 48 secondo comma ord. pen.).
231. L'art. 565 comma quinto c.p.p. prevede un particolare meccanismo di applicazione delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario nonché dal testo unico sugli stupefacenti, già prima dell'ingresso del condannato in carcere per evitare nell'ipotesi di pene brevi, fino a tre anni, il contatto con l'ambiente destrutturante e pericolosamente criminogeno del carcere. In particolare qualora sussistano i presupposti per l'ammissione ad una misura alternativa, il pubblico ministero emette l'ordine di carcerazione e contestualmente lo sospende invitando il condannato a presentare istanza per la concessione della misura, corredata dalla necessaria documentazione, entro trenta giorni a pena di revoca della sospensione e immediato inizio dell'esecuzione.
232. Al riguardo si applica la disciplina di cui all'art. 58 ter ord. pen., già esaminata nell'ambito della trattazione dei limiti di ammissione al lavoro all'esterno. Un innalzamento del quantum di pena da scontare ai fini dell'accesso alla semilibertà è previsto dall'art. 50 bis per i condannati a cui è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 quarto comma c.p., disposizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005, cosiddetta "legge ex-Cirielli", intervenuta a novellare l'ordinamento penitenziario dettando per l'appunto norme più severe e restrittive nei confronti dei recidivi, al fine di rendere maggiormente gravoso l'accesso ai benefici e alle misure alternative a tale categoria di detenuti.
233. La più recente giurisprudenza al riguardo fa riferimento ad "un prudente criterio di gradualità", Corte Cass., sez. I, 7 marzo 2007, n. 22739, reperibile su Juris Data.
234. Così M. Pavarini, op. cit., p. 155.
235. Corte Cass., sez. I, 7 novembre 1989, Mormile, in "Cassazione penale", 1991, p. 144; cfr. L. Degl'Innocenti, F. Faldi, op. cit., p. 153.
236. Corte Cass., sez. I, 11 aprile 1996, Musto, in "CED Cass. pen.", n. 205167; cfr. G. Casaroli, La semilibertà, in G. Flora (a cura di), op. cit., p. 267.
237. Corte Cass., sez. I, 14 maggio 1984, Stanghellini, in "Cassazione penale" 1985, p. 1669; Corte Cass., sez. I, 17 gennaio 1986, Di Gennaro, in "Cassazione penale" 1987, p. 652; Corte Cass., sez. I, 16 novembre 1989, Bassi, in "Cassazione penale", 1991, p. 484.
238. Corte Cass., 9 luglio 1981, Orlandi, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" 1982, pp. 260 e ss.
239. Corte Cass., 14 giugno 1978, Papeo, in "Giustizia penale", 1979, II, pp. 77 e ss.; Corte Cass., 12 dicembre 1983, Mangherini, in "Cassazione penale", 1985, p. 1471; Corte Cass., sez. I, 6 giugno 1988, Di Staso, in "Massimario penale" 1990, pp. 169 e ss.
240. Corte Cass., sez. I, 29 aprile 1985, Sala, in "Cassazione penale" 1986, p. 1384.
241. Corte Cass., sez. I, 14 ottobre 1991, Grandi, in "cassazione penale" 1993, p. 179; in particolare nel caso di specie la corte di cassazione ha considerato immotivata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di semilibertà da parte del Tribunale di sorveglianza nei confronti di un detenuto che aveva allegato la disponibilità del comune di Bologna ad impiegarlo tramite una borsa di formazione al lavoro della durata di nove mesi, e a sostenerlo successivamente nell'inserimento lavorativo presso aziende private. Secondo il Tribunale di sorveglianza in questione l'istanza doveva essere rigettata in quanto l'attività lavorativa prospettata non aveva un seguito sicuro, invece secondo la Corte di cassazione una motivazione di tal tipo alla base del rigetto deve considerarsi del tutto insufficiente, in quanto sussisterebbe il requisito della concretezza dell'attività lavorativa da svolgere nell'immediato, sufficiente per l'ammissione alla misura alternativa di cui si tratta.
242. Corte Cass., sez. I, 21 dicembre 2000, n. 11299, reperibile su Juris Data.
243. Circolare DAP 28 novembre 1990, n. 605156-13, cit.
244. Corte Cass., 28 aprile 1976, D'Antuono, riportata in R. Ciccotti, F. Pittau, Aspetti del lavoro carcerario nell'evoluzione giurisprudenziale, cit., p. 131.
245. Cfr. artt. 72 ord. pen. e 118 ultimo comma regol. penit. (D.P.R. 230/2000). Tuttavia la responsabilità del trattamento in misura alternativa continua a gravare sul direttore dell'istituto ex art. 101 comma terzo regol. penit.
246. Cfr. M. Vitali, op. cit., pp. 63 e ss; M. Pavarini, op. cit., p. 161; F. Ciccotti, R. Pittau, Il lavoro in carcere, op. cit. pp. 88 e ss.
Il parallelismo di discipline di cui si è detto comporta che anche per quanto riguarda il profilo della tutela giurisdizionale del prestatore di lavoro semilibero si debba addivenire alle medesime conclusioni, secondo cui la competenza al riguardo spetterà al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
247. Mag. sorv. Brescia, 31 luglio 1984, Mestriner in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" 1984, pp. 488 e ss.; Pret. Brescia, 13 novembre 1985, Mestriner c. Min. Giust, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" 1986, pp. 301 e ss.
248. Pret. Brescia, 27 novembre 1985, Mestriner c. Ditta Mestriner, in "Foro italiano" 1986, I, p. 1430.
249. Così Trib. Brescia, sez. lav., 22 maggio 1986, Mestriner c. Min. Giust., in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" 1986, pp. 490 e ss.
250. Argomentazione quest'ultima rinvenibile in tutte le sentenze appena citate.
251. Il comma quinto dell'art. 101 del regolamento penitenziario dispone che "l'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre", facendo pertanto chiaramente intendere che non solo è fatto divieto al semilibero di tenere presso di sé denaro durante la permanenza in istituto, ma che anche durante le ore passate all'esterno deve essere appositamente autorizzato a disporre di denaro, nei limiti della somma predeterminato, di cui per altro dovrà dar conto.
252. Corte Cass., 3 febbraio 1989, n. 685, cit., pp. 1093 e ss.
253. Circ. DAP 2 ottobre 1996, n. 577275/13.
254. Trib. sorv. Milano, 29 gennaio 1987, Bega, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" 1987, pp. 476 e ss.
255. Cfr. Trib. sorv. Firenze, 25 maggio 2004, Magistrini, riportata in L. Degli'Innocenti, F. Faldi, op. cit., p. 167.
256. Corte cass., 5 marzo 1979, Fienga, in "Rassegna di studi penitenziari e criminologici" 1980, pp. 270; Corte Cass., 27 settembre 1983, n. 623 cit.; Corte Cass. 3 febbraio 1989, n. 685 cit.
257. Per sottolineare tale diversità di situazioni, molti Tribunali di sorveglianza nominano il relativo provvedimento come "cessazione" o "annullamento" della semilibertà piuttosto che "revoca"; così L. Degl'Innocenti, F. Faldi, op. cit., p. 170. Peraltro lo stesso art. 70 ord. pen. nel prevedere le funzioni del tribunale di sorveglianza, accenna alla competenza in materia di "cessazione" dei benefici penitenziari.
258. Corte Cass., 3 febbraio 1989, n. 685, cit.
259. Cfr. M. Pavarini, op. cit., p. 96.
260. Così Corte Cost., 13 giugno 1985, n. 185, in "Foro Italiano", 1985, I, pp. 1888 e ss.
261. Sul punto si è avuta una lunga querelle giurisprudenziale, dal momento che fin dall'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario, vi era disaccordo fra la corrente secondo la quale la pena inflitta di cui all'art. 47 dovesse essere considerata la pena irrogata in sentenza, e l'opposta giurisprudenza secondo la quale il limite di pena dei tre anni doveva considerarsi come quantum di pena ancora da scontare, dunque come pena residuale. A porre fine alla discussione, è intervenuta la legge n. 356 del 1992, di conversione di un decreto legge, che ha fornito l'interpretazione autentica della disposizione in esame secondo la quale per "pena inflitta" deve intendersi "la pena da espiare in concreto, tenuto conto di eventuali cause estintive". Pertanto la giurisprudenza ha ormai pacificamente accettato l'equivalenza fra "pena inflitta" e "pena residua"; per un maggiore approfondimento cfr. M. Pavarini, op. cit., pp. 98 e ss.; L. Degl'Innocenti, F. Faldi, op. cit., pp. 16 e ss.; M. Canepa, S. Merlo, op. cit., pp. 255 e ss.
262. Si deve tenere in conto con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale del condannato, della disciplina restrittiva di cui agli artt. 4 bis e 58 quater ord. pen., che si è detto essere di generale applicazione nell'ambito dell'acceso ai benefici e alle misure alternative.
263. Cfr. artt. 47 commi nono e decimo ord. pen. e 97, comma nono, regol. penit.
264. Il periodo strettamente necessario di osservazione scientifica della personalità era in origine stato fissato in tre mesi, ridotti poi ad uno dalla riforma apportata dalla legge Gozzini (n. 663 del 1986).
265. Il meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione al fine di consentire la presentazione dell'istanza di misura alternativa si applica anche nell'ipotesi in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto per cui è emesso lo stesso ordine di esecuzione (art. 656 comma decimo c.p.p.).
266. Corte Cass., sez. I, 7 marzo 2007, n. 22739, cit.
267. Corte Cass., sez. I, 20 ottobre 1993, Costanzo, in L. Degl'Innocenti, F. Faldi, op. cit., p. 158.
268. Cfr. M. Vitali, op. cit., p. 63.
269. Corte Cass., 11 marzo 1993, Sica, in "CED Cass. pen.", n. 213558; Corte Cass., 26 giugno 1995, Battilomo, in "CED Cass. pen.", n. 202198; Corte Cass., 11 aprile 1996, Musto, cit.; Corte Cass., 14 luglio 1994, Panaro, in "Cassazione Penale", 1995, I, p. 56; Corte Cass., 27 maggio 1987, Santi, in "Cassazione Penale", 1988, p. 1521; Corte Cass., 25 ottobre 1994, Lerna, in "Cassazione Penale", 1995, fasc. 3, p. 75; Corte Cass., 26 gennaio 1995, Agnello, in "Cassazione Penale", 1995, fasc. 5, p. 25.
270. Corte Cass., 2 febbraio 1996, Della Corte, "CED Cass. pen.", n. 203890. In senso contrario Corte Cass., 16 febbraio 1995, Tummolo, in "Rivista penale", 1996, p. 877.
271. Corte Cass., 9 maggio 1994, Samà, in "Cassazione penale" 1994, fasc. 12, pag. 18.
272. Corte Cass., 22 novembre 1994, Pisano, in "Cassazione penale" 1995, fasc. 3, pag. 133, nella quale l'ammissione all'affidamento in prova era stato negato sul presupposto che l'attività lavorativa presentava "aspetti illeciti o truffaldini"; Corte Cass., 7 luglio 1995, Gallina, in "CED Cass. pen.", n. 203192.
273. Ad esempio è stata considerata legittima la revoca dell'affidamento in prova, concesso al soggetto richiedente con la prescrizione di svolgere una certa attività lavorativa presso un determinato datore di lavoro, per il fatto che il beneficiario abbia di sua iniziativa e senza informare il servizio sociale, interrotto il detto rapporto di lavoro e intrapreso un'attività lavorativa autonoma; Corte Cass. 14 novembre 1996, Selvaggio, in "CED Cass. pen.", n. 206515.
274. Così Corte Cost., 13 giugno 1985, n. 185, cit.; Corte Cost., 29 ottobre 1987, n. 343, in "Cassazione penale", 1988, pp. 25 e ss.
275. Cfr. supra § 9.2.
276. Non a caso particolare attenzione è posta dalla disciplina in materia ai rapporti e agli obblighi di solidarietà dell'affidato, sia nei confronti della "vittima del reato" che nei riguardi della propria famiglia; cfr. art. 47 comma settimo.