Capitolo 4
Rischio e governamentalità nel welfare europeo contemporaneo
Nei capitoli precedenti abbiamo illustrato le tendenze recenti del complesso rapporto tra politiche penali e sociali negli USA e in Europa utilizzando come chiavi di lettura le riforme del welfare e delle politiche del lavoro. Nei prossimi paragrafi cercheremo di mostrare che il welfare post-keynesiano si basa su un concetto di rischio sociale notevolmente diverso da quello usato nelle prime teorizzazioni del welfare novecentesco. Ricostruiremo, innanzitutto, la nozione di rischio elaborata da John Maynard Keynes e William Beveridge, che possono essere considerati i principali teorizzatori del welfare europeo del dopoguerra e, in secondo luogo, spiegheremo, facendo ricorso all'elaborazione dei sociologi della «società del rischio», la sua evoluzione nel welfare post-keynesiano. Proporremo, infine, una lettura foucaultiana di tale trasformazione, evidenziando come il rischio sia una delle strategie con cui si esercita la governamentalità, ovvero l'arte di controllo e governo della popolazione.
1. Rischio nel welfare keynesiano
John Maynard Keynes sosteneva che i moderni imprenditori fossero mossi da «spiriti animali» il cui agire non si ispira alle leggi del «rischio» o della «probabilità» quanto a quelle dell'incertezza (Keynes 1936, Cap. 12, § VII). La definizione di Keynes lascia, dunque, intendere che il concetto di rischio si riferisce ad eventi conoscibili o prevedibili, mentre quello di incertezza si riferisce ad eventi imponderabili. Altrove connette la nozione di rischio a quella di probabilità a proposito della quale dice: «of probability we can say no more than it is a lower degree of rational belief than certainty» (Keynes 1921, P. 15). Keynes, dunque, contrappone al concetto di certezza quello di incertezza e considera che il rischio, dal momento che è razionalizzabile secondo le regole logiche della probabilità, sia più prossimo al primo dei due. La nozione di rischio non aveva affatto la connotazione negativa che siamo abituati ad attribuirgli oggi, poiché era legato intimamente a quella di probabilità del verificarsi di un evento futuro il quale, anche se produttore di conseguenze non desiderabili, può essere gestito mediante il calcolo statistico. Su un analogo concetto di rischio si basava una della più importanti proposte di riforma del welfare inglese degli anni '40 del XX secolo, contenuta nel Beveridge report (Beveridge 1942) sulla quale ci soffermiamo perché ha influenzato in maniera significativa la nascita nell'immediato dopoguerra del welfare continentale.
Il promotore di tale progetto di riforma era William Beveridge, il quale era stato incaricato dal governo inglese di presiedere una Commissione che aveva il compito di analizzare il sistema di assistenza sociale britannico e di avanzare proposte di miglioramento. La commissione guidata da Beveridge arrivò alla conclusione che per combattere i mali sociali della Gran Bretagna degli anni '40, che erano identificati con la malattia, l'ignoranza, la povertà e l'ineguaglianza, bisognava introdurre un sistema di educazione pubblica gratuita, di assistenza sanitaria nazionale e, infine, un'assicurazione sociale statale a tutela del rischio di disoccupazione, finanziato grazie a contributi degli imprenditori, dei lavoratori e dello Stato stesso (Beveridge 1942). Tali proposte, contenute in testo noto con il nome di Beveridge Report, ebbero un notevole impatto nella definizione del welfare liberale anglosassone, poiché portarono all'introduzione della logica assicurativa nelle politiche sociali e contribuirono al definitivo superamento della dimensione localistica dell'intervento sociale ponendo così le basi per la nascita del welfare state.
Sulla necessità di ridefinire il ruolo delle politiche sociali pubbliche convergeva anche il pensiero di Keynes. Egli, pur non avendo mai mostrato un grande interesse per le problematiche sociali in se considerate ed essendo la sua attenzione rivolta maggiormente alle dinamiche del governo pubblico dell'economia, sosteneva la necessità che lo Stato monopolizzasse la gestione delle politiche sociali. Keynes partiva, infatti, dal presupposto che il mondo dell'economia non è retto da forze naturali che possono essere analizzate in termini di causa e di effetto, ma da una serie di variabili che possono essere descritte in termini di probabilità e che devono essere controllate da un'autorità centrale (Keynes 1936, Cap. 7). Alla base della nascita del welfare state del dopoguerra vi era, dunque, un ottimismo circa le capacità delle scienze statistiche di riuscire a guidare l'azione preventiva e compensativa del welfare. Eventi cruciali della vita di ogni cittadino che potevano avere effetti negativi sui redditi, come quelli legati alla nascita, al matrimonio e persino alla morte (Beveridge 1942), potevano essere compensati economicamente mediante un'assicurazione sociale pubblica. Ecco come Beveridge descriveva l'intervento dello Stato in veste di assicuratore:
the main feature for the Plan of Social Security is a scheme of social insurance agaist interruption of earning power and for special expenditure arising at birth, marriage or death. [...] The aim of the Plan for Social Security is to make want under any circumstances unnecessary.
(Beveridge 1942, p. 9).
Secondo tale concezione gli effetti economici negativi sui redditi derivanti dalla fisiologica instabilità del mercato del lavoro, possono essere monetizzati e risarciti, anche se, precisa Beveridge, i benefici sociali pubblici non possono mai avere una durata eccessiva e quindi avere un carattere assistenziale, ma devono essere limitati alla durata dell'evento dannoso e non possono comunque mettere il discussione il principio della responsabilità individuale (Beveridge 1942, p. 12). Il richiamo di Beveridge al principio della responsabilità individuale in un testo che prevede l'adozione di un modello di forte intervento pubblico nel sociale, non deve sorprendere poiché è assolutamente coerente con la sua formazione liberale, e in esso va rintracciato il tratto distintivo del welfare anglosassone rispetto a quello europeo continentale, in particolare a quello d'ispirazione cattolica. D'altronde Beveridge sosteneva di ispirarsi al principio di innovazione nel rispetto della tradizione tipico della «rivoluzione inglese» (Beveridge, p. 18). Egli, dunque, lontano da un concezione assistenziale e caritatevole dell'intervento sociale pubblico, poneva il problema della dipendenza degli utenti dal welfare e sosteneva che i benefici per tutelare il rischio di disoccupazione dovevano, in ogni caso, essere legati al versamento di contributi e potevano intervenire solo per sanare situazioni temporanee. L'elaborazione di tale limite era mutuata dalla definizione di rischio tipica del campo assicurativo, che lega il risarcimento del danno al verificarsi di un singolo evento. Beveridge lasciava, però, aperto il problema della durata dell'evento dannoso: quanto più questo si protrae, tanto più l'esborso dell'assicurazione deve essere consistente. Nel testo della commissione, infatti, la questione dei costi e della loro sostenibilità nel tempo viene analizzato ma non sono prospettate soluzioni a lungo termine. Il problema della dipendenza degli utenti dal nuovo sistema si sicurezza sociale era, dunque, già presente alla nascita del welfare. Lo stesso Keynes nel capitolo conclusivo della sua Teoria Generale (Keynes 1936), intitolato Concluding notes on the social philosophy towards which the general theory might lead, sosteneva che il problema della disoccupazione non poteva essere risolto in maniera autoritaria, ne poteva essere lasciata al laissez-faire del capitalismo individualista, ma che bisognava individuare istituzioni in grado di preservare allo stesso tempo l'efficienza dell'intervento regolatore dello Stato e la libertà d'iniziativa degli individui.
Nonostante i dubbi sulla sostenibilità finanziaria e i pericoli connessi alla creazione di forme di dipendenza dagli aiuti pubblici fossero noti, il welfare del dopoguerra si basò sulla nozione di rischio mutuata dal campo assicurativo anche perché vi era un diffuso ottimismo circa le capacità dello Stato di saper gestire tali eventualità. L'ipotesi della dipendenza degli utenti dai benefici compensativi, ad esempio, era considerata remota dal momento che, in una situazione in cui la crescita economica sembrava inarrestabile, la probabilità del verificarsi di eventi economicamente sfavorevoli per gli assicurati sembrava doversi ridurre sempre di più con l'aumento del benessere e con il raggiungimento di una situazione di pieno impiego.
La connotazione positiva della nozione di rischio posta alla base del welfare era strettamente legata all'ottimismo sulla capacità del sistema economico di continuare ad espandersi e a produrre ricchezza. Il rischio stesso che il welfare potesse diventare un onere insostenibile per le casse dello stato era valutato allo stesso modo con cui vengono valutati i rischi nel gioco d'azzardo: più le prospettive di guadagno sono alte più aumenta la predisposizione a correre rischi. Nel caso del welfare keynesiano il guadagno consisteva nella crescita della domanda di beni di consumo di massa e del benessere generale, il costo era rappresentato dalle politiche di sostegno dei redditi dei lavoratori. Come abbiamo visto nel primo capitolo, il fallimento delle promesse di crescita continua e la transizione al modello post-fordista hanno reso, invece, il welfare incapace di gestire i propri limiti e hanno fatto diventare concreti i dubbi di Beveridge e Keynes sulla sostenibilità del meccanismo assicurativo.
2. Rischio nella transizione from welfare to work
La scommessa persa degli ideatori del welfare del dopoguerra sulle capacità del sistema di non creare dipendenza degli utenti e sulla sua sostenibilità economica, ha portato sia all'adozione di nuovi strumenti di gestione dei rischi derivanti dall'instabilità del sistema economico, sia alla rielaborazione di una nuova nozione di rischio con cui le istituzioni devono confrontarsi. Il welfare della post-modernità cerca di venire a patti con i propri limiti e le proprie inefficienze, articolando in modo nuovo l'intervento a tutela dei rischi e lasciando che una parte di essi siano ora gestiti dagli individui. Il nuovo contratto sociale emerso da tale cambiamento è frutto di un processo articolato. Nel primo capitolo ci siamo soffermati sul fatto che alcune delle strategie utilizzate per far fronte alle gestione dei rischi economici legati all'organizzazione capitalista, come quello di disoccupazione, sono inefficaci nell'attuale sistema post-fordista e inadatte a gestire alcuni nuovi rischi, come quelli ambientali (Luhmann 1983, Beck 1986). Ma l'invecchiamento delle istituzioni del welfare e la sua incapacità di gestire il nuovo non sono le uniche spiegazioni del cambiamento.
Una prima importante chiave di lettura della transizione al welfare post-keynesiano è rappresentato dalla sfiducia nelle istituzioni sociali scaturita dal fallimento delle promesse del welfare del dopoguerra. Gli individui, infatti, a causa della sfiducia hanno acquisito consapevolezza della portata dei rischi sociali che si trovano a dover affrontare, in conseguenza della quale vivono nuovi sentimenti di insicurezza ed ansietà ai quali da soli non riescono a trovare un rimedio che finiscono così per cercare, ancora una volta, nello Stato. Da una parte, quindi, la sfiducia nei confronti del welfare è aumentata, a causa della nuova consapevolezza dei limiti dei processi decisionali che presiedono alla formazione e al controllo dei rischi (Luhmann 1993), dall'altra tale situazione, in un circolo vizioso, genera nuove e continue richieste alle istituzioni sociali. Luhmann nel suo saggio sulla Teoria politica nello Stato del benessere (1983) sosteneva che le cause della crisi del welfare keynesiano risiedono nel fatto che l'aumento del benessere ha innescato un meccanismo incontrollato di espansione delle politiche pubbliche. Possiamo, pertanto, sostenere che il welfare europeo nato con le riforme degli anni '80 e '90 del XX secolo, pur avendo arrestato tale espansione per evitare il tracollo finanziario, ha finito per alimentare ulteriormente quello stesso senso di insicurezza che dell'espansione era stato il principale motore.
2.1 Riflessività del welfare
Secondo Ulrich Beck la transizione al welfare post-keynesiano è solo un aspetto di un fenomeno più ampio rappresentato dalla crisi delle istituzioni sociali tradizionali verificatasi nella tardo modernità. Nell'analisi di Beck il welfare contemporaneo è un prodotto della transizione delle società post-industriali verso un modello che egli definisce di «società del rischio» (Beck 1986, trad. it. 2000). Nelle società occidentali contemporanee viene, infatti, attribuito al termine rischio un significato notevolmente diverso rispetto al passato. Nelle società preindustriali, ad esempio, i rischi, per quanto potessero consistere in eventi catastrofici e distruttivi, erano considerati come eventi frutto del fato e non controllabili in nessun modo poiché causati da entità superiori (Beck 1992). Nelle società industriali si afferma la nozione di rischio tipica della logica assicurativa che abbiamo descritto nel primo paragrafo. Secondo Beck questa concezione permette di de-individualizzare i rischi e di ricondurli ad una sistematicità che la sfera politica è in grado di governare. Da ciò derivava la sensazione diffusa di poter controllare il futuro e di poter trasformare eventi meramente potenziali in oggetti di azioni preventive nel presente (Beck 1992). Gli azzardi che l'industrializzazione portava con se venivano in tal modo annullati dalla creazione di sicurezze nel presente (Ewald 1991). Di conseguenza il welfare aveva una funzione meramente compensativa dei rischi prodotti dall'ordine economico e sociali capitalista.
Nella transizione alla società del rischio, invece, all'aumento della produzione delle ricchezza segue anche un aumento della produzione di nuovi rischi che possono condurre sino alla distruzione del pianeta (Beck 2000). L'approccio di Beck al tema del rischio è attraversato da una serie di descrizioni sulle possibili conseguenze della modernità che tradisce spesso un catastrofismo irrazionale, che viene mitigato, però, da un realismo sociologico che lo porta a distinguere il rischio in se considerato dalla sua percezione e a sostenere che «non è mai chiaro se sono i rischi ad essersi acutizzati o se è il nostro sguardo su di essi ad essersi fatto più attento» (Beck 2000, p. 70). Su questo punto fa maggiore chiarezza Giddens, il quale ritiene che i rischi siano allo stesso tempo degli avvenimenti oggettivi ma anche delle costruzioni sociali che vanno soggette al condizionamento di saperi esperti che li definiscono, li discutono e possono drammatizzarli o minimizzarli (Giddens 1990, trad. it. 1994). Egli sostiene, infatti, che la percezione del rischio dipende dal contesto economico e culturale in cui esso viene elaborato: ciò che è considerato un pericolo in un determinato momento da un certo gruppo sociale, può non essere considerato tale da un altro gruppo o in un'altra epoca (Giddens 1990, trad. it. 1994).
Sia Beck che Giddens concordano nel ritenere che la caratteristica che segna in maniera inequivocabile il passaggio alla società del rischio sia la riflessività della modernità, che definiscono come la tendenza della società a rimettere in discussione se stessa, diventando essa stessa un argomento di dibattito ed un problema da affrontare a livello globale (Beck 1999). La modernizzazione riflessiva consiste nella consapevolezza che è la modernizzazione stessa a produrre nuovi rischi e, in secondo luogo, nel dibattito sul fatto che tali rischi possono mettere in discussione l'ordine sociale su cui si regge.
Mentre per Beck la riflessività della tardo-modernità è dovuta principalmente all'aumento di rischi che la razionalità illuminista della modernità non è più in grado di controllare, in Giddens prevale, invece, l'atteggiamento relativista che lo porta a ritenere che nella tardo-modernità sia innanzitutto cambiato in maniera sostanziale il modo con cui affrontiamo i rischi e la sensibilità nei confronti di essi. Giddens ritiene che la riflessività abbia minato la fiducia nei saperi esperti che nella modernità consentivano un calcolo preciso delle conseguenze dei rischi e che abbia portato, di conseguenza, al diffondersi di un generale senso di insicurezza. La globalizzazione dei rischi non consente più l'uso degli strumenti assicurativi e compensativi che si sono sviluppati con la modernità, poiché gli strumenti di calcolo sono sempre meno affidabili. I pericoli della tardo modernità non sono più riconducibili alla nozione moderna di rischio, ma vanno invece ricondotti a quella di pericolo e d'incertezza tipica dell'epoca pre-moderna (Beck 2000). La nozione di rischio che, nell'analisi keynesiana della probabilità abbiamo visto essere più prossima a quella di certezza, si è dunque polarizzata sul suo contrario: l'incertezza.
Nell'analisi di Beck vi è un secondo processo, denominato «individualizzazione» il quale, al fianco della globalizzazione e della modernità riflessiva, ha determinato il passaggio alla società del rischio. Esso è il prodotto della crisi dei ruoli sociali vincolanti attribuiti dalle norme sociali tradizionali e dall'emergere di una nuova concezione in cui l'individuo è al centro della propria vita ed è capace di assumere, sulla base di proprie scelte, ruoli molteplici. L'individualizzazione sarebbe un prodotto della modernizzazione ed in particolare di fenomeni come l'istruzione di massa, del benessere economico diffuso e dei mutamenti del mercato del lavoro. Essa comporta che agli individui sia richiesto di essere i principali autori delle biografie personali, di costruire le proprie carriere lavorative e di competere sul mercato senza poter contare sulle istituzioni sociali tradizionali.
Vi è un punto dell'analisi di Beck sul quale vale la pena di soffermarci, quello relativo agli effetti dei nuovi rischi sulle disuguaglianze sociali. Egli sostiene che i rischi tendono a perpetuare e ad aggravare le disuguaglianze già esistenti, poiché la loro produzione e distribuzione incide più su alcuni gruppi sociali che su altri. Ma non approfondisce ulteriormente il tema e si limita ad affermare che, in fondo, i rischi della tardo-modernità incidono sui ricchi e i poveri in maniera uguale, poiché molti di essi non possono essere evitati neanche da chi dispone di risorse economiche elevate. Tale affermazione può essere considerata valida se riferita ad alcuni rischi, come quelli ambientali o quelli derivanti da una ipotetica guerra nucleare. Appare, invece, discutibile se riferita a quei rischi sociali prodotti dalla globalizzazione economica la quale ha esasperato le disuguaglianze sociali, permettendo agli strati più benestanti della popolazione di consolidare ulteriormente le proprie posizioni di potere e privilegio, grazie alle nuove possibilità offerte dai mercati, e mettendo, invece, le classi medio-basse in concorrenza su un mercato globale senza un'adeguata protezione dai rischi (Gallino 2000, p 81).
L'approccio della scuola dei sociologi del rischio è utile per mettere in luce alcuni tratti del welfare post-tradizionale, quello emerso cioè dalla crisi delle istituzioni sociali tradizionali. Il welfare tradizionale, affermatosi nel dopoguerra, si caratterizzava per due aspetti principali: anzitutto proteggeva gli individui dai rischi dell'industrializzazione con una logica economico-compensativa e, in secondo luogo, supportava l'autonomia ed il benessere individuale mediante l'erogazione di servizi pubblici come la sanità e l'istruzione. Il welfare post-tradizionale si caratterizza, invece, per il fatto che le istituzioni sociali si trovano a dover fare i conti con gli effetti negativi delle loro stesse politiche. Utilizzando le categorie elaborate dai sociologi del rischio, possiamo affermare che la riflessività del welfare post-tradizionale è dovuta alla consapevolezza della duplice natura dei suoi limiti e delle relative modalità con cui produce insicurezza. Anzitutto, possiamo sostenere che gli strumenti compensativi/assicurativi del vecchio welfare sono inadeguati ad affrontare i nuovi rischi. Questi ultimi sono emersi sia a causa della globalizzazione che del processo di individualizzazione. La globalizzazione ha, infatti, reso il mercato del lavoro un luogo insicuro in cui la competizione tra lavoratori non è più limitata entro i confini dell'economia nazionale, ma è globale. L'individualizzazione ha, invece, compromesso il ruolo di ammortizzatore dei rischi sociali svolto dalla solidarietà familiare e dalle comunità locali. Gli individui, indeboliti da questo nuovo stato d'insicurezza, continuano a cercare la soluzione ai nuovi problemi nelle vecchie istituzioni sociali, le quali non sono più in grado di risolverli e finiscono così per alimentare l'insicurezza che, a sua volta, tende ad esagerare la percezione soggettiva dei rischi facendoli apparire più gravi di quanto non potessero apparire nei regimi di welfare tradizionale.
In secondo luogo la riflessività del welfare consiste nel fatto che si è raggiunta la consapevolezza che le istituzioni sociali tradizionali, sia pubbliche che private, siano diventate inadatte anche ad affrontare i vecchi rischi dell'epoca industriale, come quello della disoccupazione, perché essi sono ora diventati globali e sfuggono al controllo degli stati nazionali. Anche tale aspetto della riflessività contribuisce ad alimentare l'insicurezza poiché gli individui sono più consapevoli che in passato dei limiti e dell'inaffidabilità dei saperi tecnici su cui basava il welfare tradizionale, grazie all'aumento del livello medio d'istruzione e della capacità di comprensione delle modalità di funzionamento delle istituzioni e dell'economia.
2.2 Una lettura foucaultiana della transizione al welfare post-tradizionale
L'approccio foucaultiano ai temi del rischio e del welfare, sposta il piano d'analisi rispetto a quello dei sociologi del rischio. Mentre questi ultimi si limitano a descrivere le variabili macrosociali che hanno determinato il passaggio alla tardo modernità, l'analisi foucaultiana della governamentalità ci consente di approfondire il tema del cambiamento della pratiche di governo della popolazione nella transizione al welfare post-keynesiano.
Secondo Foucault la governamentalità consiste di quel complesso di pratiche e tecniche di controllo della moltitudine che si sono sviluppate in Europa a partire dal XVI secolo dopo il crollo della società feudale (Foucault 1978) e la nascita, con la pace di Vestfalia, degli Stati moderni (Foucault 2004, p 16). Per Foucault il tratto distintivo di questa nuova razionalità del governo è rappresentato dal fatto che gli Stati in politica estera agiscono secondo un progetto limitato di conservazione della propria autonomia ed indipendenza rispetto agli altri Stati, mentre all'interno sviluppano la «polizia» che egli definisce come quel complesso di tecniche di governo della popolazione e della ricchezza finalizzate ad accrescere dall'interno la potenza dello Stato. E' solo a partire dal XVIII secolo, però, che gli Stati hanno iniziato a pensare ai propri cittadini in termini di popolazione e hanno iniziato a sviluppare quei saperi, si pensi alla demografia o alle numerose altre applicazioni della scienza statistica, e quelle tecnologie di governo che permettono di classificare la popolazione e di pianificare interventi di normalizzazione di masse di individui Mentre l'azione dello Stato all'esterno è limitata dalla presenza di una pluralità di Stati, quella interna è, invece, potenzialmente illimitata (Foucault 1979). La governamentalità liberale si caratterizza per il fatto di riuscire, mediante il ricorso ai saperi esperti, ad indurre gli individui ad adattarsi spontaneamente agli interessi ed alle esigenze generali senza bisogno di coercizione alcuna. Essa si rivolgeva, dunque, a cittadini definiti autonomi e capaci di autogoverno. I cittadini nei regimi liberali non hanno bisogno di subire forme di controllo coercitive, che non scompaiano ma assumono un ruolo secondario, in quanto si tratta di soggetti normalizzati che perseguono i propri interessi e la propria felicità affidandosi ai saperi esperti (Gordon 1991). Il sapere è di fatto lo strumento principale grazie al quale gli individui vengono indotti ad adeguarsi a costruire il proprio «sé» (Foucault 1992), così che, divenuti «imprenditori di se stessi» (Gordon 1991), essi continuino a rivolgersi ai saperi esperti che li guidano in un processo di massimizzazione delle proprie risorse.
Anche il rischio è ricondotto dalla scuola foucaultiana alle strategie della governamentalità. Castel, prendendo spunto dall'analisi dello Stato sociale francese e di quello statunitense, ritiene che il welfare utilizzi tecniche di calcolo e di valutazione che hanno ad oggetto l'intera popolazione e che permettono di elaborare politiche che, invece, di rivolgersi agli individui in quanto tali si rivolgono alla popolazione o a gruppi sociali selezionati a seconda delle esigenze. Le politiche del welfare hanno, dunque, ad oggetto fattori di rischio: «il rischio non ha origine dalla presenza di un pericolo determinato in un individuo o in un gruppo concreto. Esso è l'effetto di una combinazione di fattori astratti che rendono più o meno probabile il prodursi di forme di comportamento indesiderate» (Castel 1991, p. 287). In tale contesto le tecniche di controllo non sono più basate sull'osservazione del comportamento attuale degli individui, quanto piuttosto su quello futuro di «gruppi di rischio» (Castel 1991, p. 287). Secondo Castel, poi, l'uso del rischio come strategia della governamentalità ha favorito il passaggio da forme di controllo basate sulla pericolosità a forme di controllo basate sul calcolo attuariale. Mentre la definizione di un soggetto come pericoloso presuppone l'osservazione ravvicinata da parte di un professionista delle biografie individuali e la sua classificazione rispetto a categorie elaborate dai saperi esperti. La definizione di un individuo o di un gruppo come a rischio, invece, è molto più semplice perché si basa su statistiche e calcoli che hanno ad oggetto l'intera popolazione e che possono fare a meno dell'osservazione ravvicinata. Il concetto di rischio ha dunque il vantaggio di essere applicabile ad un numero di individui maggiore di quello di pericolosità.
Il welfare keynesiano nato nel dopoguerra può essere ricondotto agli strumenti attraverso cui si esercita la governamentalità. Foucault in una intervista raccolta nel volume Biopolitica e liberalismo sosteneva, infatti, che:
Il ben noto problema dello Stato assistenziale che mette semplicemente in evidenza le necessità o le nuove tecniche di governo del mondo attuale. Esso deve essere riconosciuto per quello che è: una delle numerosissime riapparizioni del difficile adattamento tra il potere politico esercitato sui soggetti giuridici e il potere pastorale che si esercita su degli individui viventi (Foucault 2001, p. 153)
Le politiche di welfare keynesiano erano, infatti, finalizzate a rafforzare la «propensione al consumo» (Keynes 1936) della popolazione, la quale veniva governata entro un sistema che tendeva a far interiorizzare un'etica del lavoro che identificava il successo mondano con il benessere che, a sua volta, consisteva nella possibilità di acquistare beni di consumo di massa, prodotti o dalle industrie private o dallo Stato sotto forma di servizi e sussidi. Una conferma di questo assunto viene, ad esempio, dalla posizione di Beveridge sui sussidi di disoccupazione. Nella definizione della disoccupazione egli prescindeva dall'analisi delle situazioni individuali e proponeva di pianificare, infatti, le strategie pubbliche di intervento nel mercato del lavoro basandosi sull'analisi dei fattori di rischio. Egli riteneva che la tecnica dell'assicurazione sociale pubblica non potesse coprire tutti gli eventi dannosi che accadono nella vita di un individuo, ma solo quelli riconducibili ad una statistica generale e che fossero compatibili con le esigenze pubbliche dell'economia e del mercato capitalista (Beveridge 1942). La disoccupazione era, in tale ottica, considerata come un fattore di rischio che minava l'ordine sociale ed economico capitalista in fieri. Stando così le cose, lo stesso progetto politico keynesiano del pieno impiego, fatto proprio dai regimi europei progressisti di welfare, può essere considerato un tentativo di normalizzazione governamentale della popolazione. Secondo Castel (1996), infatti, il salario nei regimi di welfare cessa di essere la semplice retribuzione per un lavoro svolto, per diventare invece un mezzo attraverso cui si attribuisce uno status fatto di nuovi diritti e doveri: da un parte la possibilità di benessere materiale, di nuove garanzie sociali e opportunità di mobilità sociale ascendente, dall'altra l'adesione all'ordine sociale ed economico del capitalismo fordista.
L'azione politica inizia ad investire in tal modo tutta la sfera del sociale, la logica assicurativa ha una natura elastica e invasiva che la rende applicabile a tutti gli ambiti in cui può estrinsecarsi il comportamento dell'homo oeconomicus. Affermava in proposito François Ewald nella sua opera sullo Stato sociale che: «Io stesso rappresento un rischio in senso attivo e questo nella misura in cui faccio correre dei rischi agli altri, ma anche in senso passivo nella misura in cui sono un rischio che gli altri devono correre. L'essere di ognuno, fondamentalmente, è un essere per l'altro. Un essere sociale» (Ewald 1986, p. 217, traduzione mia). In tal modo fenomeni che prima erano accettati con rassegnazione nella vita di un individuo sono ora trasformati in un rischio ed in un nuovo ambito in cui può concretizzarsi l'intervento normalizzatore dello Stato.
La massificazione dei bisogni degli individui operata dalle politiche di welfare del dopoguerra rappresenta solo un volto del processo di normalizzazione, il quale agisce infatti anche mediante un processo di individualizzazione. Foucault afferma in proposito che:
i meccanismi di assistenza e di sicurezza hanno effetti individualizzanti: fanno dell'individuo, del suo comportamento, della sua esistenza, non solo di quella di tutti, ma di quella di ognuno, un avvenimento rilevante, persino necessario, indispensabile per l'esercizio del potere nelle società moderne. L'individuo è diventato una posta in gioco fondamentale del potere. Paradossalmente il potere è tanto più individualizzante quanto più è burocratico e statale (Foucault 1998, p 112)
Si può, dunque, sostenere che la governamentalità progressista del welfare keynesiano agisce allo stesso tempo includendo ed escludendo. Include servendosi di politiche sociali, pianificate per categorie ben determinate (famiglie, lavoratori, disabili, malati, ecc.), che hanno come oggetto finale la normalizzazione dei comportamenti individuali. Esclude deresponsabilizzando gli individui e mettendoli nella condizione di poter godere delle protezioni sociali solo quando si trovano in una delle classi oggetto dell'intervento (Foucault 1998).
Secondo Dean (1997) la governamentalità affermatasi con il welfare keynesiano sarebbe stata successivamente ridefinita soprattutto a causa della critica neo-liberale a quello che è considerato, sia dai sostenitori che dai detrattori del welfare, un aspetto deteriore della politica sociale, cioè la passività e la dipendenza degli utenti dagli aiuti pubblici. Questa critica è stata, infatti, come abbiamo visto nel capitolo 2, centrale nel dettare le linee delle riforme del welfare statunitense degli anni '80 e '90. In realtà la critica liberale al welfare ha iniziato a produrre i suoi effetti nelle strategie di welfare sin dagli anni '50. Foucault sosteneva, infatti, che essa trae origine dal neo-liberalismo tedesco, all'interno del quale sin dal dopoguerra si è sviluppata la critica ai tre principi fondanti delle politiche sociali. Vediamo innanzitutto quali sono tali principi del welfare e, in secondo luogo, come sono stati confutati dalla critica liberale. Il primo di questi principi era rappresentato dall'idea che i processi economici del capitalismo produrrebbero, se non governati, effetti negativi sulla società in termini di disuguaglianza e distribuzione della ricchezza. Il secondo è rappresentato dall'idea che le politiche sociali servano a socializzare il consumo attraverso politiche di sostegno dei redditi e la produzione di specifici beni di consumo sociali, come l'istruzione o la sanità. Il terzo è rappresentato, invece, dall'idea che con la crescita economica aumenta anche la tendenza del mercato a produrre disuguaglianza e, di conseguenza, il welfare deve espandersi per porvi rimedio (Foucault 2004, p. 125).
Secondo quello che Foucault con un neologismo definiva «l'ortoliberalismo» (Foucault 2004, p. 125) la politica sociale non può avere come obiettivo nessuno di questi tre principi. Anzitutto, essa non può essere finalizzata a livellare le disuguaglianze, poiché il sistema di regolazione dell'economia di mercato si basa sul meccanismo di concorrenza il quale, al contrario, per poter funzionare ha bisogno di continue differenziazioni. Il mercato ha bisogno delle differenze di reddito, dei differenti livelli di produttività e dell'iniqua distribuzione della ricchezza, poiché la molla che fa scattare la concorrenza sono proprio tali disuguaglianze. Il welfare non può, poi, sottrarre parte di quanto viene prodotto in ricchezza e distribuirlo su altri redditi, poiché toglierebbe essenziali risorse all'investimento per trasferirli sul consumo. Il massimo che una politica sociale può fare è assicurare il minimo vitale a ciascuno, ma non deve in alcun modo avere come obiettivo la stabilizzazione della ricchezza. La critica al secondo principio consiste, invece, nel fatto che il welfare non può avere come obiettivo quello di socializzare i consumi. Lo Stato non deve assicurare protezione contro i rischi, ma deve piuttosto lasciare che l'economia cresca e che metta gli individui in condizioni economiche tali da permettergli di poter stipulare assicurazioni individuali a protezione dei rischi. Contrariamente a quanto sostenuto dai keynesiani - entriamo così nella critica al terzo principio - la crescita economica dovrebbe, in tal modo, aumentare di continuo il benessere individuale e rendere, di conseguenza, sempre meno necessario il ricorso all'intervento dello Stato (Foucault 2004)
La critica liberale è da sempre stata presente nella tradizione di welfare anglosassone, Foucault a proposito affermava che la si potrebbe «anzi considerare del tutto endogeno agli Stati Uniti» (Foucault 2004, p. 160). La distinzione tra due tipologie di programmi di welfare, presente sin dal New Deal, può esserne considerato un esempio rivelatore. La prima di queste tipologie consisteva in programmi modulati sullo schema di assicurazione sociale (sanità, istruzione, disoccupazione) che era selettiva e non a vocazione universale, dal momento che, al fine di prevenire la creazione di forme di dipendenza dall'aiuto di stato, la possibilità di ricevere i sussidi venne subito legata al versavano di specifici contributi previdenziali. Una seconda tipologia era quella di welfare assistenziale che proseguiva la tradizione delle leggi vittoriane sulla povertà e consisteva nella concessione di aiuti economici alle famiglie disagiate (si pensi ai programmi come l'AFDC, il TANF, Food Stamps). Come abbiamo visto nel secondo capitolo, la gran parte delle riforme e dei tagli al welfare statunitense hanno riguardato prevalentemente i programmi di welfare assistenziale del secondo tipo (Pierson 1994).
In Europa, invece, la critica liberale ha prodotto effetti più limitati ed allo stesso tempo più articolati sul sistema di erogazione dei benefici economici. Nel primo capitolo abbiamo visto che essa si è concretizzata nell'adozione di politiche che cercano di limitare sempre più, con l'introduzione dei means tested benefits, l'accesso al welfare assistenziale ai soli cittadini con basso reddito, nell'introduzione di misure riconducibili allo schema contributivo e, infine, nella tendenza a subordinare la concessione di alcuni benefici al fatto che gli utenti si mostrino attivi sul mercato del lavoro.
Tale differenza tra Europa e USA può essere spiegata con la distinzione che Foucault fa tra il liberalismo europeo continentale e quello nord-americano. Mentre in Europa il liberalismo è nato come strumento di limitazione, attraverso il principio dello stato di diritto, della ragion di stato, negli Stati Uniti esso ha, invece, costituito la ragione stessa per la costituzione di uno Stato indipendente dalla madrepatria inglese (Foucault 2004). Secondo Foucault, stando così le cose, il neo-liberalismo europeo ha agito ponendo dei limiti alla tendenza dello stato ad accrescere, mediante le politiche di welfare, il suo potere, mentre negli USA, al contrario, è stato il welfare ad essere percepito come una indebita intrusione nel liberalismo di Stato. Foucault a proposito della critica neo-liberale statunitense affermava:
[...] la critica economicista che i neo-liberali cercano di applicare alla politica governativa consiste nel filtrare ogni azione della potenza pubblica in termini di contraddizione, di inconsistenza e di non senso. La forma generale del mercato diventa uno strumento, un mezzo di discriminazione nel dibattito con l'amministrazione. In altre parole nel liberalismo classico si chiedeva al governo di rispettare il mercato e di lasciar fare. Nel neoliberalismo, invece, il laissez-faire viene rovesciato in un non lasciar fare il governo, in nome di una legge del mercato che dovrà permettere di misurare e di valutare ciascuna delle sue attività. Il laissez-faire, in questo modo, si capovolge, e il mercato smette di essere un principio di autolimitazione del governo, per diventare un principio di limitazione del governo, per diventare un principio che si ritorce contro di esso. Diventa una sorta di tribunale economico permanente di fronte al governo. (Foucault 2004, p. 202)
Secondo Dean (1997), però, la governamentalità neo-liberale ha iniziato ha condizionare, a partire dagli anni '70 ed '80 del XX secolo, le strategie del welfare di tutti i paesi occidentali in maniera sempre più evidente. Anzitutto essa starebbe portando al superamento di quella tendenza totalizzante ed invasiva del welfare descritta da Ewald (1986). Secondo Dean (1997), infatti, gli individui non agiscono più entro i confini sociali determinati dalle agenzie pubbliche di welfare. Le agenzie sociali pubbliche cercano ora di formare individui che siano in grado di auto-realizzarsi partecipando ad aggregazioni sociali deboli, in cui possono essere in grado di assumere di volta in volta ruoli diversi. Il loro compito non si esaurisce più nella sola erogazione di servizi. Secondo una strategia definita di «nuovo prudenzialismo» (Dean 1997, p. 224), infatti, le agenzie sociali spingono ora gli individui ad adottare comportamenti tesi a prevenire o a ridurre le conseguenze dei rischi e a spostare progressivamente la loro gestione dalle agenzie pubbliche agli individui o ad agenzie private. Il nuovo prudenzialismo tende a presentare questo spostamento di responsabilità come una nuova forma di libertà, come una liberazione dall'intervento oppressore dello Stato, il quale non tende più ad intervenire finanziariamente ed in maniera massiccia come faceva in passato, ma si limita a fornire assistenza alle iniziative degli individui e a premiare quelle che tendono a ridurre o prevenire i rischi.
Alla luce della tesi di Dean, potremmo dunque sostenere che, nonostante i diversi punti di partenza teorici del neo-liberalismo statunitense ed europeo individuati da Foucault, si sia registrata una convergenza sostanziale delle rispettive politiche pubbliche. Si potrebbe affermare, ad esempio, che le istituzioni dell'Unione Europea hanno assunto quel ruolo di tribunale economico permanente del governo e dell'amministrazione che negli Stati Uniti è svolto tradizionalmente dal mercato. L'UE assolve a questo compito grazie alle sue politiche economiche di liberalizzazione del mercato interno, alle sue politiche monetarie volte a contenere l'espansione spesa pubblica e, tramite di esse, a limitare il potere degli Stati d'intervento e di regolazione del mercato. Tutti questi elementi inducono a ritenere che ci sia un stato un effettivo avvicinamento delle politiche economiche e sociali europee al modello neo-liberale statunitense. Esistono però una serie di elementi che, invece, ci portano a ritenere che l'Europa abbia mantenuto una specificità anche nella transizione al welfare post-tradizionale. Anzitutto il fatto che l'introduzione di misure di workfare sia stata guidata dalle istituzioni dell'UE, rappresenta un elemento di continuità con la tradizione europea. Foucault notava, infatti, che l'introduzione di elementi neo-liberali nelle politiche sociali europee è risalente ed è spesso stata conseguenza di scelte politiche di auto-limitazione del potere pubblico, il quale ha sin dagli anni '50 integrato progressivamente le politiche assistenziali e/o di welfare con elementi di workfare. In secondo luogo, mentre negli Stati Uniti le politiche sociali non sono soltanto state informate alla logica del mercato ma si è anche lasciato, attraverso politiche di privatizzazione dei servizi e della assicurazioni sociali, che fosse lo stesso mercato a gestirle, in Europa permane, invece, una situazione di monopolio pubblico nell'erogazione dei servizi nonostante alcuni tentativi di riforma. (1) Non è, poi, da sottovalutare che il mantenimento di programmi di welfare generosi è dovuto alla necessità della classe politica di mantenere il consenso elettorale (Luhmann 1983). Il fatto che i programmi più costosi, si pensi a quello sanitario o a quello dell'istruzione, siano fruiti da tutti gli strati di popolazione li rende, infatti, difficilmente emendabili.
Come esempio della specificità del modello europeo rispetto a quello statunitense possiamo, poi, citare la politica europea sul lavoro. Il paradigma della flessicurezza che abbiamo analizzato nel primo capitolo può, a tutti gli effetti, essere definito come la via europea della governamentalità neo-liberale. Da un lato, infatti, i welfare europei continuano ad erogare sussidi di disoccupazione anche se - in ciò si riscontrano gli effetti della critica neo-liberale - tendono a farlo sempre più su base contributiva (ad eccezione dei Paesi scandinavi, tutti gli altri paesi dell'Europa continentale si stanno progressivamente conformando a tale indirizzo) e, soprattutto, li concedono solo ad individui che si mostrano attivi sul mercato del lavoro. Un altro esempio è costituito, poi, dalla tendenza a sostituire o integrare i sussidi economici con finanziamenti a corsi di formazione, in cui lo Stato dismette il suo ruolo di assicuratore per assumere quello, non meno paternalista, di consigliere e guida dell'individuo che ritorna, così, ad essere imprenditore di se stesso. Questo si è realizzato attraverso la creazione di nuovi saperi specifici che hanno ad oggetto l'orientamento lavorativo e che svolgono una funzione di primo piano all'interno della agenzie di collocamento, siano esse private o pubbliche. All'erogazione dei servizi e dei benefici rivolti ai disoccupati si sono, così, aggiunte nuove forme di assistenza, che vanno di volta in volta sotto il nome couselling, vocational training, lifelong learning, mediante i quali si classificano i disoccupati (sulla base dell'età, delle competenze, del genere, del titolo di studio, dell'area geografica di provenienza, ecc) e si studiano strategie d'intervento individualizzate. Tale processo di normalizzazione, però, non passa più attraverso la presa in carico dell'individuo mediante la condivisione attuariale del rischio sociale di disoccupazione, poiché è l'individuo stesso che ora deve prevenire il rischio, mettere a punto le strategie di protezione e farsi così carico della propria sopravvivenza sul mercato del lavoro. Nonostante lo spostamento della gestione dei rischi dallo Stato agli individui, non è scomparsa la logica assicurativa nei sistemi di protezione dai rischi sociali, poiché le politiche attive del lavoro hanno lo scopo di far interiorizzare agli individui la logica del calcolo attuariale nella gestione soggettiva dei rischi. E' l'individuo, dunque, non più e non solo lo Stato, a dover pensare al proprio futuro prevenendo e compensando i rischi.
La tendenza europea ad investire in formazione lavorativa per spostare la gestione del rischio di disoccupazione sugli individui va, però, valutata nel contesto di un progetto politico europeo in cui il pieno impiego è uscito dall'agenda politica dei governi - nonostante i proclami retorici del Consiglio di Lisbona - comportando così l'implicita accettazione da parte dei governi della disoccupazione come fenomeno normale. La disoccupazione non è più un problema sociale da risolvere con politiche pubbliche, ma è essa stessa un fenomeno sociale da governare.
Il governo della disoccupazione nelle politiche dell'UE si realizza attraverso nuove e vecchie strategie governamentali. Nel modello europeo sopravvivono, infatti, sia elementi del welfare tradizionale, come i sussidi di disoccupazione, che elementi di workfare. Una delle spiegazioni di questo fenomeno è che la critica alla dipendenza dal welfare tradizionale europeo non è maturata solo in ambienti politici liberali, ma è stata fatta propria anche dai social-democratici che hanno così proposto riforme in continuità con la tradizione solidaristica europea (Levitas 2005). Un esempio di quest'ultimo approccio viene dalla posizione di Anthony Giddens. Egli ritiene che le agenzie del welfare tradizionale inducano gli utenti alla passività, dal momento che ad essi non viene data alcuna libertà di scelta o la possibilità di poter personalizzare i servizi (Giddens 1999, 2007). Analoga critica era stata mossa dallo stesso Foucault, il quale affermava che:
Esiste indubbiamente una domanda positiva: quella di una previdenza che apra la strada a rapporti più ricchi, più vari, più diversificati e più flessibili con se stessi e con il proprio ambiente, in grado, nello stesso tempo, di garantire ad ognuno una reale autonomia. E' un fatto nuovo che dovrebbe pesare sulle concezioni attuali in materia di protezione sociale (Foucault 1998, p 186)
E' stato poi notato che la standardizzazione e massificazione dei servizi e delle prestazioni del welfare, permettendo uguale accesso al welfare sia ai ricchi che ai poveri, hanno fortemente compromesso anche il principio redistributivo (Titmuss 1958). Va precisato subito, però, che tale fenomeno non va considerato come una distorsione dei principi del welfare, dal momento che, al contrario, esso è frutto di scelte consapevoli presenti già nei primi progetti del welfare europeo. Ancora una volta ricorriamo al Beveridge Report (Beveridge 1942), nel quale si affermava che il nuovo sistema di sicurezza sociale doveva essere universalistico con l'avvertimento che: «nessuno può pretendere di pagare di meno perché è più in salute o possiede un impiego più regolare [...] Tutti gli assicurati, ricchi o poveri pagheranno gli stessi contributi per ottenere gli stessi servizi; coloro che dispongono di più mezzi pagheranno di più ma solo in quanto contribuenti fiscali» (Beveridge 1942 p. 13). Per Beveridge la redistribuzione della ricchezza poteva passare esclusivamente attraverso la diversificazione dei regimi fiscali, mentre il welfare doveva garantire eguali servizi e prestazioni a tutti i cittadini a prescindere dal reddito. Appena due decenni dopo la pubblicazione del Beveridge Report, Richard Titmuss (1958) già denunciava il fatto che il welfare beveridgiano aveva finito per garantire di più i meno bisognosi. Questo era accaduto anzitutto perché lo Stato faceva pagare a tutti in egual misura alcuni dei servizi sociali più costosi come quelli sanitari o d'istruzione, ma anche perché aveva con il tempo creato, attraverso la contrattazione privilegiata con gruppi d'interesse organizzati in lobby, una serie di prestazioni sociali specifiche che avevano rafforzato il benessere degli strati sociali più ricchi:
Gli sviluppi in tal senso degli ultimi dieci anni si sono quasi interamente concentrati sul terzo più ricco della popolazione specialmente per qual che riguarda pensioni, liquidazioni esenti da imposte, indennità per la perdita del posto di lavoro, assicurazioni sulla vita, indennità di malattia, tasse scolastiche, istruzione superiore, abitazioni, indumenti gratuiti, spese di viaggio, nonché una enorme varietà di benefici e vantaggi in natura (Titmuss 1958, trad. it. 1986, p. 207)
Questa tendenza alla diversificazione dei programmi ha portato il welfare contemporaneo, in special modo quello statunitense, a dualizzare la sua azione, limitandosi per gli utenti più ricchi ad erogare risorse (Jessop 1993, Pierson 1999) e creando, invece, un sistema di welfare stigmatizzante per i più poveri e dipendenti dal welfare (Sennett 2003). Di quest'ultima categoria, etichettata in maniera sprezzante come «underclass» da Murray (1984), facevano parte, secondo Bauman (1987), soggetti con bassi livelli di reddito, come gli anziani, i disoccupati o gli occupati nelle economie sommerse, i quali, non avendo una rappresentanza politica forte, non riescono a contrattare livelli di protezione adeguati. Richard Sennett nel suo Respect (2003) mostra che le politiche di workfare, adottate negli USA negli anni '80 e '90, sono nate non solo a causa della critica liberale, ma sono maturate anche in ambienti progressisti ed avevano l'obiettivo di liberare il welfare, rendendone la burocrazia più snella e offrendo servizi modulati sulle esigenze della persona. Sennett nota che, in realtà, si è finito per esasperare ancor di più la dualizzazione del welfare, perché si è lasciato che l'underclass affrontasse un mercato del lavoro molto più insicuro che in passato con il supporto di programmi sociali estremamente selettivi ed, al contempo, inefficaci.
A proposito dell'Europa si potrebbe affermare che negli stessi anni le riforme hanno avuto una ratio simile. Da un lato esse hanno, in effetti, riguardato solo in minima parte quei servizi garantiti in maniera uguale a tutti i cittadini, come quello dell'istruzione o della sanità, e non hanno spezzato, dunque, quella catena di privilegi garantita ai meno bisognosi descritta da Titmuss. Dall'altro, le riforme si sono concentrate su quei benefici, quali quello della protezione dei disoccupati, di cui tradizionalmente usufruiscono i settori più poveri e meno garantiti della popolazione. Le riforme del welfare hanno finito così per aggravare la distribuzione distorta delle risorse del welfare a vantaggio degli strati benestanti di popolazione.
Gli effetti della nuova governamentalità sui sistemi di welfare europei non ha, comunque, comportato un abbandono completo delle vecchie strategie. Nel modello europeo continuano, infatti, a convivere elementi del welfare tradizionale grazie ai quali si conservano i privilegi della classe media, mentre sono stati introdotti elementi del workfare che hanno l'obiettivo di spostare la gestione attuariale del rischio disoccupazione sugli individui, determinando così un risparmio per il welfare. Il quadro che emerge dalla lettura foucaultiana della storia recente del welfare europeo è, in sintesi, quello di un disegno complesso, in cui vecchie e nuove strategie governamentali si sovrappongono, in cui il welfare tradizionale convive insieme a nuovi istituti di workfare. Abbiamo sottolineato che la governamentalità neo-liberale europea agisce secondo strategie che allo stesso tempo includono ed escludono e che questa modalità duale d'azione si articola in maniera diversa a seconda dei programmi del welfare e delle tipologie di utenti. Abbiamo evidenziato, poi, che le politiche del lavoro tendono a riprodurre il fenomeno della disoccupazione dal momento che non rientrano più in una politica economica complessiva che ha come obiettivo il pieno impiego. L'esclusione dal mercato del lavoro non è più considerato un evento eccezionale nella vita degli individui ed il fatto che ci siano consistenti masse di individui disoccupati è un fenomeno normale. La riduzione del concetto di inclusione sociale a sinonimo di inserimento lavorativo, che abbiamo visto essere uno dei perni delle politiche sociali dell'UE, appare così essere assolutamente coerente con tale impostazione. La sicurezza del lavoro, un tempo caposaldo del welfare keynesiano, ha con il passaggio dal progetto politico di piena occupazione a quello di piena occupabilità, cambiato completamente significato. Nel nuovo disegno lo Stato non ha più l'obbligazione politica di garantire un lavoro, ma solo quello di garantire le condizioni per il funzionamento di un mercato del lavoro e di rafforzare la capacità dei lavoratori di resistere alla concorrenza.
3. Deriva securitaria dello Stato assistenziale europeo?
Loïc Wacquant (2000) ritiene che negli USA la transizione al welfare post-keynesiano abbia portato all'emergere di una nuova modalità di gestione della povertà e della marginalità sociale. Il fenomeno statunitense di detenzione di massa sarebbe dovuto al declino dello Stato assistenziale e alla sua sostituzione con lo Stato penale, il quale sta progressivamente intercettando la stessa utenza del primo. Si starebbe così affermando un modello di welfare leggero, in cui la gran parte delle risorse sono destinate ai programmi non-assistenziali di cui i principali beneficiari sono le classi medio-alte, al fianco di uno Stato penale finalizzato al controllo delle minoranze e delle classi povere. Wacquant ritiene che anche in Europa si stia verificano un fenomeno analogo. In effetti, abbiamo visto che l'Europa non è immune da quel trend di politica penale caratterizzato dall'inasprimento della severità delle sanzioni che, secondo Walmsley (2006), è comune ai ¾ circa dei paesi su scala globale. I segni della crescente influenza della governamentalità neo-liberale sono evidenti, come abbiamo visto, sia nelle politiche di welfare che in quelle penali. La nuova centralità data al concetto di responsabilità individuale dalla retorica liberale porta, infatti, ad interpretare fenomeni come la disoccupazione, che prima erano ricondotti alla responsabilità sociale collettiva, come fallimenti dell'individuo. Allo stesso modo il crimine tende a non essere più imputato al fallimento delle reti di controllo sociale preventivo, ma a consapevoli scelte individuali e, di conseguenza, è trattato con misure meramente repressive (Von Hirsh 1993, Ashworth 1995). L'utenza preferita delle carceri europee, cittadini nazionali e migranti con un basso capitale umano e sociale, coincide ogni giorno di più con quella stessa utenza del welfare assistenziale la quale sta perdendo sempre più terreno nella capacità di contrattare migliori protezioni sociali.
Nonostante alcune analogie, non ci sentiamo di sposare l'ipotesi di Wacquant sull'emersione dello Stato penale in Europa. Anzitutto perché egli sottovaluta che la deriva securitaria negli USA è stata resa possibile dal fatto che lo stato sociale statunitense si è sin dalla nascita caratterizzato per avere un welfare liberale per le classi medio alte, basato quindi sullo schema contributivo e su un mix di assicurazioni private e pubbliche, i cui programmi erano nettamente distinti da quelli del welfare meramente assistenziale riservato alle classi povere che era, invece, in continuità con la tradizione delle leggi ottocentesche sui poveri del Speenhamland. Da una parte lo stereotipo della madre nera single, abitante nelle periferie delle metropoli e dipendente dai sussidi pubblici, dall'altra quello del bianco di classe media che ha un contratto di lavoro che include l'assicurazione sanitaria e che versa i contributi a fondi pensione privati.
Il fatto che le politiche penali repressive neo-liberali abbiano colpito prevalentemente l'utenza del welfare assistenziale, che negli stessi anni veniva drasticamente ridotto, è stato reso possibile dal fatto che le politiche sociali americane l'avevano sempre tenuta distinta da quella del welfare liberale. La chiara separazione dei due modelli di welfare è anche la chiave di lettura che ha reso tale operazione sostenibile in termini elettorali e politici. La presenza di un welfare povero per i poveri ha portato alla graduale stigmatizzazione della povertà (Sennett 2003) e alla creazione di una vera e propria underclass composta perlopiù da minoranze etniche che vivono nelle periferie delle città e hanno elevati livelli di dipendenza dal welfare. L'esistenza di un gruppo sociale dalle caratteristiche socio-economiche omogenee, connotabili perlopiù anche in termini etnici, ha facilitato la produzione di quei discorsi di riprovazione morale dell'underclass (Murray 1984, 1996) sui quali è stato costruito il consenso politico per la riforma del welfare assistenziale e la sua sostituzione con forme di controllo penale. I discorsi dei neo-cons sull'underclass hanno prodotto, infatti, un concetto di esclusione sociale all'interno del quale un ruolo essenziale gioca la riprovazione morale dei poveri, i quali vengono accusati di non volersi assumere la responsabilità di competere nel mercato del lavoro e di non fare nulla per migliorare il proprio capitale umano (Murray 1984). La pigrizia, l'indolenza nell'accettare le regole del mercato e di preferire la strada dell'assistenza sociale pubblica e del guadagno facile nell'economia criminale, sono i discorsi principali che hanno convinto l'opinione pubblica americana ad accettare con entusiasmo l'idea che si tagliassero i programmi di welfare assistenziale. Le riforme di tali programmi non hanno inciso sul consenso elettorale dei governi di diverso colore politico che si sono succeduti dagli anni '80 ad oggi, perché esse non riguardavano la maggioranza degli elettori ma delle minoranze, le quali, oltretutto, man mano che dalle maglie del welfare sono state fatte cadere in quelle tentacolari del sistema penale sono state anche private del diritto di voto (2).
La situazione europea appare differente sotto molti aspetti. Anzitutto non vi è mai stata una differenza così nitida tra programmi di welfare liberale ed assistenziale. La presenza di programmi di welfare molto generosi e ad accesso universale, in settori come quello dell'istruzione, della sanità e, in parte, in quello delle pensioni, hanno fatto sì che tipologie di cittadini diversi, sia per capacità di reddito che per capitale umano, usufruissero dei medesimi programmi di welfare, che negli USA erano invece distribuiti in maniera molto più selettiva. Nei welfare europei, quindi, le fasce economicamente più deboli della popolazione si trovano ad usufruire contemporaneamente sia di programmi che sono loro espressamente riservati (sussidi alle famiglie, indennità di disoccupazione e tutto quel complesso di benefici distribuiti sulla base dei means tested benefits) sia di programmi cui accedono anche i benestanti (sanità, istruzione e pensioni). Se da una parte, quindi, è possibile attraverso la riforma dei programmi basati sul reddito dei percipienti selezionare solo quella fascia di popolazione povera e dipendente dall'aiuto pubblico, dall'altra questa continua comunque ad usufruire dei programmi di welfare più costosi, che in termini percentuale assorbono la gran parte della spesa sociale, i quali non vengono tagliati perché coprono anche quella parte della popolazione benestante che ha una rappresentanza ed un potere politico/elettorale rilevante. Tale fatto ha sinora impedito che i dipendenti del welfare fossero oggetto di riprovazione morale o stigmatizzazione, poiché in Europa le forme di dipendenza e di privilegio sono distribuite su una fascia di popolazione e di elettorato trasversale. Lo stesso termine underclass non è praticamente mai usato nei discorsi politici sulla povertà, ad eccezione della sola Gran Bretagna, mentre si preferiscono concetti come quello di esclusione sociale o di nuova povertà, che pongono l'accento sulle cause strutturali e culturali dell'esclusione sociale. Il più volte citato testo della Commissione Europea Growth, competitiveness, employment (1993), che ha posto le basi per delle attuali politiche sociali e del lavoro, individua, infatti, le cause dell'esclusione sociale in parte in fenomeni strutturali dell'economia e del mercato del lavoro e, in secondo luogo, nella mancanza di quella cultura del lavoro basata sull'apprendimento permanente. Anche i discorsi sull'esclusione sociale che sono stati copiosamente prodotti dopo il Consiglio di Lisbona continuano a riferirsi all'esclusione in questi termini. La perseveranza nel modello europeo di welfare di una siffatta lettura della povertà non ha permesso, dunque, di fare quel salto, compiuto negli USA, verso l'adozione di politiche meramente repressive della marginalità sociale.
Se, dunque, non ci sono i presupposti per fare delle analogie tra le modalità con cui si è realizzata la deriva securitaria dello stato assistenziale americano e la situazione europea, alcune similitudini sono invece evidenti nel trattamento dei migranti. Gli stranieri non comunitari, come le minoranze statunitensi, sono iper-rappresentati nel sistema penale e al contempo sono tenuti ai margini del welfare. Nei prossimi paragrafi mostreremo che la discriminazione dei migranti in Europa è il prodotto di un dispositivo di controllo che combina le politiche che regolano la migrazione, le politiche sociali e quelle penali.
4. Le politiche europee di immigrazione
Le Nazioni Unite stimano che circa il 3% della popolazione mondiale viva al di fuori del suo paese di nascita. L'emigrazione verso l'Europa ha conosciuto i suoi picchi all'inizio degli anni '90, quando i flussi erano di circa un milione l'anno, dalla fine degli anni '90 si è poi stabilizzata su una media di 700.000 annui. Il tasso di immigrazione europeo degli anni '90 è stimato sui 2,2 per 1000 abitanti, mentre quello degli USA è di 3. L'Europol stima che gli immigrati che arrivano irregolarmente ogni anno in Europa siano circa 500.000. La crescita dell'immigrazione è andata di pari passo con l'invecchiamento della popolazione europea, la popolazione over 65 dal 13% del 1975 arriverà ad essere circa il 22% nel 2025.
Per comprendere appieno l'attuale ratio della politica europea in materia di immigrazione è necessario anzitutto spiegare come dal dopoguerra ad oggi il fenomeno sia stato gestito dai governi europei. I paesi storici destinatari dell'immigrazione (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo e paesi Scandinavi) nel periodo del boom economico e dell'espansione delle politiche pubbliche di welfare, iniziato nel dopoguerra e conclusosi con la crisi petrolifera del 1973, consideravano l'immigrazione come un'importante risorsa economica e la gestivano con politiche liberali ed aperte. A metà degli anni '70 gli stessi paesi, in particolare Francia e Germania, iniziarono a subire gli effetti della recessione economica e della crisi fiscale del welfare e presero ad adottare, di conseguenza, politiche sociali meno generose che in passato e politiche di immigrazione più restrittive.
Negli anni '80, con l'allargamento dell'Europa al mediterraneo e la creazione del mercato interno, l'immigrazione inizia ad esse percepita come un problema politico europeo. La tendenza già diffusa nei paesi storici dell'immigrazione ad adottare politiche che scoraggino la stabilizzazione sul territorio dei migranti, viene di fatto imposta anche ai nuovi Stati. Nel 1986 durante in Consiglio Europeo di Londra gli Stati europei concordano un politica di immigrazione sostanzialmente repressiva. La circolazione nel mercato interno dovrà essere libera per le merci e per i cittadini comunitari, mentre dovrà essere il più possibile limitata per i non-comunitari. La restrizione delle possibilità di regolarizzare i migranti passa per la distinzione, formalizzata al punto 1.1.16 del documento approvato dal Consiglio, tra i richiedenti asilo e gli immigrati per motivi economici: «They agreed that asylum should not be granted for economic and financial reasons and that steps must be taken to counter abuse. They invited the relevant Ministers to concert action with a view to ensuring that the right of asylum is not abused.» La preoccupazione degli Stati Europei, soprattutto di quelli storicamente destinatari dei flussi migratori, era di distinguere tra l'immigrazione per motivi politici e quella per motivi economici, al fine di evitare che quest'ultima potesse essere regolata attraverso le legislazioni nazionali sull'asilo le quali, dal momento che riconoscevano il diritto all'asilo politico (3) avrebbero potuto finire per limitare la discrezionalità degli Stati.
Tra il 1986 ed il 1992 l'immigrazione viene gestita con meccanismi di cooperazione intergovernativa spesso affidata ad organismi che operano in maniera poco trasparente o inizialmente predisposti per occuparsi di altre materie, come il Gruppo TREVI, costituito in origine per occuparsi di terrorismo e traffico internazionale di droga. L'immigrazione viene trattata sostanzialmente come un problema di sicurezza interna degli Stati. E' solo con la creazione del mercato unico e la creazione del terzo pilastro dell'Unione Europea denominato Cooperazione nel settore della Giustizia e degli Affari interni (CGAI), che viene compiuto un salto nelle modalità di gestione delle politiche d'immigrazione. Nonostante con il CGAI venga creato uno specifico livello di coordinamento inter-governativo, il trattamento istituzionale della materia continua ad essere legato al tema della sicurezza. Eccezion fatta per la politica dei visti che viene da subito comunitarizzata, la politica migratoria è gestita, infatti, dai ministri della giustizia e degli interni dei vari Stati ed esclude, di conseguenza, un ruolo in materia della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Non si sono registrati significativi passi in avanti neanche dopo l'apertura fatta con il Trattato di Amsterdam (in vigore dal 1999) nel quale si è prevista la possibilità di comunitarizzazione le politiche sull'immigrazione. La stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo, con una consolidata giurisprudenza riconosce la sovranità degli Stati europei nella gestione dell'immigrazione (Santoro 2006). Nonostante tali limiti, l'UE ha contribuito in maniera significativa al consolidamento e alla diffusione di alcune tendenze e prassi comuni a tutti gli Stati membri. Tra queste, le due più significative sono la tendenza all'esternalizzazione dei controlli dei flussi e alla disincentivazione della stabilizzazione dei migranti sul territorio.
Il problema dei controlli dei confini esterni dell'UE è un problema che è stato legato sin dal Trattato di Maastricht a quello della sicurezza interna. La ratio della contestuale inclusione tra le materie del terzo pilastro delle politiche di sicurezza, giustizia e immigrazione, era di compensare l'eliminazione delle frontiere interne con un innalzamento del livello di sicurezza e di controllo sui migranti. Il rafforzamento delle frontiere esterne consiste nell'adozione di «misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione» (art 61 Trattato Amsterdam). La funzione compensativa delle politiche di controllo dell'immigrazione rispetto all'eliminazione delle frontiere interne risulta ancora più evidente dalla lettura dell'articolo 62:
«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; 2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri»
E' evidente che l'idea di controllo delle frontiere esterne dell'UE è una questione essenzialmente simbolica, ma che ha un significato altamente politico dal momento che l'abolizione delle frontiere interne spinge gli Stati ad intensificare i controlli sugli stranieri non comunitari e ad adottare politiche restrittive in materia di ingresso e permanenza. Un altro aspetto dell'esternalizzazione dei controlli è rappresentato dalla recente tendenza a stipulare accordi o cercare intese con gli Stati di provenienza dei flussi migratori, finalizzati a facilitare il reingresso dei clandestini. Queste tendenze vennero chiaramente espresse nel corso del Consiglio Europeo di Tampere del 1999, nelle conclusioni della presidenza si legge infatti:
26. Il Consiglio europeo chiede di sviluppare l'assistenza ai paesi di origine e transito, al fine di promuovere il rientro volontario e di aiutare le autorità di tali paesi a rafforzare la loro capacità di combattere efficacemente la tratta degli esseri umani e di adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell'Unione e degli Stati membri.
Sempre nel corso del medesimo Consiglio Europeo viene affermato, inoltre, che:
11. L'Unione europea ha bisogno di un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò significa che occorre combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, delle donne e dei bambini. [...] Un altro elemento fondamentale per il successo di queste politiche sarà il paternariato con i paesi terzi interessati, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo comune.
12. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del gruppo ad alto livello "Asilo e migrazione" istituito dal Consiglio e conviene il prosieguo del suo mandato e l'elaborazione di altri piani d'azione.
L'idea che l'immigrazione possa essere scoraggiata favorendo lo sviluppo economico dei paesi terzi appare demagogica in un contesto in cui la globalizzazione economica aumenta la competizione tra le varie economie e non favorisce la solidarietà di quelle più forti in favore di quelle deboli.
L'altra caratteristica delle politiche d'immigrazione dell'UE è rappresentata dalla tendenza a evitare la stabilizzazione dei migranti sul territorio. Abbiamo già visto che tale indirizzo politico è ampiamente accolto dagli Stati europei i quali adottano, infatti, provvedimenti restrittivi del diritto al ricongiungimento familiare. Esso è stato poi consolidato di recente con l'adozione della direttiva 2003/86/ce del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare. La direttiva nonostante sia adottata «in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale» pone, infatti, tutta una serie di limiti al diritto al ricongiungimento familiare tra cui la possibilità per gli Stati di limitarlo al solo coniuge e ai figli oppure la possibilità di limitarlo per i minori sotto i 12 anni di età non residenti con il richiedente. La direttiva prevede, inoltre, che il ricongiungimento possa essere richiesto dopo almeno due anni di residenza nel paese ospitante e che lo Stato possa attendere tre anni dalla domanda per concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
5. Politiche di immigrazione e welfare
La domanda che vogliamo porci in questo paragrafo è come mai il processo di europeizzazione delle politiche pubbliche mentre in settori come quello della politiche macroeconomiche e monetarie ha introdotto la logica del laissez-faire propria del mercato e ha portato, di conseguenza, ad una riduzione della capacità d'intervento degli Stati membri, in quello delle politiche d'immigrazione ha portato solo ad un consolidamento di tendenze comuni lasciando sostanzialmente intatta l'egemonia dei governi e delle amministrazioni nazionali. Le ragioni che spiegano tale contraddizione sono molteplici. La prima è legata ai limiti della cittadinanza marshalliana, la quale concede i diritti sociali ai soli cittadini. La seconda è più articolata essendo rappresentata, in parte, dalla necessità per Stati nazionali di contenere l'espansione finanziaria del welfare, per il quale l'immigrazione è allo stesso tempo un vantaggio e un costo, e in parte dalla volontà di continuare ad utilizzare i programmi di welfare come strumento di consolidamento del potere politico/elettorale e di mantenimento delle posizioni di privilegio degli attuali beneficiari.
5.1 I limiti della cittadinanza marshalliana
I welfare europei, come abbiamo mostrato nel primo capitolo, nascono entro i confini dello Stato nazione e la cittadinanza, di conseguenza, è considerata uno status indispensabile per l'accesso ai diritti sociali (Marshall 1950). In realtà, gli Stati europei hanno in parte superato questa concezione, legando l'accesso ai diritti sociali alla partecipazione al mercato del lavoro ed alla residenza protratta per lungo tempo sul territorio. Il primo elemento ha portato, come abbiamo evidenziato nel primo capitolo, ad introdurre nella cittadinanza sociale europea un meccanismo di inclusione/esclusione basato sullo svolgimento o meno di una attività lavorativa. Il secondo elemento ha fatto si che la gran parte degli Stati europei abbiano adottato leggi che concedono ai lavoratori non-comunitari, che risiedono per un lungo periodo sul territorio, praticamente gli stessi diritti che spettano ai cittadini. Nel secondo capitolo abbiamo illustrato alcuni esempi concreti di tali politiche. Esse funzionano grazie ad un altro dispositivo di inclusione/esclusione che dipende dal titolo legale di soggiorno posseduto, in base al quale possiamo distinguere quattro diversi status di immigrati, cui sono legati quattro tipi di modalità d'accesso al welfare:
- clandestini: esclusi dal welfare, con delle eccezioni rappresentate dal diritto all'assistenza sanitaria (4) e, se minori, all'educazione (5), e dal fatto che hanno accesso limitato ad alcuni servizi e benefici durante il periodo di detenzione in carcere;
- richiedenti asilo: accesso limitato a misure di assistenza sociale minime, diritto all'assistenza sanitaria e, se minori, all'educazione, permesso di lavorare massimo dopo un anno se non hanno ricevuto una risposta alla richiesta di asilo (6);
- migranti con permesso di soggiorno temporaneo: accesso limitato ai soli benefici del welfare legati allo svolgimento di un'attività lavorativa;
- migranti con permesso di soggiorno a tempo indeterminato e rifugiati politici (denizen): accedono agli stessi benefici sociali dei cittadini.
Le condizioni per l'accesso al welfare dei migranti hanno una declinazione più articolata rispetto all'originario criterio della cittadinanza e sono il frutto di aggiustamenti e riforme che sono procedute di pari passo con l'evoluzione delle politiche di immigrazione che abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi. Tali politiche agiscono configurando la cittadinanza sociale come uno status elastico che può adeguarsi alle esigenze delle economie e della finanze pubbliche e che può arrivare sino a conferire allo Stato il diritto di praticare l'esclusione degli stranieri. Secondo Balibar (2004) le ragioni di questa esclusione, oltre che risiedere nella tradizionale opposizione tra diritti civili universali e diritti sociali nazionali, derivano dal mancato compimento della cittadinanza sociale, la quale avrebbe dovuto, nel disegno originario dello Stato sociale, legare i diritti sociali allo status di lavoratore salariato. Egli afferma in proposito che:
Questa correlazione non è stata tradotta equamente dalle istituzioni e non esiste nei fatti anche se è presente dappertutto e da più di un secolo definisce il modello universale stesso [...] Quel che di fatto si produce, quindi, è una cittadinanza sostanziata dal «bene comune» dei nazionali in quanto lavoratori o aventi diritto nel senso più ampio del termine: una sostanza che è anche il «bene comune» dei lavoratori in quanto nazionali. Di conseguenza si può dire che il passaggio dalla cittadinanza alla cittadinanza sociale, dallo Stato nazione allo Stato nazionale-sociale, accentua considerevolmente la tensione tra la logica dell'universalismo e i meccanismi dell'esclusione interni che, evidentemente, ne rappresentano una contropartita. (Ivi, p. 105-106)
L'analisi di Balibar è interessante poiché mette in luce il fatto che il carattere nazionale della cittadinanza sociale legittima l'esclusione dei migranti, ma lascia in ombra il fatto che la stessa cittadinanza sociale, se legata allo status di lavoratore, comporta anche l'esclusione dei cittadini non lavoratori (7). L'UE, infatti, sulla base di tale concezione, permette agli Stati di limitare l'accesso a welfare anche ai cittadini comunitari non lavoratori residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine (Cfr. Cap. 1 §4.4). Come abbiamo visto, questa nozione di cittadinanza sociale è poi ampiamente usata nel welfare post-keynesiano per legittimare l'esclusione dal welfare di tutti quei soggetti che non si dimostrino attivi sul mercato del lavoro.
Le pratiche di esclusione dei migranti dal welfare sono, in alcuni casi, conseguenza indiretta di politiche sociali e d'immigrazione restrittive e si concretizzano, pertanto, in una discriminazione strutturale, mentre in altri casi sono frutto di normative che in maniera esplicita limitano l'accesso ad alcuni benefici. Cerchiamo, innanzitutto, di capire come funziona la prima forma di discriminazione. Nel primo capitolo abbiamo spiegato che uno degli effetti sul mercato del lavoro dei processi di globalizzazione economica e di europeizzazione è rappresentato dall'impoverimento dei lavoratori con basse qualifiche, denominati low skilled workers. La risposta dei welfare europei a tale fenomeno è stata di contenere le spese per i programmi, come i sussidi di disoccupazione, destinati a queste tipologie di lavoratori e di adottare le cosiddette politiche del lavoro attive per stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro. Gli immigrati appartenendo quasi esclusivamente a tale categoria e hanno, dunque, subito in maniera particolarmente accentuata gli effetti di tali riforme. La discriminazione deriva dal fatto che le politiche in materia di immigrazione, ponendo seri limiti alla possibilità per i migranti di stabilizzarsi sul territorio e subordinando la regolarità della loro permanenza allo svolgimento di un'attività lavorativa, finiscono per ridurre le possibilità di accesso al welfare dei low skilled workers stranieri rispetto ai nazionali.
L'esclusione esplicita dal welfare deriva, invece, dalle politiche degli Stati membri che limitano la concessione dei diritti sociali ai soli cittadini non comunitari che soggiornano regolarmente e per un lungo periodo sul territorio dello stato (i denizen), mentre essi prevedono una serie di restrizioni per quelli che hanno un permesso temporaneo. La normativa europea, infatti, spinge gli Stati a parificare la posizione dei denizen con quella dei cittadini comunitari, lasciando sostanziale discrezionalità nel disciplinare lo status degli stranieri che hanno un permesso di soggiorno temporaneo. La Direttiva n. 109/2003 del Consiglio Europeo del 25 novembre 2003 intitolata Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo formalizza la parificazione tra denizen e cittadini stabilendo che alle:
«persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea» (Consiglio Europeo 2003, corsivo mio)
La stessa direttiva all'articolo 4 stabilisce che il periodo di soggiorno ininterrotto richiesto per poter ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo è di 5 anno. La condizione cui viene subordinata l'inclusione entro i regimi nazionali di sicurezza sociale è rappresentata, però, dal fatto che gli stranieri possiedano un reddito stabile e non siano quindi solo un onere per gli Stati membri:
(6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. [...].
(7) Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l'adempimento degli obblighi fiscali.
(Consiglio Europeo 2003)
La Direttiva impone, inoltre, che gli Stati per riconoscere il pieno diritto alla sicurezza sociale non si debbano limitare ad accertare la residenza protratta per lungo periodo ed il possesso di risorse economiche, ma che rilascino uno specifico titolo di soggiorno (8): «Il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico» (Consiglio Europeo). Come abbiamo evidenziato il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo porta al riconoscimento non degli stessi diritti dei cittadini ma solo di diritti «simili», la direttiva stabilisce, infatti, che gli Stati possano limitarsi a riconoscere le prestazioni «essenziali» dell'assistenza sociale che sono identificate con «un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine».
Lo status di soggiornante di lungo periodo è, poi, la condizione per poter accedere al diritto alla sicurezza sociale in caso di mobilità all'interno dell'UE, riconosciuto dal regolamento 1408/71, ora sostituto dal regolamento 883 del 2004 sul Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Cfr Cap. 1, § 4.4). Il regolamento 883/2004 prevede che il cittadino che si sposti all'interno dell'UE possa godere dei diritti alla sicurezza sociale acquisiti nel paese d'origine, possibilità che era stata già estesa dal regolamento 859/2003 anche agli stranieri regolarmente soggiornanti che si spostano all'interno dell'Unione Europea. Questo diritto non si estende automaticamente ai tutti gli stranieri regolari, la direttiva 109/2003 stabilisce, infatti, che il diritto di soggiorno in uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno sia un diritto dei soli migranti che hanno lo status di soggiornante di lungo periodo.
Il fatto che la Direttiva imponga agli Stati di parificare la posizione dei soli migranti in possesso dello status di «soggiornanti di lungo periodo» lascia intendere implicitamente che ai residenti temporanei possa, invece, essere riconosciuto dalle legislazioni nazionali uno status che comporti un accesso ridotto al welfare. Un esempio di tale pratica di esclusione viene dalla normativa italiana. La legge 288 del 2000 stabilisce, infatti, che le prestazioni di assistenza sociale - non quindi quelle di sicurezza sociale (9) - possano essere concesse solo ai titolari di permesso di soggiorno CE. Questa norma porta ad escludere che i titolari di un semplice permesso di soggiorno rinnovabile possano accedere ad alcuni dei benefici sociali più costosi: come l'assegno sociale, la pensione d'invalidità e l'assegno di maternità (10). Recentemente alcune pronunce giurisprudenziali, per ora rimaste isolate, hanno ridotto la portata della limitazione stabilita dalla legge 288/2000. La prima cui facciamo riferimento è del Tribunale di Trento il quale, con sentenza 202/2004, stabiliva che l'assegno di invalidità può essere concesso anche allo straniero che abbia solo un permesso di soggiorno rinnovabile. Il Tribunale argomentava la sua decisione sostenendo, in primo luogo, che l'assegno di invalidità rientra nella definizione di sicurezza sociale e, in secondo luogo, che il regolamento 859/2003 estende l'ambito di applicazione della direttiva 1408/71 sulla sicurezza sociale (ora sostituita dalla direttiva 883/2004) anche agli stranieri. La prima argomentazione appare valida anche alla luce del fatto che il nuovo regolamento 883 del 2004 allarga il concetto di sicurezza sociale includendo esplicitamente l'assegno di invalidità (Cfr. Cap.1, p. 32). La seconda argomentazione ci sembra, invece, discutibile dal momento che il regolamento 883/2004, come abbiamo visto, ha solo la funzione di coordinare i regimi di sicurezza sociale e si limita a stabilire il principio di esportabilità dei benefici acquisiti nel paese europeo di provenienza del lavoratore, e che il regolamento 859/2003 si limita ad estendere questo meccanismo agli stranieri ma non crea affatto un diritto alla sicurezza sociale per i non-comunitari. Il regolamento 859/2003 comporta soltanto che lo straniero che si sposta all'interno dell'UE possa continuare a godere di quei benefici che gli erano stati concessi sulla base della legge del paese europeo di provenienza. Le altre sentenze cui facciamo riferimento, Tribunale di Verona n 37 e 38 del 26 maggio 2006, evitano, infatti, di incorrere nello stesso errore del Tribunale di Trento e si limita a riconoscere il diritto all'assegno di invalidità sostenendo che esso è una misura di sicurezza sociale, concedibile quindi anche agli stranieri con permesso temporaneo, e non di assistenza sociale, concedibile, invece, solo ai titolari di permesso di soggiorno CE. Secondo il Tribunale di Verona rientrano nella definizione di assistenza sociale esclusivamente quei benefici concessi discrezionalmente dagli enti locali. L'assegno di invalidità è, invece, un beneficio concesso con legge dello Stato in maniera automatica al verificarsi delle condizioni previste e rientra, di conseguenza, nel sistema di sicurezza sociale che si estende anche agli stranieri con semplice permesso di soggiorno.
La Corte Costituzionale italiana è stata chiamata a pronunciarsi sulla disparità di trattamento tra stranieri ed italiani provocata dalla legge 288/2000 (11). Essa si è, però, limitata a dichiarare inammissibile il ricorso sostenendo che nel caso sottopostole (12) il giudice a quo avrebbe potuto ammettere, sulla base del principio di irretroattività delle modifiche alle norme di previdenza sociale, il diritto dello straniero a continuare a beneficiare dell'assegno di invalidità, riconosciutogli sulla base della precedente normativa, anche dopo l'entrata in vigore della legge 288/2000, senza dover sollevare la questione di costituzionalità della medesima legge. La Corte non si è così pronunciata sulla questione della parità di trattamento tra stranieri ed italiani, che resta insoluta.
5.2. L'immigrazione come risorsa e come costo
Passando ad analizzare la seconda ragione dell'adozione di politiche che, in vario modo, escludono o limitano l'accesso dei migranti ai diritti sociali, bisogna innanzitutto dire che l'aumento della domanda nel mercato europeo di manodopera straniera a basso costo è coincisa con la crisi fiscale del welfare e la tendenza già in atto alla contrazione della spesa sociale. Tali fatti hanno portato a considerare l'immigrazione come una risorsa indispensabile per far fronte alle sfide dell'internazionalizzazione dei mercati e, al contempo, come un costo insostenibile per il welfare.
Sono numerosi i documenti dell'Unione Europea nei quali l'immigrazione è definita un risorsa fondamentale per le economie europee, non ultimo il Libro Verde sull'immigrazione nel quale si legge:
[...] prendendo atto dell'incidenza del calo e dell'invecchiamento demografico sull'economia, la Commissione ha evidenziato la necessità di rivedere le politiche in materia di immigrazione a più lungo termine 4, soprattutto alla luce delle ripercussioni che una strategia in materia di immigrazione economica avrebbe sulla competitività e quindi sulla realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Sono proprio le tendenze demografiche che hanno stimolato il dibattito sull'immigrazione nell'UE, senza mettere in discussione il diritto degli Stati membri di stabilire il numero di migranti da ammettere. Di fatto, anche se gli obiettivi occupazionali di Lisbona fossero conseguiti entro il 2010, i livelli generali di occupazione sarebbero comunque destinati a subire un calo a causa del cambiamento demografico. Nel periodo 2010-2030, al ritmo degli attuali flussi migratori, il calo della popolazione in età attiva nell'UE-25 comporterà una riduzione del numero degli occupati di circa 20 milioni di unità. Questi sviluppi avranno un forte impatto sulla crescita economica generale, sul funzionamento del mercato interno e sulla competitività delle imprese dell'Unione.
In tale contesto, e sebbene l'immigrazione in sé non rappresenti una soluzione al problema dell'invecchiamento demografico, saranno necessari sempre maggiori flussi migratori per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro dell'UE e per garantire la prosperità dell'Europa. (Commissione Europea 2005: p.3)
Non esistono, invece, documenti ufficiali dell'Unione Europea in cui l'immigrazione è definita esplicitamente come un costo, ma tale valutazione può considerarsi come assunta implicitamente nelle politiche dei paesi europei. Come abbiamo visto analizzando i casi Spagna, Italia, Germania e Svezia, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, esiste una tendenza diffusa ad adottare politiche discriminatorie che limitano il più possibile l'accesso dei migranti al welfare. Tali politiche si fondano su valutazioni di carattere politico/elettorale ed economico, che analizzeremo di seguito.
Titmuss (1958), nei suoi saggi sul welfare pubblicati negli anni '50, evidenziava che il welfare europeo aveva, a causa della contrattazione privilegiata con gruppi d'interesse, esteso notevolmente il suo ambito di intervento andando molto oltre l'originaria funzione di ridistribuzione ed assistenza delle fasce di popolazione più povere. Questo fattore, tuttavia, non comporta il venir meno della funzione redistributiva del welfare, ma evidenzia semmai la sua dipendenza dai meccanismi che regolano la rappresentanza politica. Si può quindi sostenere che i migranti, non avendo un peso politico-elettorale, non riescono a beneficiare di una protezione sociale pari a quella dei cittadini comunitari.
Meltzer e Richard in un seminale articolo intitolato Tests of a rational theory of the size of government (1981) consideravano l'espansione della spesa pubblica direttamente proporzionale all'estensione della fascia di elettorato dipendente dalle politiche pubbliche e dal loro livello di povertà. Essi assumevano che quanto fosse più ampia e decisiva a fini elettorali tale fascia di elettorato, tanto più il sistema fiscale tendeva ad avere alti livelli di tassazione ed il welfare ad essere generoso. La ridistribuzione opera, infatti, solo in un sistema in cui il livello di prelievo fiscale è articolato in maniera diversa sui redditi. Il livello di tassazione/ridistribuzione del reddito è determinato in concreto da un equilibrio politico-economico tra gli interessi di quelli che guadagnano e di quelli che perdono dalla ridistribuzione effettuata grazie al prelievo fiscale (Razin, Sadka e Swagel 2002).
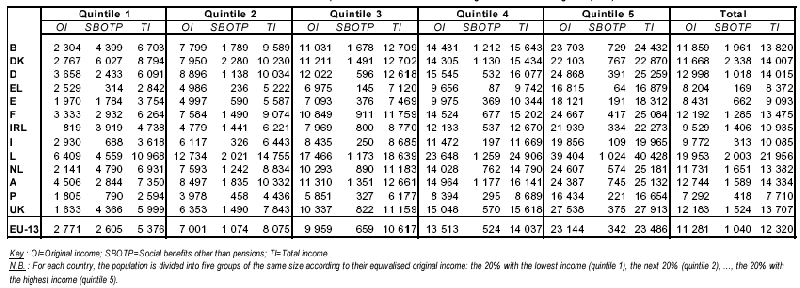
Nella tabella elaborata dall'Eurostat (2000) si vede l'effetto redistributivo dei benefici sociali sui redditi. L'effetto redistributivo è valutato per fasce di reddito (quintile) che sono ordinate in ordine crescente da sinistra verso destra. Nella colonna Quintile 1, ad esempio, dove ci sono i redditi più bassi si vede che i reddito al netto dei benefici sociali (OI) è di gran lunga più basso rispetto a quello che li include (SBOTP), la differenza si assottiglia man mano che si sposta verso le fasce di reddito più alte. I redditi che appartengono alle fasce più alte sono quelli che perdono nella ridistribuzione fiscale, perché pagano di più rispetto a quello che ricevono.
Al contrario di quanto si pensa comunemente, la presenza di migranti appartenenti alla categoria dei low skilled workers, che abbiamo visto essere quella che beneficia maggiormente della ridistribuzione fiscale, ha portato in Europa ad avere un carico fiscale ed un livello di distribuzione inferiore di quello che ci sarebbe stato senza l'immigrazione. Facchini, Razin e Willmann (2004) arrivano a questa conclusione analizzando il rapporto tra carico fiscale, estensione del welfare e flussi migratori in 10 Stati europei (13) tra il 1974 ed il 1992. Ci si sarebbe aspettato che l'aumento dei low skilled workers, determinato dall'immigrazione, portasse all'aumento dei costi del welfare per l'incremento dei beneficiari della ridistribuzione del carico fiscale, ma questo non si è verificato perché da una parte, per compensare la crescita degli utenti, i programmi di welfare sono stati ridotti e perché, dall'altra, i migranti sono stati tenuti ai margini del sistema di ridistribuzione. L'immigrazione produce politiche reazionarie a difesa delle posizioni dei beneficiari della ridistribuzione operata attraverso il welfare, posizioni che si sono determinate con i meccanismi di contrattazione e rappresentanza politica. La distribuzione dei benefici del welfare dipende, infatti, dall'attività di lobbying degli utenti, i quali tendono a difendere i privilegi acquisiti. Questo attività, in una situazione di espansione dello Stato sociale, non è finalizzata a contrastare l'inclusione di nuove categorie nel welfare, dal momento che ci sono risorse sufficienti. Al contrario, in un periodo di contrazione della spesa pubblica, poiché l'inclusione di nuovi soggetti nel welfare porta inevitabilmente ad una ricontrattazione a ribasso dei benefici, l'attività di lobbying tende a contrastare l'allargamento dell'utenza.
Facchini et al. (2004) ritengono, infatti, che l'immigrazione sia percepita dai contribuenti del welfare in due modi opposti: come un fattore di complementarietà e come un fattore di sostituzione. I principali beneficiari della ridistribuzione fiscale e dei benefici del welfare, normalmente costituiti da low skilled workers, considerano l'immigrazione come un fattore di sostituzione, dal momento che essa, facendo aumentare il numero dei beneficiari, diminuisce il livello pro-capite di reddito ridistribuito. Al contrario, coloro i quali contribuiscono di più alla ridistribuzione fiscale considerano l'immigrazione di low skilled workers un fattore positivo di complementarietà, in grado di sostenere la produttività dei sistemi economici e di aumentare il loro livello di benessere. Si può, dunque, affermare che quanto più le categorie che percepiscono l'immigrazione come un fattore di sostituzione riescono ad organizzarsi e ad avere un peso ed una rappresentanza politica forti tanto più i governi tendono ad adottare politiche repressive dell'immigrazione. Le politiche d'immigrazione dei governi sono così il prodotto di un'azione di lobbying che vede come interpreti principali queste due tipologie di contribuenti.
Facchini et al. (2004) spiegano il mancato aumento del livello di ridistribuzione e di gettito fiscale derivante dalle migrazioni con il fatto che i migranti agiscono come fattore di sostituzione. Come abbiamo visto, ad integrazione di questa spiegazione, i migranti sono tenuti ai margini del welfare per ragioni politico-elettorali. Questa impostazione presuppone che i low skilled workers europei abbiano un peso politico tale da indurre i governi e le amministrazioni a concedere tutele sociali inferiori ai migranti al fine di preservare le proprie. Tale spiegazione appare, da sola, eccessivamente semplicistica e lascia delle zone d'ombra. Gallino (1998) ha sottolineato, infatti, che la globalizzazione del mercato del lavoro e la flessibilità hanno indebolito fortemente i low skilled workers europei i quali non riescono a darsi una rappresentanza politico-sindacale forte come in passato. La scarsa capacità di lobbying di questa tipologie di lavoratori è tale da aver permesso che venissero sacrificati sull'altare del libero mercato e della concorrenza con una certa facilità anche dai governi europei social-democratici. Stando così le cose, possiamo dubitare a ragione i low skilled workers europei abbiano condizionato le scelte dei governi in materia di immigrazione. E' proprio la presenza in misura massiccia di migranti che ne ha abbassato ulteriormente la capacità di lobbying. Cerchiamo di capire come ciò sia avvenuto.
Il fatto che i migranti agiscano come fattore di sostituzione ha comportato, infatti, non solo che essi assorbissero parte dei redditi destinati ai lavoratori nazionali attraverso la ridistribuzione fiscale, ma anche che diventassero un fetta consistente dell'utenza tipica dei benefici destinati ai low skilled workers distribuiti sulla base della regola means tested benefits. Il fatto che l'utenza di questi programmi di welfare sia costituita sempre più da migranti, che si stanno progressivamente sostituendo ai nazionali, comporta l'indebolimento del suo potere di lobbying, dal momento che i migranti hanno un peso politico-elettorale molto più basso dei nazionali. Questo permette ai governi nazionali di poter abbassare la quota di gettito fiscale ridistribuito attraverso means tested benefits come i sussidi per la disoccupazione e per le famiglie. Come abbiamo spiegato nel primo capitolo, infatti, le riforme ed i tagli al welfare europeo verificatosi a partire dall'inizio degli anni '90 - gli stessi anni in cui le politiche migratorie dell'UE hanno iniziato a produrre i loro effetti - hanno avuto ad oggetto proprio tali settori. Le politiche attive del lavoro e i programmi di workfare hanno, infatti, prodotto effetti negativi, sia in termini di ridistribuzione fiscale che di diminuzione della protezione dal rischio disoccupazione, proprio sui low skilled workers. Le politiche d'immigrazione poi, dal momento che pongono ostacoli all'accesso dei migranti ai benefici sociali, sono lo strumento attraverso cui si distribuiscono questi effetti in maniera iniqua tra nazionali e stranieri.
Le politiche di welfare e d'immigrazione della Germania che abbiamo descritto nel capitolo precedente, rappresentano un caso emblematico di tale politica. Da un lato abbiamo visto che, man mano che è aumentata l'immigrazione dei low skilled workers, si sono adottate politiche dell'immigrazione restrittive che hanno privilegiato l'immigrazione per i lavoratori qualificati o specializzati. Allo stesso tempo l'introduzione delle politiche attive del lavoro ha danneggiato i low skilled workers che nel welfare corporativista tedesco avevano un peso politico e sindacale inferiore a quello delle altre categorie.
Possiamo, dunque, affermare che i lavoratori migranti agiscono non soltanto come fattore di sostituzione rispetto ai lavoratori nazionali, ma anche come fattore di abbassamento generale del livello di protezione sociale assicurata alle fasce più deboli dei lavoratori, nazionali inclusi. Questo spiega come mai nei paesi considerati dallo studio di Facchini et al. il livello di ridistribuzione, invece di aumentare grazie all'extra gettito fiscale dei migranti sia, al contrario, diminuito.
Il fatto che la presenza di immigrati nel mercato del lavoro tenda ad abbassare le protezioni sociali dei lavoratori è confermato dal fatto che le organizzazioni sindacali europee sono state storicamente contrarie all'adozione di politiche che favoriscono l'immigrazione. Penninx et al. (2000), in uno studio sul rapporto tra sindacato ed immigrazione in Europa, evidenziano che sin dagli anni '60 le organizzazioni sindacali hanno osteggiato, soprattutto in paesi storici d'immigrazione come la Germania o la Svezia, l'adozione di politiche d'immigrazione liberali, perché creavano una forza di lavoro di riserva la quale, dal momento che si componeva di migranti che accettavano paghe ridotte e benefici più bassi, riduceva la forza delle rivendicazioni dei lavoratori nazionali. Come abbiamo visto nel precedente capitolo, la Svezia per un periodo limitato di tempo ha lasciato, su pressione dei sindacati, che fosse il Ministero del lavoro a gestire i flussi sulla base dell'effettiva domanda di manodopera. E' stato notato (Caviedes 2004) che nell'ultimo decennio l'atteggiamento dei sindacati europei sta cambiando e che ora chiedono, sempre più spesso, l'adozione di politiche liberali. Tale cambiamento si è verificato inizialmente nei paesi del mediterraneo dove i sindacati, preso atto dell'impossibilità per i governi di fermare i flussi migratori, spingono per la regolarizzazione dei migranti e per il loro inquadramento entro il sistema di sicurezza sociale (Caviedes 2004). Essi preferiscono la presenza di lavoratori immigrati regolari rispetto agli irregolari i quali, fornendo una manodopera a costi bassi, finiscono per danneggiare in misura maggiore i lavoratori nazionali. Recentemente anche in paesi storici d'immigrazione come la Germania, l'Olanda e l'Austria, i sindacati nei casi in cui riconoscono che c'è un calo di manodopera in alcuni settori dell'industria, favoriscono l'adozione di provvedimenti normativi volti a favorire l'ingresso di manodopera straniera.
Possiamo a questo punto rispondere alla domanda iniziale sulle ragioni per cui gli Stati continuano a conservare un alto livello di autonomia nella definizione delle proprie politiche d'immigrazione. E' evidente che l'immigrazione è un terreno di contrattazione del consenso politico troppo importante perché i governi nazionali lo deleghino all'Unione Europea. Le politiche europee dell'immigrazione, grazie al loro ambiguo status che le vede essere da una parte repressive e dall'altra liberali, costituiscono, infatti, una soluzione politica ottimale che sintetizza sia le esigenze economiche di crescita che quelle di conservazione del consenso politico. Da una parte, infatti, l'economia europea trae enormi benefici dalla presenza di una forza lavoro immigrata a basso costo, con la quale si sopperisce alla carenza di manodopera determinata dalla crisi demografica. Dall'altra i governi, per evitare di perdere il consenso politico di quella parte di elettorato che percepisce l'immigrazione come fattore di sostituzione nella ridistribuzione della ricchezza, adottano politiche repressive che mantengono i migranti ai margini del welfare e conservano i privilegi degli attuali beneficiari del welfare.
6. I costi reali dell'immigrazione sul welfare
Nel precedente paragrafo abbiamo illustrato la tendenza degli Stati europei ad adottare politiche che in vari modi limitano l'accesso al welfare dei migranti. Tali politiche sono finalizzate ad evitare che si creino meccanismi di dipendenza dal welfare per i migranti soprattutto nel caso dei low skilled workers. La storia cinquantennale del welfare europeo ha mostrato che la tendenza alla dipendenza dal welfare è, infatti, particolarmente presente proprio in tale categoria di lavoratori. La tendenza ad adottare politiche che evitino tale fenomeno è stata mutuata dal welfare liberale anglosassone, nel quale già negli anni '80, si sono tagliati i programmi sociali destinati alle categorie con una maggiore propensione a dipendere dal welfare. E' importante capire se i migranti abbiano effettivamente mostrato tale propensione, perché alla base delle politiche descritte nel paragrafo precedente vi è anche l'idea che i migranti e le loro famiglie possano finire per adagiarsi sui benefici del welfare in maniera ancora più forte dei nativi.
Borjas (1998) in uno studio sugli USA mostra che gli utenti del welfare immigrati tendono a concentrarsi negli Stati che concedono più benefici, la generosità del welfare agirebbe, dunque, come un magnete. E' stato di recente condotto uno studio il quale mostra che la dipendenza tra generosità del welfare ed immigrazione in Europa non è poi così evidente. Brücker et al.(2001) mostrano come la scelta del paese europeo di destinazione per i migranti dipende da un complesso di fattori nei quali la generosità del welfare è solo uno dei tanti elementi di valutazione. Un ruolo essenziale è svolto, infatti, dalla mediazione delle reti migratorie rappresentate dai connazionali che sono già emigrati. Inoltre, le valutazioni del migrante nella scelta del paese dipendono più spesso dalle possibilità che egli ritiene di avere nell'inserirsi nel mercato del lavoro che non dalla possibilità di accedere al welfare. La presenza, ad esempio, di alti tassi di disoccupazione involontaria disincentiva l'immigrazione a prescindere da quanto sia generoso il sistema di welfare del paese in questione.
Sulla base dei dati forniti dal European Community Household Panel su un numero selezionato di Stati UE risulta che vi è una sproporzione nell'accesso al welfare di cittadini non comunitari rispetto ai nativi solo in Danimarca, Olanda, Belgio, Francia, Austria e Finlandia, mentre in Germania, Gran Bretagna, Grecia, Spagna e Portogallo gli stranieri accedono ai benefici sociali proporzionalmente in misura eguale ai nativi (tabella 2). Discorso a parte meritano le pensioni di anzianità, nei quali la sproporzione è tutta a vantaggio degli europei e si spiega con il fatto che gli stranieri sono molto più giovani. La differenza, invece, nei sussidi per le famiglie si spiega con il fatto che gli stranieri hanno in media molti più figli degli europei. Il fatto che in alcuni paesi i migranti mostrino una maggiore propensione alla dipendenza da welfare è compensato, in termini di costi complessivi, dal fatto che gli stranieri a parità di lavoro svolto guadagnano meno rispetto ai cittadini europei (tabella 3).
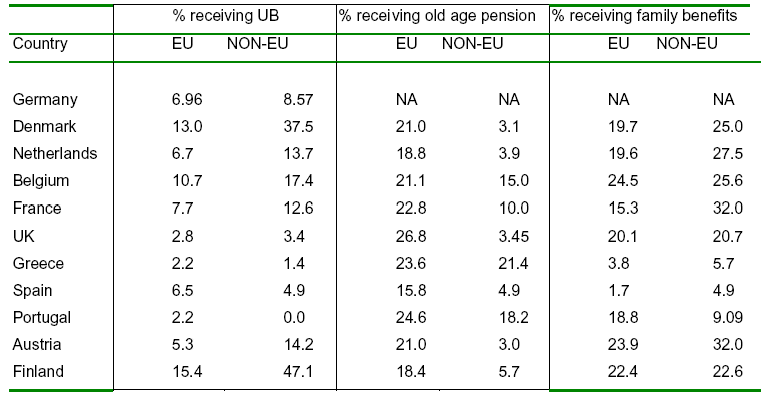
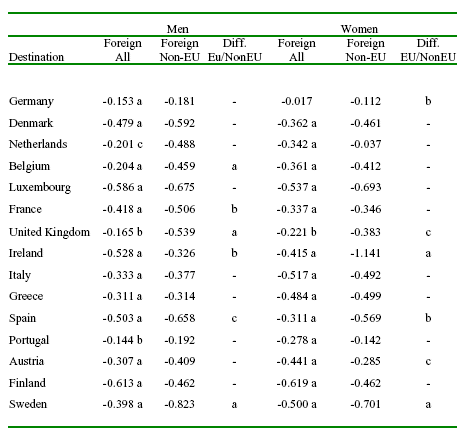
I dati dell'European Community Household Panel mostrano che la dipendenza dei migranti dal welfare è maggiore nei paesi che hanno programmi di disoccupazione più generosi, come Olanda e Danimarca, e che quindi essi rappresentano effettivamente un costo importante per questi sistemi di welfare. Il motivo per cui tale fenomeno si verifica non dipende solo dalla generosità di tali sistemi, ma anche dalle caratteristiche dei migranti stessi. Brucker et al. (2001) mostrano, infatti, che in questi paesi i migranti sono in possesso di un capitale umano medio e di una capacità di produrre reddito inferiore a quelli posseduti dai migranti dei paesi in cui c'è una minore propensione alla dipendenza da welfare.
Vi è, però, un altro dato da valutare che compensa i costi dell'iper-rappresentazione dei migranti nei programmi di disoccupazione e sostegno alle famiglie. I migranti al momento pesano pochissimo sui sistemi pensionistici che, ricordiamo, costituiscono la parte decisamente più rilevante della spesa sociale e che rappresentano il 15% circa delle entrate complessive dei cittadini europei. I contributi previdenziali versati dai migranti sono una risorsa essenziale per mantenere in saldo positivo l'erogazione delle pensioni dei cittadini europei (Brücker et al. 2001)
In conclusione si può sostenere che, se è vero che il welfare agisce come un magnete nei sistemi che dispensano benefici più generosi nei quali abbiamo visto che i migranti mostrano una propensione alla dipendenza maggiore dei nativi, è anche vero che tale fatto è compensato in termini puramente economici dai contributi previdenziale che, a partire dagli anni '90, hanno iniziato ad avere un ruolo sempre maggiore nel mantenimento dei nostri sistemi pensionistici (Brücker et al.1001), e dal fatto che gli immigrati percepiscono, a parità di mansioni lavorative e di capacità, redditi inferiori rispetto ai lavoratori europei. Nonostante, ciò, gli Stati Europei tendono a porre ostacoli all'accesso alla sicurezza sociale ai lavoratori stranieri, configurando per loro uno status di cittadinanza sociale minore.
7. Conclusioni
Esistono delle analogie tra il trattamento riservato alle minoranze negli USA e le pratiche con cui si realizza l'esclusione dei migranti in Europa. In entrambi i casi, infatti, le minoranze subiscono politiche che le tengono ai margini del welfare e le rendono più facilmente oggetto di forme di controllo meramente repressive. Esistono, però, delle differenze rilevanti tra le politiche europee e statunitensi. Negli USA la deriva securitaria dello Stato assistenziale si è basata sui discorsi neo-cons di riprovazione morale della povertà e della dipendenza dagli aiuti pubblici. In Europa, invece, il fenomeno della dipendenza dei migranti dal welfare è si presente, ma non così diffusamente, dal momento che è limitato ad un gruppo ristretto di Stati che offrono le prestazioni sociali più generose. Il combinato disposto delle politiche sociali e d'immigrazione europee non è finalizzato, come le riforme del welfare statunitense, ad eliminare privilegi acquisiti e forme di dipendenza dall'aiuto pubblico, piuttosto cerca di impedire che si creino fenomeni di questo genere. Possiamo dunque affermare che mentre nel caso degli USA la convergenza tra politiche sociali e penali si è determinata per rimuovere protezioni sociali, in quello Europeo essa agisce per mantenere il loro status quo.
Diverso è anche il ruolo che le politiche penali esercitano nel mercato del lavoro. Come abbiamo visto nel capitolo 2 le politiche d'incarcerazione di massa adottate negli USA, nascondendo un quota consistente di disoccupati, finiscono per contenere le eccedenze dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In Europa, invece, non vi è alcuna relazione significativa tra detenzione e tasso di disoccupazione che possa consentire di fare un'analoga considerazione. Il ruolo delle politiche penali nel mercato del lavoro europeo è, come abbiamo spiegato nel capitolo 3, quello di regolare l'ingresso nel mercato dei lavoratori stranieri selezionando quelli che mostrano di riuscire con le proprie forze ad inserirsi (Santoro 2006).
Resta un ultimo aspetto su cui soffermarci. Abbiamo visto che negli USA la saldatura tra politiche penali e sociali si è pienamente realizzata con l'adozione delle misure denominate denial of social benefis. In Europa la situazione sotto questo aspetto appare estremamente diversa, visto che la gran parte degli Stati membri continuano a permettere che i detenuti e le loro famiglie accedano ai benefici sociali. In Italia, Spagna e Germania, ad esempio, i detenuti continuano a beneficiare, qualora abbiano i requisiti previsti dalle rispettive leggi, del sussidio di disoccupazione. La sola Francia impedisce, dopo il sessantesimo giorno di detenzione, di poterne beneficiare, mentre non pone limitazioni per le altre forme di assistenza sociale. La tendenza europea a non prevedere limiti espliciti all'accesso al welfare ai detenuti si spiega anche con la presenza di una serie di norme internazionali che li renderebbero illegittimi. Già nel 1962 la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 185 su Electoral, civil and social rights of prisoners, al punto D affermava, infatti, che i detenuti e le loro famiglie non perdono, a seguito della condanna, il diritto ai benefici sociali acquisiti prima o maturati durante la detenzione. L'articolo 70 delle European prison rules del 1987 (Consiglio d'Europa) affermò successivamente che si devono salvaguardare il diritto alla sicurezza sociale e ai benefici sociali dei detenuti. L'aggiornamento del 2006 alle European prison rules del 2006 all'articolo 26 ha confermano che «As far as possible, prisoners who work shall be included in national social security systems» (Consiglio d'Europa 2006c). Le normative nazionali, salvo rare eccezioni come quella francese, permettono di accedere ai benefici sociali anche ai detenuti, ma solo qualora abbiano i requisiti previsti. Tale equiparazione tra detenuti e liberi cittadini, non tiene conto del fatto che nei sistemi penitenziari europei non sempre è garantito l'accesso al lavoro e, di conseguenza, a quelle forme di assistenza sociale che sono collegate allo svolgimento di una attività lavorativa. Non va poi dimenticato il fatto che in alcuni Stati europei il lavoro in carcere non comporta il versamento dei contributi previdenziali e che, quindi, non sempre è garantito il diritto alla pensione. E' il caso dell'Austria che, pur prendendo in considerazione il periodo trascorso in carcere ai fini del computo della disoccupazione e dei relativi benefici, non richiede il versamento dei contributi previdenziali per il lavoro in carcere che, di conseguenza, non viene considerato ai fini del conseguimento della pensione di anzianità. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha di recente considerato ammissibile il ricorso presentato da un detenuto austriaco il quale, sulla base della legislazione nazionale, si era visto respingere il riconoscimento dell'anzianità ai fini pensionistici per il periodo di lavoro trascorso in carcere. (14)
La situazione dei detenuti stranieri non comunitari rispetto all'accesso ai benefici sociali è, invece, contraddittoria. Essi, anche se clandestini, possono godere di quei benefici per i quali le legislazioni nazionali richiedono un permesso di soggiorno temporaneo, mentre non possono accedere agli altri benefici per i quali è richiesto un permesso a tempo indeterminato. L'elemento paradossale è rappresentato dal fatto che la detenzione attribuisce uno status giuridico agli stranieri irregolari che gli permette di accedere, per il periodo in cui sono reclusi, ad alcuni benefici sociali di cui da liberi non potrebbero in alcun modo godere.
Proviamo, invece, a domandarci cosa accade quando la condanna penale non colpisce uno straniero clandestino ma un regolare. In questo caso durante la detenzione egli continua a godere dei benefici sociali acquisti prima o maturati dopo la detenzione, ma al termine del periodo di detenzione, rischia di perdere a causa della condanna penale il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno e, di conseguenza, di perdere anche ogni possibilità di accesso al welfare. Sotto questo aspetto la politica europea presenta delle analogie con quella dei denial of social benefits adottata negli USA. Nel sistema americano, però, l'esclusione dai benefici sociali è esplicitamente prevista dalla legge per tutti coloro i quali ricevono una condanna, a prescindere dal fatto che siano o meno statunitensi, e scatta automaticamente dal giorno stesso in cui la condanna diventa definitiva. In Europa, invece, l'esclusione colpisce solo gli stranieri regolari condannati ed inizia ad avere effetto, non dal momento della condanna, ma dalla fine dell'esecuzione nel caso in cui venga disposta la revoca del titolo di soggiorno. Negli ordinamenti europei, infatti, la revoca del permesso di soggiorno non scatta automaticamente con la condanna (15), ma sono previsti dei meccanismi più articolati. Vediamone alcuni esempi.
Nell'ordinamento italiano è previsto che lo straniero condannato per un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio subisca la revoca del permesso di soggiorno e possa essere espulso. L'espulsione dal territorio dello Stato non è automatica per i titolari di permesso di soggiorno CE (16), i quali possono essere espulsi solo per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza (art. 9 T.U. 191/1998), se sotto procedimento o condannati per terrorismo (art. 3 legge 155/2005), e tenuto conto di una serie di elementi, quali l'età dell'interessato, le possibili conseguenze sulla sua famiglia e della presenza di legami familiari sul territorio (art. 9 T.U. 191/1998). Nel caso dei titolari permesso di soggiorno a tempo determinato si può tener conto, per evitare l'espulsione, della durata della permanenza sul territorio e dell'eventuale esistenza di vincoli familiari nel paese ospitante e in quello d'origine (art 13 comma 2bis T.U. 191/1998). L'avere un parente cittadino italiano è, poi, condizione di inespellibilità del migrante che ha subito una condanna penale. La legge svedese sull'immigrazione (Utlänningslagen 1989:529), invece, prevede che a uno straniero possa essere revocato il permesso di soggiorno e disposta l'espulsione nel caso in cui venga condannato per un crimine punibile con la detenzione o l'affidamento in prova. Esistono a questa regola diverse eccezioni, la prima è quella dell'inespellibilità dello straniero che sia residente in Svezia da prima che compisse i 15 anni d'età. La seconda riguarda gli stranieri che sono stati titolari di permesso di soggiorno CE per almeno 4 anni oppure sono stati domiciliati regolarmente in Svezia per almeno 5 anni: in questi casi l'espulsione può avvenire solo se lo straniero è ritenuto particolarmente pericoloso. Nel sistema tedesco, invece, l'espulsione è automatica solo se lo straniero è condannato per terrorismo o se incita alla commissione di atti di terrorismo. Nel caso di condanna per un reato comune il sistema è più articolato. L'espulsione è facoltativa e dipende dalla pericolosità presunta nel caso di condanna sotto i tre anni, mentre è obbligatoria sopra i tre anni (Sez. 53-54-55 Hereinafter Residence Act). A questa regola sono poi previste delle eccezioni che riguardano: i titolari di permesso di soggiorno CE che abbiano vissuto per almeno cinque anni in Germania, coloro i quali abbiano legami familiari in Germania e, infine, coloro i quali sono entrati e hanno risieduto legalmente in Germania da minori (Sez. 56 Hereinafter Residence Act).
Le analogie tra il sistema americano di denial of social benefits ai condannati e quello europeo di revoca del titolo di soggiorno agli stranieri condannati, non sono tali da poterci far sostenere che in Europa esiste una saldatura formale tra le politiche penali e quelle di esclusione dei migranti dal welfare. Nel sistema statunitense l'esclusione dal welfare è, infatti, prevista esplicitamente, mentre in quello europeo è solo una probabile ed indiretta conseguenza della condanna penale. Anche se, va riconosciuto, che hanno in comune la medesima selettività. Nel sistema americano l'esclusione dal welfare, riguardando solo i benefici del welfare assistenziale, finisce per colpire prevalentemente le minoranze etniche. Allo stesso modo, nel sistema europeo l'esclusione dal welfare riguarda solo i cittadini non comunitari.
Abbiamo analizzato le differenze delle politiche penali e sociali di controllo delle minoranze di USA ed Europa. Abbiamo evidenziato che quelle americane si inseriscono in un contesto più generale di riduzione dello stato assistenziale e rafforzamento del controllo penale della marginalità sociale, mentre quelle europee hanno la duplice ratio di difesa dei privilegi dei nazionali e di riduzione del costo dell'immigrazione sul welfare. Abbiamo, poi, evidenziato le differenze del ruolo svolto dalle politiche penali nel mercato del lavoro. Ci siamo, infine, soffermati sul fatto che negli USA, grazie ai provvedimenti legislativi riconducibili alla politica del denial of social benefits, si è avuta un saldatura formale tra politiche penali e sociali, mentre in Europa l'esclusione dei benefici sociali per i condannati non è esplicita ma è un fenomeno riconducibile ad un complesso di fattori strutturali.
Restano da fare alcune considerazioni conclusive sulla diversificazione delle strategie della governamentalità di gestione dei cittadini europei rispetto a quelle di controllo dei migranti. Il fatto che nel welfare europeo non esista quella differenziazione tra utenza dei programmi assistenziali e di altri programmi che negli USA ha consentito la deriva securitaria delle politiche sociali, non esclude, però, che non vi siano segnali di cambiamento in tal senso. Nel capitolo precedente quando abbiamo affrontato il tema dell'impatto dell'immigrazione sul welfare, abbiamo evidenziato che la presenza sempre più consistente di immigrati con basso capitale umano sta non soltanto diminuendo la redistribuzione fiscale a favore degli strati più bassi della popolazione, ma sta anche concorrendo, insieme alla deregolamentazione del mercato del lavoro, ad una contrattazione a ribasso dei livelli di protezione sociale per questi stessi strati. Le strategia di workfare europea di flexsecurity formalizzata nell'Agenda di Lisbona, infatti, pretendendo di residualizzare il ruolo dei benefici economici compensativi della disoccupazione in favore di quello svolto dal lifelong learning, non solo non sta portando i risultati promessi ma sta rendendo gli strati più bassi della popolazione sempre più dipendenti da programmi di welfare i quali, per la parte relativa ai means tested benefis, stanno diventando sempre più poveri. La strategia di flex-security aprirebbe, in tal modo, la strada per la creazione di un welfare povero anche per i poveri nazionali. Non va, però, neanche sopravvalutato il ruolo dei benefici a sostegno del reddito i quali, come abbiamo visto, costituiscono tutto sommato una quota minoritaria di quel complesso di programmi sociali che, dall'assistenza all'infanzia sino alle pensioni passando per l'istruzione, sono tuttora garantiti in maniera diffusa.
Mentre la creazione di un welfare duale come quello statunitense sembra essere solo un pericolo, per ora remoto, per le sorti cittadini europei poveri, esso è già una realtà per migranti. Essi sono vittime di una discriminazione che li porta a godere di forme di protezione sociale inferiori rispetto a quelle garantite ai cittadini europei. La loro esclusione non è mai esplicita ed completamente slegata da ogni riferimento alla razza o all'etnicità (Balibar 2000). Inoltre, essa non deriva dai limiti della cittadinanza sociale marshalliana, come abbiamo già detto, gli Stati europei si sono muniti di una serie articolata di normative che riconoscono una serie di status diversi da quello di cittadinanza (richiedente asilo, lavoratore temporaneo, lavoratore a tempo indeterminato e rifugiato politico) cui corrispondono diversi livelli di inclusione entro il sistema di protezione sociale. E' evidente, dunque, che per lo stato sociale europeo post-keynesiano il salario percepito dai migranti non ha lo stesso valore di quello percepito dai cittadini. Per questi ultimi comporta ancora la possibilità d'inclusione entro quel tipo governamentale del welfare tradizionale, nel quale ai diritti corrispondono doveri, al lavoro seguono i benefici sociali. La governamentalità neo-liberale, infatti, non si è mai del tutto sostituita per i cittadini a quella del welfare tradizionale, ma ha fatto presa, tramite le politiche di flex-security, sui settori della popolazione economicamente più deboli. Ai migranti, invece, si applica la governamentalità neo-liberale nella sua forma più spietata, quella dell'auto-imprenditorialità e della gestione individuale dei rischi. Non solo il migrante deve far conto solo sul proprio capitale umano e sociale per inserirsi nel mercato del lavoro, iniziando quasi sempre il suo percorso dalla clandestinità e passando sotto le forche caudine del controllo penale. Una volta che si è inserito, inizia un percorso di emancipazione a tappe, a ognuna delle quali corrisponde uno status legale differente che comporta nuovi doveri e nuovi diritti. Egli resta, comunque, in una condizione estremamente precaria ed insicura in cui rischi sociali comuni alla carriera di qualsiasi lavoratore, come la disoccupazione involontaria, possono produrre conseguenze ben più gravi di quelle che subiscono i cittadini: si può ritornare, infatti, in qualsiasi momento al punto di partenza ed essere privati dello status che con tanta fatica si era conquistato. Il lavoratore immigrato viene in tal modo tenuto ai margini del welfare e sottoposto a continui esami che ne possono mettere in discussione le certezze raggiunte.
Gli stessi programmi di formazione, che dovrebbero servire ad accrescere le competenze dei lavoratori e a favorirne la capacità di competere sul mercato del lavoro, hanno per i migranti un significato diverso. Nel primo capitolo abbiamo evidenziato che l'FSE sin dagli anni '70 ha previsto misure specifiche per i migranti i quali, nella programmazione degli interventi, venivano di volta in volta accostati ai disabili, ai tossicodipendenti o ad altre categorie marginali come i giovani disoccupati delle aree rurali. Questo comporta che i migranti vengano trattati come soggetti marginali dotati di un capitale umano inferiore alla norma e ai quali si riservano, di conseguenza, tipologie di lavoro per le quali sono richieste basse qualifiche e che danno accesso a tutele sociali limitate. Non si tratta solo di una tendenza delle politiche dell'UE in materia di formazione, ma vi è un tendenza diffusa in Europa a diversificare gli interventi sociali a favore dei migranti riservando loro programmi sociali dotati di meno risorse di quelli previsti per i nazionali. La gran parte dei paesi europei, infatti, adottando politiche restrittive e trattando l'immigrazione in termini emergenziali, costringono i migranti ad entrare in Europa illegalmente e predispongono, pertanto, programmi sociali meramente assistenziali che coprono solo la prima accoglienza dei clandestini, nella migliore delle ipotesi lasciandone la gestione ad associazioni del privato sociale. Questo ha portato alla nascita di tipologie assistenziali assimilabili a quello che Sennett (2003) definiva welfare povero per i poveri, che non risolve la povertà ma la riproduce dal momento che si limita a creare di forme di dipendenza stigmatizzanti.
Emerge, dunque, una differenza sostanziale tra il modo con cui la governamentalità neo-liberale fa presa sui cittadini e sui migranti. Nel caso dei cittadini europei abbiamo visto che essa si è affiancata a quella progressista del welfare tradizionale - il quale continua a garantire la normalizzazione attraverso l'erogazione di servizi garantiti universalmente a tutti i cittadini - e ha agito indebolendo quei programmi assistenziali riservati ai lavoratori più deboli e introducendo, attraverso le nuove politiche sul lavoro attive e la retorica del lifelong learning, un nuovo dispositivo di normalizzazione della disoccupazione.
La biopolitica neoliberale sui migranti opera in maniera differente, nonostante essa si basi sulla medesima retorica della gestione individuale dei rischi utilizzata per i cittadini. Quello che differenzia la posizione dei migranti è che alla base del sistema piramidale di inclusione entro il welfare è operativo un dispositivo di selezione che non funziona con le strategie della biopolitica (Santoro 2008). Quest'ultima, infatti, normalmente agisce stimolando l'individuo a migliorare il proprio capitale umano e fornendo i servizi e beni adeguati a formare cittadini utili e normalizzati. Nei confronti dei migranti, invece, si offrono servizi di welfare stigmatizzanti e si opera, mediante il diritto penale, una scrematura iniziale tra quelli che si dimostrano capaci di d'inserirsi con le proprie forze e quelli che, invece, violano le regole.
Note
1. Ci riferiamo alla direttiva approvata dalla Commissione Europea a febbraio 2004 nota come direttiva Bolkestein. Nella sua versione originale stabiliva il principio della libera circolazione dei servizi entro l'UE. La direttiva è stata al centro di polemiche e di un importante dibattito politico su due punti particolarmente controversi. Il primo era quello dell'introduzione della regola del paese d'origine, in base alla quale un prestatore di servizi che si sposta in un altro paese europeo avrebbe potuto rispettare la legge del proprio paese di origine. L'altro era quello della liberalizzazione dei servizi pubblici, tra cui quello sanitario. La direttiva è stata formalmente approvata nel 2006 (GU 2006/123/CE) e nella sua versione finale ha escluso che la liberalizzazione riguardasse i servizi pubblici d'interesse generale come quello sanitario e ha sostituito il principio del paese d'origine con quello del riconoscimento reciproco. Evelyne Gebhardt (deputata tedesca del Partito Socialista Europeo) nella sua relazione conclusiva presentata alla commissione parlamentare il 19 aprile del 2005 ha sottolineato le modifiche sono state rese necessarie per la salvaguardia del modello sociale europeo.
2. Negli USA la condanna penale può essere causa della perdita temporanea o permanente del diritto di voto (Travis 2002). Si calcola che siano oltre 4 i milioni di persone che sono state private di tale diritto.
3. Esso è riconosciuto come un diritto soggettivo inalienabile dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
4. Il diritto all'assistenza sanitaria agli immigrati anche se illegali e ai loro figli è riconosciuta dall'articolo 19 della Carta dei Diritti Sociali (Strasbrurgo, 3 maggio 1996), come è confermato dall'interpretazione fornita dal European Comittee of Social Rights (2006).
5. La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia all'articolo 28 stabilisce che gli Stati devono offrire a tutti i minori il diritto all'educazione.
6. La direttiva 9/2003 del Consiglio Europeo stabilisce che gli Stati possono stabilire un periodo dalla presentazione della domanda in cui i richiedenti asilo non hanno la possibilità di lavorare, se entro 1 anno non è stata presa una decisione sulla richiesta di asilo gli Stati devono concedere l'accesso al lavoro. La direttiva prevede che nel periodo in cui il richiedente asilo non ha la possibilità di lavorare vengano comunque garantire le condizioni minime di sostentamento materiale e venga garantita l'assistenza sanitaria, l'accesso alla formazione professionale e il diritto all'istruzione ai minori. I richiedenti asilo sono esclusi, nel periodo iniziale, dall'accesso a tutti i benefici dipendenti dallo svolgimento di una attività lavorativa.
7. Cfr. p. 31.
8. Denominato permesso di soggiorno CE.
9. Per definizione di assistenza sociale e la sua distinzione da quella di sicurezza sociale, rimandiamo al Capitolo 1, § 4.2.
10. Per la definizione di questi benefici rimandiamo al Capitolo 3, §3.
11. Nel caso sottoposto alla Corte vi era stata una revoca della pensione di invalidità a uno straniero a seguito dell'entrata in vigore della legge 288/2000 la quale, al contrario della precedente normativa, prevedeva il requisito della titolarità del permesso di soggiorno CE.
12. Sentenza 324 del 2006.
13. Gli Stati considerati sono: Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Svezia.
14. European Court of Human Rights, Application no. 37452/02 by Ernst Walter STUMMER against Austria.
15. La Direttiva del Consiglio Europeo n. 109/2003 del Consiglio Europeo del 25 novembre 2003 intitolata Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, stabilisce in proposito che «i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave».
16. La Direttiva del Consiglio Europeo 109/2003 prevede che «Il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione».